EJGS Supplement no. 5, EJGS 5/2007
Archivio Manzotti – Le ragioni del dolore
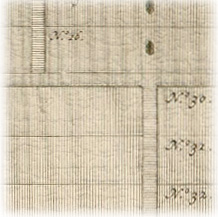 |
Una visita bibliografica
Giulio Ungarelli
Ho conosciuto dal vero pochi scrittori, ne ho dimenticato assai presto l’immagine, sovrastata dalle loro molte pagine. Perché? Erano così veri – nel senso del ruolo di scrittori – da essere falsi. Ho incontrato una sola volta Carlo Emilio Gadda, all’inizio dell’estate del 1963, nel suo volontario esilio romano in via Blumenstihl, alla Camilluccia. Non riesco a dimenticarlo. La sua immagine era così falsa da essere vera.
Salendo su per l’erta assolata che dal capolinea dell’autobus portava alla casa di Gadda – non erano ancora le quattro del pomeriggio di una precoce estate romana – temevo un po’ ingenuamente, lo confesso, di trovarmi di lì a poco di fronte a Don Gonzalo Pirobutirro, all’ira di Don Gonzalo (a leggere i libri con troppo entusiasmo a volte ci si fa certe idee). E mi sentivo, e qui non a torto, come un nipotino ignorante del colonnello Di Pascuale, destinato ad essere irosamente scacciato dall’ultimo discendente del governatore della Néa Keltiké. Né le cose migliorarono, quando, non avevo ancora tolto il dito dal pulsante del campanello, la porta, come avviene nei racconti del terrore, subito si dischiuse (l’appuntamento era per le quattro precise ed evidentemente Gadda mi attendeva dietro alla porta). Ma, aperto del tutto il battente, una grossa figura un po’ clownesca, ravvolta in un doppio petto di panno scuro, in completa antifrasi con il caldo pomeridiano, cravatta bordò, ed un volto spietatamente asimmetrico, mi rassicurarono: «Non è Don Gonzalo» – mi venne fatto di pensare – «è Jacques Tati». Poi, il rituale dei suoi convenevoli, degli inchini, di gentilezze portate allo stremo, che si risolvevano inevitabilmente in gesti di involontaria quanto perfetta comicità, mi esonerarono dal disagio di essere senza cravatta e col colletto della camicia slacciato, e tolsi così la mano già posta vergognosamente a difesa della gola scoperta.
Questo il prologo. Il dialogo avvenne in una stanza adibita a studio, dietro ad un tavolone ordinato, ben sgombro, lui seduto da una parte su una specie di seggiolone, io dalla parte opposta. Davanti a ciascuno di noi dei fogli di carta candida, perfettamente squadrati; dalla sua parte c’era anche una matita esattamente allineata. Aveva proprio pensato a tutto.
«Faccia le domande, la prego, chieda pure» – iniziò timidamente, quasi temesse l’eco sproporzionata delle sue parole – «e poi» (qui però più deciso) «può scrivere, dire di me quello che vuole, lei è assolutamente libero».
Ma che cosa mai avrei potuto dire di lui, ero venuto per delle faccende bibliografiche, e lo sapeva benissimo, come conosceva – ne era stato edotto in precedenza e minuziosamente da altri, dietro ovviamente sua richiesta – il mio stato anagrafico, età, professione, luogo di nascita, ecc.
Si era a quel punto che le cose non vanno né avanti, né indietro. Sembrava un esame, soltanto che non si riusciva a capire chi era l’esaminato e chi l’esaminatore, e nel silenzio i ruoli si scambiavano simultaneamente creando una notevole, imbarazzante confusione. Risolsi, per rompere il cerchio, di essere io l’esaminato.
Ed allora Gadda si ravvivò: l’intrico delle domande e delle ipotetiche risposte, delle domande che diventavano risposte e viceversa, lo interessò subito, ma senza alcuna intenzione inquisitoria, solo per il gusto di sapere, di conoscere tutti gli infiniti aspetti, le infinite possibilità, vere, verosimili, presunte, che la cosa in sé poteva offrire. Credo addirittura che in certo modo non ascoltasse neppure le mie risposte.
Perché volevo raccogliere una bibliografia su di lui? Non aveva senso, poi lui non si ricordava. Sì, qualcuno aveva scritto sui suoi libri, critici bravissimi, non giornalisti, s’intende, dovevo informarmi da Bonsanti, a Firenze. Bonsanti sapeva tutto. E poi perché lui, c’erano tanti altri scrittori, più celebri di lui, loro sì che raccoglievano tutto. No? Non si trattava di una bibliografia critica? Ah, di una bibliografia dei suoi scritti. Curioso, se ne facevano ancora? I suoi articoli? No, non li aveva tutti, anzi ne aveva pochissimi, era passato tanto tempo. I traslochi, Firenze, la guerra. Ma era proprio utile una bibliografia dei suoi scritti? E a che cosa mai poteva servire? Per un articolo di giornale, un ritratto, un profilo, un medaglione, un… (e qui la voce si incrinò, rimanendo soffocata, sospesa, come per terribili sospetti). No, non poteva essere (rassicurato). D’altronde, in un giornale non sapevano certo che farsene. Una bibliografia, la sua, poi.
Il caos esplorativo stava esaurendosi. Ancora un’ultima possibilità: doveva servire per una tesi? A questo punto la ridda delle sue ipotesi coagulò in un pensiero: fu questione di un attimo, una occhiata di stima ai miei anni – era evidente l’ormai trascorsa età canonica dei lauri dottorali – e il pensiero trionfalmente scoccò in Gadda, non detto, ma espresso con lo sguardo, press’a poco così: «Somaro». Poi quasi d’un subito, un sospiro di sollievo: no, non serviva per una tesi, voleva ben dire.
Adesso, esperite coscienziosamente le indagini, la cosa non lo riguardava più, se mai l’avesse veramente riguardato sin dall’inizio. E seguì l’offerta reiterata di qualcosa da bere. Nella stanza il caldo infieriva malgrado la penombra delle persiane socchiuse. Chiesi un bicchiere d’acqua che Gadda si premurò subito di portarmi, non senza prima scusarsi: «Sono solo». Naturalmente era tiepida. Attese che finissi di bere, e con un segno appena percettibile della mano mi avvisò che potevamo iniziare veramente a parlare di carte. E qui Gadda divenne dolcemente curioso della mia curiosità. Era come se ci intrattenessimo tutti e due su un altro scrittore. Nessuna finzione o affettato distacco, da parte sua, nessuna malizia o civetteria nascosta, no, era proprio così. Ed alle mie parole – quanto controllate, quanto ristrette ai soli fatti bibliografici, è facile immaginare, ma che pur talvolta si coloravano (involontariamente) di sfumature un po’ encomiastiche – non si schermiva, non tradiva la minima noia. Non ce n’era bisogno. Stavamo parlando proprio di un altro, non di lui, stavamo parlando dell’autore della Cognizione del dolore.
Mi accorsi allora che l’humour inarrestabile che promanava dalla sua figura, dai suoi gesti, che la sua spagnolesca, assurda gentilezza che metteva allegria, erano veri e falsi assieme, naturali e voluti, ma soprattutto autenticavano la sua esistenza, anche se povera, desolata, malata, di lui. Carlo Emilio Gadda, ingegnere (che scrittore era già cosa troppo complessa, da mettere da parte, da non menzionare in una onesta scheda anagrafica), nato a Milano, il 14 novembre 1893, ore 6, via Alessandro Manzoni numero 3, terzo piano, battezzato a San Fedele, cresimato a San Simpliciano, ecc.
Altro che Don Gonzalo, ad onta di tanti riconoscimenti autobiografici, false identificazioni, assurde presunzioni, sparsi per ogni dove in certa facile e purtroppo diffusa critica gaddiana.
Alla fine in quella stanza che sembrava un forno, c’ero rimasto soltanto io come personaggio, io nipotino ignorante del colonnello Di Pascuale. Ma incominciavo ad imparare la lezione e diventavo sempre meno nipotino. Anche Gadda se ne accorse e si alzò dal suo seggiolone, pregandomi di seguirlo nel corridoio, non cessando un istante di scusarsi, scusarsi del disordine, scusarsi della sporcizia (non c’era disordine, né sporcizia; desolazione, solitudine, sì). Entrammo nella sua camera, e qui con la mano fece un cenno buffo, stizzoso ed angoscioso, a scongiurarmi di non badare, di non guardare, per carità, in un angolo l’alto letto monoposto, di buon legno massello, stile Biedermeier anni ’20 dei mobilieri di Lissone, Seregno, Cantù, con due monumentali materassi, sotto quello di crine di «bel cavallone», sopra quello di lana. Si diresse verso un armadio dello stesso stile ed altrettanto massiccio, ne aprì gli sportelli, scostandosi subito per farmi vedere e col palmo aperto mi invitò, come a dire: «Se proprio vuole, si accomodi».
Devo confessarlo: adesso comico ero io, perché mi tuffai a capofitto – solo la consunta metafora corrente può descrivere degnamente la mia vana ed ingenua agitazione – dentro l’antro oscuro di quell’armadio. Non mi accorsi neanche che l’ordinata, grigia disposizione delle cose che regnava nella casa di Gadda, qui veniva contraddetta ed in modo stridente: dai piani dell’armadio fuoriuscivano arricciati giornali, riviste, opuscoli, libri, almanacchi, vecchi e nuovi, in una confusione polverosa ed ingiallita che suggeriva l’abbandono.
Rimasi un bel po’ con la testa infilata dentro l’armadio, a frugare, indiscreto. Gadda, per non disturbarmi, s’era ritirato nell’angolo opposto della stanza. Finalmente, recuperata la testa, mi volsi un momento a guardarlo: era sempre là, in piedi, le lunghe braccia abbandonate lungo il corpo, fermo come un coscritto, ma non immobile del tutto: scuoteva appena, appena il suo testone.
Riemersi, dopo la mia performance, stringendo un pugno di carte, con un’aria stupidamente trionfale. Rientrammo nello studio, io con la mia preda, lui con il suo modo fra l’assorto ed il rispettoso. Mentre disponevo sul tavolone la mia pesca che si rivelava ben poco abbondante – quelle carte in gran parte già le conoscevo per lunga frequentazione di biblioteche, emeroteche ed altre simili istituzioni – Gadda continuava lievemente a scuotere il capo. Poi, quasi dietro mio invito – s’erano insomma curiosamente invertite le parti e sembrava che il padrone di casa fossi io –, Gadda accondiscese a darvi un’occhiata. Ma il suo sguardo vagava fuori campo, come se non riuscisse a mettere a fuoco quei rettangoli dove l’inchiostro tipografico col tempo s’era ormai scolorito.
Eppure, s’intende, ce la metteva tutta, lui, la sua buona volontà a non contraddire quel matto che gli era capitato in casa, preso per sovrappiù da un curioso raptus: che quelle stampe, per il solo fatto che si trovassero in casa di uno scrittore, fossero diverse, più appetibili di quelle raccolte in severe ed ordinate collezioni e custodite, per la dovuta consultazione, nei luoghi dati allo studio ed alla riflessione. E per non eccitarlo ancor più – il matto, s’intende – lui, Gadda, pensò che fosse bene affettare interessamento, ma non ne usciva che meraviglia e stupore. Non era mica facile assecondare le manie di quel tipo che s’era sì presentato puntuale alle quattro, ma per una visita ch’era giusto, insomma, augurarsi un po’ più breve.
S’era intanto fatto tardi, e nella stanza si allungava l’ombra tenue, uniforme delle sere d’estate, ed una arietta fresca, fresca scendeva giù da Monte Mario a sgomberare il caldo dei muri; nelle finestre spalancate delle case vicine s’accendevano le lampadine gialle rischiaranti quieti interni intesi al riposo dopo una lunga, soffocante giornata.
Era proprio ora d’andare, la visita era durata fin troppo. E già nella mente di Gadda le sacre leggi dell’ospitalità venivano travolte da tormentosi pensieri: questo originale intendeva forse mettere le radici a casa sua? O magari autoinvitarsi a cena. Stava fresco. Tanto in casa non c’era nulla.
Gadda si alzò soffocando a stento un sospiro. Mi alzai anch’io.
Sulla porta ci promettemmo reciprocamente di rivederci. Non sarebbe accaduto, lo sapevamo (anch’io, finalmente, incominciavo a capire) entrambi benissimo, ed in quello stesso momento in cui ci scambiavamo frasi di rito, le sue incomparabilmente più fiorite delle mie. Eppure tutto questo non era un falso. Era un falso che nascondeva, anzi faceva vivere, ancora una volta gaddianamente, una verità: tutto quello che poteva e doveva insegnarmi in via Blumensthil lui, Gadda, me l’aveva insegnato, era inutile per me rifare la strada. Se la visita bibliografica s’era risolta in uno scacco – in quanto a numero di schede ero più o meno al punto di prima –, fatti miei. Lui, dal canto suo, ce l’aveva messa tutta, davvero tutta ad insegnarmi – ciò era ben più importante – come dovevo leggerle quelle schede, altrimenti che senso aveva raccoglierle? Perché in fondo quelle schede che altro erano se non libri, racconti, saggi, articoli di uno scrittore chiamato Carlo Emilio Gadda col quale lui c’entrava solo ai fini nominali. E poi, quando i libri si potevano trovare, che bisogno c’era per leggerli di andare dallo scrittore a chiederli. Ci sarebbe mancato altro. E se lo scrittore fosse morto, non lo si leggerebbe più?
Il ragionamento non faceva una grinza. Non rimaneva altro che salutarci: «Buonasera Gadda» e lui rispose con un impercettibile ma pur sempre cerimonioso inchino.
Discesi l’erta per andare a prendere l’autobus. Camminando rimuginavo le parole non dette ma ben eloquentemente espresse da Gadda, e in tutti i modi, con la sua clownesca figura, i suoi gesti buffi, la sua assurda gentilezza. Erano parole non facili a ricordare, nel senso di non dimenticarle all’occasione giusta. Mi accorsi, nel buio sopravvenuto, di parlare da solo. Ripetevo meccanicamente una frase come quando da ginnasiale recitavo in rime dialettali, fra me e me, una filastrocca per ricordarmi forme irregolari di verbi latini: la filastrocca raccontava press’a poco di dic duc fac fer che prendevano un coltello e se non c’erano fio fis ammazzavano volo vis. Soltanto che ora ripetevo molto più semplicemente: «Una cosa è l’uomo, una cosa lo scrittore, una cosa il personaggio». Chissà se la frase avrebbe funzionato, come alla fine nei lontani primi anni ginnasiali funzionò abbastanza bene la filastrocca.
Dieci anni dopo (Gadda è morto il 21 maggio 1973 a Roma) mi trovai con altri in Piazza del Popolo, davanti alla chiesa di Santa Maria del Popolo. Odio le riunioni dei letterati, forse solo per timidezza. Non amo i funerali, le cerimonie funebri, che invece piacevano tanto a Léautaud.
Quando posso le evito. Ma quella mattina assolata – era già estate, e il cielo alto e limpido sembrava ancora più alto, più limpido su di noi, giù, in una Roma accaldata, rumorosa, soffocata dai clackson e dai gas di scarico – avevo voluto, come si dice, salutare Carlo Emilio Gadda, quello che una volta avevo conosciuto, ormai avviato leggero verso il luogo del silenzio. Verso la Certosa. Appunto.
Università di RomaPublished by The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS)
ISSN 1476-9859
ISBN 1-904371-16-7
© 2007-2025 by Giulio Ungarelli & EJGS Manzotti Archive. First archived in EJGS (EJGS 5/2007), Supplement no. 5. Previously published in E. Manzotti (ed.), Le ragioni del dolore. Carlo Emilio Gadda 1893-1993 (Lugano: Edizioni Cenobio, 1993), 105-09.
Artwork © 2007-2025 by G. & F. Pedriali. Framed image: A Cabinet of Curiosities (Wunderkammern) – detail from an illustration in V. Levinus, Wondertooneel der natuur, tome II (1715), Strasbourg University.
The digitisation and editing of EJGS Supplement no. 5 were made possible thanks to the generous financial support of the School of Languages, Literatures and Cultures, University of Edinburgh.
All EJGS hyperlinks are the responsibility of the Chair of the Board of Editors.
EJGS is a member of CELJ, The Council of Editors of Learned Journals. EJGS may not be printed, forwarded, or otherwise distributed for any reasons other than personal use.
Dynamically-generated word count for this file is 2574 words, the equivalent of 8 pages in print.


