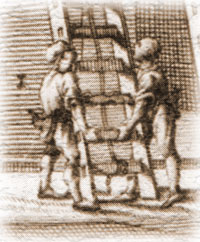 |
Dalle Meraviglie d’Italia a Verso la Certosa
Liliana Orlando
L’intera opera gaddiana è, per riprendere una felice metafora, «un complesso sistema a vasi comunicanti», (1) dove sovente accade che un scritto destinato a essere un tassello di un progetto originario, sia trasferito – rielaborato – da una pubblicazione a un’altra diversamente strutturata. Si può ben dire che tutte le pubblicazioni di Gadda siano il risultato di un assemblaggio di materiali già anticipati su quotidiani e o riviste.
Non sfuggono a questa regola Le meraviglie d’Italia (1939), Gli anni (1943), Verso la Certosa (1961), Le meraviglie d’Italia-Gli anni (1964), raccolte di prose giornalistiche che pur mantenendo, individualmente, la loro caratterizzazione peculiare sono correlate tra loro per la presenza di alcuni scritti che vengono riproposti a distanza di tempo.
Queste opere hanno avuto una elaborazione complessa, a volte con sorprendente deviazione rispetto all’impianto progettato, per l’interferenza di scelte diverse o di condizioni vincolanti. La ricostruzione dei passaggi è ora resa possibile dalla documentazione offerta dalle molte lettere gaddiane indirizzate a privati e agli editori, ormai in gran parte divulgate, e dai materiali di lavoro – appunti, annotazioni personali, bozze di stampa – conservati scrupolosamente da Gadda e poi affidati ad amici o collaboratori. (2)
Il problema che si è posto oggi all’editore è stato dunque quello di riconoscere e valorizzare la specificità di ogni singola raccolta, ricostruendone la storia interna. Va fin d’ora precisato che la realizzazione dell’ultimo segmento del percorso (Le meraviglie d’Italia-Gli anni 1964) non può a rigore essere considerata come superamento delle fasi di lavoro precedenti, e quindi volontà ultima dell’autore, perché risponde piuttosto alla necessità da parte di Gadda di assolvere ad impegni editoriali precedentemente presi – come dimostreremo – che a una vera esigenza di diversa rielaborazione. (3)
Le meraviglie d’Italia (1939)
Le meraviglie d’Italia, terzo libro di Gadda, esce, come i due precedenti La Madonna dei Filosofi e Il castello di Udine, dalla tipografia dei Fratelli Parenti di Firenze, quattordicesimo volume della collezione di Letteratura, la rivista fiorentina diretta da Alessandro Bonsanti. La data di stampa – il rituale scaramantico del numero propiziatorio appare con evidenza – è 14 luglio 1939. Si tratta di un’edizione a tiratura limitata (355 copie numerate, più 50 fuori commercio) preceduta da un ritratto dell’autore eseguito da Francesco Messina e dalla dedica alla memoria della madre.
Raccoglie scritti già apparsi su quotidiani e riviste (la gran parte dei quali pubblicati sulle terze pagine della Gazzetta del popolo di Torino e de L’Ambrosiano di Milano tra il 1934 e il 1938, due su Il Tesoretto e Corrente di vita giovanile nei primi mesi del ’39) e include un solo inedito. (4) Il volume si configura ripartito, per scelte tematiche, in quattro sezioni: la prima e più consistente raggruppa gli articoli milanesi, con la rassegna delle attività produttive, commerciali, finanziarie della città, con la rivisitazione di luoghi e avvenimenti cari alla memoria; la seconda raccoglie pagine nate dai ricordi del lavoro all’estero di Gadda ingegnere, in Argentina tra il 1922-24, e nella Lorena francese dopo il 1925. Segue poi un mannello compatto di sei servizi giornalistici ricavati da un viaggio in Abruzzo in veste di «inviato speciale» per conto della Gazzetta del popolo; l’ultima sezione offre uno spaccato del lavoro italiano degli anni trenta: dalle risaie della Lomellina, alle cave di marmo delle Alpi Apuane, alle miniere carbonifere dell’Istria.
Una raccolta così composita si fregia anche di un titolo, Le meraviglie d’Italia, dalle molteplici valenze, in cui si assommano dichiarata ammirazione, enfasi, ironia, e che evoca illustri precedenti, dai Mirabilia urbis Romae, medioevali guide ad uso dei pellegrini, al De magnalibus Mediolani del milanese Bonvesin da la Riva.
L’esito del volume corrisponde però solo in parte al progetto originario, che intendeva associare ai contributi di carattere giornalistico una significativa porzione narrativa; nel gennaio 1938 Gadda ne informava l’amico Bonaventura Tecchi e più dettagliatamente il cugino Piero Gadda Conti:
Io lavoricchio alle stampe del volume che comprenderà: 1) San Giorgio in casa Brocchi, 2) articoli milanesi (borsa, macello, mercato, ecc.), 3) viaggio in Abruzzi e a Buenos Aires, 4) La cognizione del dolore che devo ancora finire. (Gadda 1974c: 47-48)
Due racconti (il primo, San Giorgio in casa Brocchi, già apparso in Solaria nel giugno 1931, l’altro, La cognizione del dolore, senza dubbio una sezione, al momento ancora inedita, di quello che sarà il romanzo dal titolo omonimo) avrebbero dovuto dunque incorniciare una scelta di articoli giornalistici d’argomento chiaramente individuato, dai quali si profila già in questa fase embrionale la struttura delle future Meraviglie.
Supplementi di informazioni sono offerti da appunti autografi reperibili tra le carte gaddiane del Fondo Roscioni, con buona probabilità ascrivibili a questa fase cronologica; uno schema del lavoro (o piuttosto un indice del volume in cantiere) fornisce altresì il titolo dell’opera, ricavato dal racconto conclusivo:
La cognizione del dolore
I PARTE: San Giorgio in casa Brocchi
II PARTE: Le torri: mattino e tramonto
III PARTE: La filovia del Gran Sasso e altre meraviglie d’Italia. E d’America
IV PARTE: La cognizione del dolore
Sotto la sintetica allusività di Le torri: mattino e tramonto (con cui è circoscritto l’arco della giornata vigilata dalle torri, per antonomasia, del Castello Sforzesco di Milano) sono poi elencati i titoli, talora ancora provvisori, di molti brani che comporranno la sezione milanese della raccolta. Il contenuto della III Parte è specificato nei dettagli da un altro indice, la cui intestazione complessiva Le meraviglie d’Italia / Dal taccuino di un italiano si articola in tre sottotitoli (Dal taccuino di un italiano all’estero // Le meraviglie d’Italia // Lo verde piano, l’alpe di marmo, il carbone) corrispondenti alle ripartizioni in cui risultano raggruppati tutti gli articoli della seconda, terza, quarta sezione della raccolta definitiva.
La scelta del titolo assunto per il progettato volume è ribadita da un annuncio pubblicitario dell’uscita dell’opera (si legge in Letteratura, n. 5, gennaio 1938) accompagnato da uno scritto di mano d’autore che illustra, in tono grottesco, il carattere della raccolta che si va configurando e ne definisce la materia composita e tormentata:
La cognizione del dolore
«Double, double toil and trouble:
Fire burn: and cauldron bubble»
Una tensione magica sembra sostentar sulle fiamme il pentolone gaddiano dove ribollono, con parvenze inattese, creature e forme tuttavia venutegli da mondo. Così dalle forconate che l’autore di quando in quanto regala al suo lesso, taluno penserebbe a una cottura laboriosa, a una vana magia [...].
La soluzione adottata è però transitoria. Nei mesi successivi il racconto che Gadda stava elaborando acquista progressivamente spessore e autonomia, tanto da essere infine svincolato dalla progettata eterogenea struttura. È certo che nel luglio Gadda ha ormai differenziato due lavori in vista di una prossima pubblicazione: una raccolta di prose giornalistiche dal titolo Le meraviglie d’Italia (titolo già affiorato in sordina nel primo indice del volume) e il romanzo La cognizione del dolore. La nota pubblicitaria del fascicolo di Letteratura in cui appare la prima puntata del «romanzo» La cognizione del dolore (n. 7, luglio 1938) annuncia infatti l’imminente uscita di due volumi, presentando distinti per la prima volta i due titoli gaddiani in preparazione.
Il nuovo assetto dato alle Meraviglie implica l’esclusione dell’altro testo narrativo San Giorgio in casa Brocchi, mentre s’impone il potenziamento, nella scelta numerica, delle prose giornalistiche. Fedele all’impianto quadripartito dello schema originario, l’opera è arricchita nella sezione milanese dall’aggiunta di alcune prose, anche quando parte della composizione tipografica del volume è già avviata, (5) mentre la prevista aggregazione concentrata della III Parte si distribuisce nella seconda, terza e quarta sezione.
La complessità dell’operazione, che ha investito la scelta della struttura assegnata al libro, si estende anche alla revisione formale dei singoli testi nel travaso dal giornale al volume. La collazione dei materiali esistenti, agevolata dalla possibilità di consultare gli originali con le correzioni autografe, conservati nel Fondo Roscioni, (integrati dall’aggiunta di fogli manoscritti supplementari, e dalle bozze di stampa, a loro volta arricchite di nuovi interventi d’autore) documenta un lavoro soprattutto di integrazione o sostituzione (in pochi casi di riduzione) ma tale da non sconvolgere la compagine originaria dell’articolo. Le varianti sostitutive sono indirizzate quasi sempre ad accentuare le componenti espressive già presenti nel testo, potenziandone i tratti specifici. L’aspetto più vistoso dell’operazione è però rappresentato dall’aggiunta delle note in quasi tutte le prose. Talvolta rigorosissime nella loro precisione tecnica e scientifica, ma molto più spesso occasione di controcanto al testo, le note vengono a rivestire la funzione di un osservatorio privilegiato che consente allo scrittore di prendere le distanze, con toni a volte ironici e umoristici, dalla pagina a fronte. Le riduzioni drastiche, per altro limitate, riguardano quasi esclusivamente la retorica celebrativa del regime fascista che interessa, nell’ultima sezione del libro, alcune prose compromesse nel magnificare le opere del regime e il «lavoro italiano».
Gli anni (1943)
Sono ancora gli editori Parenti di Firenze ad allestire la stampa della quarta pubblicazione in volume di Gadda, Gli anni, che reca nel colophon la data, con l’abituale compiacimento scaramantico, del 14 maggio 1943. Primo (e ultimo) di una progettata serie di opere di diversi autori da stamparsi per la collezione di Letteratura in numero limitato di esemplari su carta a mano con disegni, litografie, acqueforti di artisti famosi, il volume gaddiano appare in una raffinata veste editoriale, impreziosita da tre disegni originali di Filippo De Pisis. L’esiguità della tiratura, duecento copie, ne accentua il carattere di opera privata.
La pubblicazione annovera dieci testi, perlopiù brevi poèmes en prose di registro lirico-elegiaco. Il ricordo dell’infanzia, i luoghi delle proprie radici, l’esperienza del lavoro nelle sue implicazioni di ingegnosità e perizia tecnica, di fatica e di sofferta moralità, ne sono i temi dominanti. Il tempo e le opere è dunque il motivo conduttore della raccolta: nel segno di una dolente ricognizione nel tempo è allora da ricondursi il titolo Gli anni, la cui lapidaria allusività è resa esplicita dal breve testo di Gadda che in Letteratura (n. 25, 1943) accompagna l’annuncio pubblicitario del volume:
…gli anni, cioè alcuni momenti della fatica del dolore e della conoscenza registrati in una parodia che si leva dal tempo e dalle opere. Non sempre vestite di facilità, queste «liriche in prosa» del famigerato calligrafo sono un riflesso del vivere contro i suoi cieli piuttosto cupi…
Nove delle dieci prose che compongono l’opera erano già apparse su riviste e quotidiani tra il 1936 e il 1941; inedita una sola prosa. Non è tuttavia possibile dimostrare, dalla documentazione limitata di cui ci si può valere, come venisse allestita questa raccolta, quali operazioni di selezione e di esclusione si fossero avvicendate a definirne la fisionomia. Si tratta per certo dell’esito di un progetto editoriale concepito in origine in forma diversa: infatti nell’estate del ’42 Gadda aderisce all’invito di inaugurare con una sua opera la nuova serie di pubblicazioni di pregio per la collezione di Letteratura, ma esita a concedere, come avrebbe voluto l’amico Bonsanti, la riedizione del Castello di Udine (uscito nel ’34 nelle edizioni di Solaria) perché legato da un precedente impegno editoriale con Bompiani; svincolato dal quale, e presi già alcuni contatti con De Pisis, finì invece con l’offrire la ristampa del Castello a Einaudi, per soddisfare alla richiesta dell’editore torinese di annoverare un’opera gaddiana nel proprio catalogo: ma il progetto, avviato, si arrestò dopo pochi mesi. (6)
Alla organizzazione dei materiali per Gli anni, e quindi alla revisione delle pagine dei giornali, si volse verso gli ultimi mesi del ’42. Il lavoro fu completato in tempi relativamente brevi (il volume uscì nel luglio ’43, come confermano diverse lettere sconfessando la data ufficiale) con la consueta composizione tipografica a tappe successive. Le bozze provenienti dall’Archivio Garzanti (si tratta di ben quattro giri di bozze) offrono la prova di un’anteriore composizione dei primi sette testi del volume, nonché della complessità del lavoro correttorio che emerge dalla stratificazione degli interventi.
La possibilità di collazionare i materiali di partenza (in mancanza, per ora, di altra documentazione manoscritta) con il risultato conclusivo della stampa in volume, mostra come all’unità di visione che presiede all’organizzazione dei testi, risponda il lavoro di rielaborazione stilistica: l’esempio del calligrafismo del testo iniziale non si propone così marcato nelle altre prose, ma a un modello di nobiltà formale tendono complessivamente i criteri correttorî adottati per l’intera opera. Ridotti a pochi casi le soppressioni, gli interventi più numerosi sono di tipo sostitutivo o aggiuntivo. Ampio soprattutto il catalogo delle aggiunte (alcune di considerevole estensione interessano la terzultima e penultima prosa) a documentare un ventaglio eloquente dei procedimenti espressivi gaddiani.
La storia delle Meraviglie d’Italia e degli Anni non si esaurisce con le edizioni Parenti. A distanza di un decennio dalla loro pubblicazione, Gadda propone a Einaudi, nel corso di trattative per ristampa di alcune sue opere, la riedizione associata dei due libri. Ma le complicate vicende editoriali in cui si trova coinvolto intralciano il progetto e finiscono per indirizzarlo, come si vedrà, verso esiti imprevisti.
Verso la Certosa (1961)
Nell’ottobre 1961 esce dall’editore Ricciardi un elegante volumetto della collana Sine titulo, dalla tiratura limitata a 1500 esemplari, personalizzato dalla presenza di un ritratto dell’autore, disegno originale di Leonetta Cecchi Pieraccini, e dalla premessa di uno scritto di dedica a Raffaele Mattioli. Vi confluiscono otto prose degli Anni, nucleo portante della raccolta, cinque delle Meraviglie, oltre a cinque scritti di provenienza giornalistica di anni più recenti, inediti in volume. Questa pubblicazione è un’opera autonoma – del tutto diversa – dalle precedenti a cui si richiama: l’intenso lavoro di rielaborazione dei testi, documentato dalle correzioni autografe sugli originali e sulle bozze di stampa, le sofferte fasi dell’allestimento del volume, attestate dal carteggio con l’editore, ne sono la prova. (7) Ma le operazioni che approdano a questo risultato partono più da lontano e da premesse diverse.
L’avvio dei contatti con la casa editrice Ricciardi risale al dicembre ’57: l’occasione era stata l’assegnazione a Gadda del Premio degli Editori a risarcimento del mancato Marzotto, a cui aveva concorso con il Pasticciaccio, fresco di stampa. Entusiasta promotore era stato Emilio Cecchi, munifico mecenate Raffaele Mattioli. La risposta di Gadda alla generosa iniziativa è il proposito di pubblicare, in forma quasi di edizione privata, un lavoro che avesse nel banchiere umanista il destinatario privilegiato e che trovasse sede proprio in una delle raffinate collezioni della sua casa editrice.
Il primo intento è quello di pubblicare il racconto lungo (o romanzo breve) Accoppiamenti giudiziosi, parzialmente edito sulla rivista Palatina di Parma, ma trattative editoriali avviate da tempo con Garzanti inducono Gadda a rinunciarvi e a indirizzare la scelta su La cognizione del dolore, apparsa in Letteratura e già promessa a Einaudi. Saranno proprio le precedenti intese con l’editore torinese a deviare ancora una volta il percorso: Einaudi si opporrà fermamente a cedere la Cognizione a Ricciardi, concedendogli in alternativa la facoltà di pubblicare Le meraviglie d’Italia e Gli anni di cui aveva assunto dal ’53 i diritti editoriali, senza rinunciare a una eventuale propria edizione.
La selezione si rivolge allora in un primo tempo alla raccolta delle prose poetiche Gli anni, che viene accolta quasi integralmente nel nuovo volume. Sono dunque le componenti tematiche e stilistiche proprie di quest’opera, dai prevalenti toni lirici ed elegiaci, a dare l’impronta alla nuova silloge, e a questo denominatore comune tende a uniformarsi il lavoro di revisione che investe tutti i testi raccolti, e che comporta talvolta il sacrificio di certi elementi comico-grotteschi, tipici del controcanto gaddiano, assorbiti entro un livello stilistico di maggiore sostenutezza o in qualche caso abbassati al piano delle note.
La costruzione avviene, come di consueto, con l’aggregazione progressiva di altri materiali, nell’alternanza di scelte e di esclusioni – e sofferte incertezze – ben documentate dal carteggio con l’editore.
Indiscussa e felice soluzione fu quella di includere fin dalle prime fasi del lavoro, una prosa edita in rivista, Il Petrarca a Milano, e di assegnarle in seguito la funzione di chiusura dell’opera, proprio in concomitanza con la scelta del titolo, Verso la Certosa, con cui si stabilisce una sorta di richiamo circolare tra l’inizio e la fine del volume. Nel titolo infatti si legge l’accenno alla residenza milanese di Petrarca, nella solitudine voluta e cercata accanto alla Certosa di Garegnano (nei pressi del cimitero di Musocco) ma si intravvede anche l’allusione ben familiare ai milanesi all’avvio verso la dimora estrema. Da qui si comprende la volontà di attribuire alla raccolta il valore di opera conclusiva, di raggiunto traguardo. Il significato di testamento umano e letterario insito nel titolo è reso esplicito da Gadda in una delle ultime lettere al suo editore:
Si ha così una specie di traslazione dell’animo dell’autore scrivente nell’intima aspirazione di un ben più grande essere e nel suo pacato incamminarsi verso la fine, e la pace. (Gadda 2001c: 69)
Verso la Certosa è il libro con cui di fatto si conclude, nella sua fase vitale, l’articolato percorso dei testi delle Meraviglie e degli Anni.
Le meraviglie d’Italia-Gli anni (1964)
L’edizione Einaudi che uscirà nel ’64 nella collana dei Supercoralli col titolo Le meraviglie d’Italia-Gli anni (in sovracoperta il particolare del Paesaggio con scena sotto una tenda di Giovan Francesco Grimaldi) rappresenta per Gadda piuttosto l’adempimento di un impegno assunto molti anni prima con l’editore che l’espressione di una sua precisa volontà. Nell’opera di allestimento del volume, infatti, non si definisce chiaramente un disegno di mano d’autore, che sembra invece limitarsi a sorvegliarne l’esecuzione. Dal carteggio con Einaudi appare evidente lo scarso entusiasmo di Gadda a mettere mano di nuovo a quei testi, arrivando perfino a prospettare l’inopportunità della loro ristampa (Gadda 2003d: 111-12).
L’operazione configurò una organizzazione strutturale del tutto nuova dei testi attinti alle tre precedenti raccolte, proponendoli però, salvo pochi ritocchi, nella veste formale della loro ultima pubblicazione. Se da un lato è riproposta quasi integralmente la scelta dei brani di Verso la Certosa e ne è assunta la lezione (si intende che le prose in origine appartenenti alle Meraviglie o agli Anni o edite in rivista e accolte poi nell’edizione Ricciardi sono riprodotte nella versione approntata per questa pubblicazione), dall’altro sono recuperati brani dalle Meraviglie e un solo scritto dagli Anni nella loro lezione originale. (Unico fuori serie qui accolto è La «Mostra Leonardesca» di Milano, già apparso in rivista.)
La ragione di questa soluzione di compromesso si comprende nella riluttanza di Gadda a intervenire ancora su materiali che, in funzione della loro pubblicazione in Verso la Certosa erano stati sottoposti a una profonda revisione, tale da qualificarsi come una acquisizione definitiva. Anche il titolo non rinnovato, rimasto un po’ riduttivamente Le meraviglie d’Italia-Gli anni, spiega significativamente lo scarso coinvolgimento di Gadda, così attento in altre occasioni a sondare le diverse possibilità di scelta.
Per l’edizione Garzanti delle Opere di Carlo Emilio Gadda, ci è parso più opportuno, per le ragioni qui esposte, rinunciare a ripubblicare Le meraviglie d’Italia-Gli anni, Einaudi ’64, (che chiude, ma solo in senso cronologico, la complessa storia interna dei testi raccolti) privilegiando invece le fasi precedenti, attentamente sorvegliate dall’autore. Con la riproduzione delle stampe Parenti del ’39 e del ’43, oggi di difficile accesso per l’esiguità della tiratura tipografica, ci si è proposti di avvalorare l’importanza e l’autonomia del momento iniziale del percorso, mentre si è voluto riconoscere a Verso la Certosa il valore di opera conclusiva, con cui si esaurisce, entro un disegno organizzato, l’itinerario dell’elaborazione di questi scritti.
Note
1. D. Isella, Presentazione dell’edizione, RR I xx.
2. Presso la Biblioteca Trivulziana di Milano è ospitato il «Fondo C.E. Gadda» costituitosi col materiale proveniente dall’Archivio Garzanti, dal Fondo Roscioni, dal Fondo Citati. Nella sede dell’Archivio Contemporaneo «Alessandro Bonsanti» del Gabinetto Vieusseux di Firenze sono raccolte le carte di famiglia (documenti e lettere).
3. Ci si riferisce alla scelta operata per SGF I, dove sono state riprodotte le prime tre raccolte (Le meraviglie d’Italia, pp. 11-199, Gli anni, pp. 201-72, Verso la Certosa, pp. 273-397). Si è preferito invece escludere la quarta (Le meraviglie d’Italia-Gli anni, 1964), di cui è stata data descrizione nella Nota al testo, integrata con la riproduzione dell’indice (pp. 1289-295).
4. Bibliografia degli scritti di C.E. Gadda, a c. di D. Isella, in SVP.
5. L’operazione è documentata dagli appunti autografi (a cui si aggiunge la preziosa testimonianza di una lettera a Bonsanti) conservati nel Fondo Roscioni. Ragguagli più dettagliati sono nella nostra Nota alle Meraviglie d’Italia, SGF I 1244.
6. Particolari di queste trattative sono ora emersi più chiaramente dalla pubblicazione delle Lettere all’editore Einaudi, a c. di L. Orlando, in Gadda 2003d: 62-68.
7. I materiali a cui si fa riferimento sono conservati nell’«Archivio Ricciardi» depositato presso l’Università Statale di Milano. Le Lettere all’editore Ricciardi (1957-1961) sono pubblicate ora, a c. di L. Orlando, in Gadda 2001c: 43-87.
Published by The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS)
ISSN 1476-9859
ISBN 1-904371-17-5
© 2007-2025 by Liliana Orlando & EJGS. First published in EJGS (EJGS 6/2007), Supplement no. 6.
artwork © 2007-2025 by G. & F. Pedriali.
framed image: after Niccola Guttierez, active 1743, Untitled, Rhode Island School of Design Museum, Providence.
All EJGS hyperlinks are the responsibility of the Chair of the Board of Editors.
EJGS is a member of CELJ, The Council of Editors of Learned Journals. EJGS may not be printed, forwarded, or otherwise distributed for any reasons other than personal use.
Dynamically-generated word count for this file is 3754 words, the equivalent of 11 pages in print.


