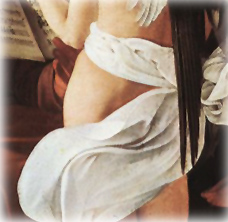 |
Carlo Emilio Gadda e la gioia del narrare *
Carla Benedetti
Carlo Emilio Gadda ha fama di essere lo scrittore italiano più umorale del 900, che ha travasato nella narrativa ogni sorta di emozioni: ira, sdegno, furore, dolore, amarezza, malinconia, commozione, ilarità, euforia; con tutti i relativi registri: sarcasmo, ironia, elegia, sublime, tragico, comico. Ciò ne fa un autore molto adatto a essere trattato in questo convegno dedicato a Emozioni e romanzo. Se non fosse che, per un paradosso su cui non possiamo non soffermarci un momento, i romanzi di Gadda, proprio a causa di questa loro peculiarità, non vengono considerati dei romanzi a pieno titolo.
Quegli umori infatti sono stati rubricati come fenomeni di stile, e come tali studiati, indipendentemente dal genere letterario che li contiene. La critica ha così ripetuto sull’opera di Gadda l’errore che Bachtin rimproverava agli studi stilistici del romanzo: quello di staccare lo stile dal genere, di fare cioè, «invece di un’analisi dello stile romanzesco […] una descrizione della lingua del romanziere». (1) La conseguenza è quella che conosciamo: Gadda è stato canonizzato non come narratore ma come prosatore, cioè, nell’accezione italiana memore della prosa d’arte, uno scrittore di pagine, di bei pezzi – da apprezzare isolatamente anche nel loro virtuosismo – se non addirittura di poème en prose, come ebbe a dire il suo primo e più autorevole interprete Gianfranco Contini (Contini 1989: 19). Tutte cose che stanno agli antipodi del romanzo.
La maggiore responsabilità di questa lettura a-romanzesca ricade su Contini, che per primo disegnò la mappa che avrebbe permesso di esplorare l’opera di questo narratore anomalo. La mappa ruotava attorno a tre concetti-chiave (poi divenuti etichette, che stanno tuttora ben incollate sull’oggetto): plurilinguismo, espressionismo, maccheronea. Con questa triade Contini non solo fotografava l’eterogeneità della pagina di Gadda, caratterizzata da un’eclatante mescidanza linguistica e stilistica, ma anche la spiegava e la motivava inserendola in una tradizione: Dante, Folengo, gli scapigliati, gli espressionisti. Una tradizione – si noti – non specificamente romanzesca. La tendenza di Gadda a usare tutte le lingue e tutti gli strati dell’idioma comune (da quelli arcaici a quelli moderni, da quelli letterari a quelli della lingua dell’uso, dai tecnicismi al dialetto) riceveva così una legittimazione – ma al prezzo di negare l’organismo romanzesco.
Per Contini lo stile senza il romanzo non era una cattiva cosa. L’organismo narrativo non lo interessava. Altri dopo di lui hanno invece mutato assiologia, mettendo al primo posto i cosiddetti valori della narrativa. Tuttavia non hanno corretto il taglio tutto stilistico della lettura di Contini, di cui, anzi, hanno lasciata intatta la sostanza mettendole semplicemente davanti un segno negativo. Per esempio Pier Vincenzo Mengaldo in un libro recente ha confessato di appartenere a quella minoranza di italiani che «non delirano per Gadda». Il suo «giudizio di valore», che intende ridimensionare quello di Contini, non ne mette però in discussione il pre-giudizio, e si sviluppa con un argomento che ripete la descrizione critica di Contini semplicemente rovesciandola di segno, e cioè che Gadda «stilisticamente così moderno e ricco, narrativamente non lo sia». Così anche per Mengaldo esattamente come per Contini Gadda resta uno scrittore di pezzi che si limita a «giustapporre “poemetti in prosa”». (2)
In quelle stesse pagine Mengaldo si chiede anche «se non sia proprio la costante accensione stilistica a impedire che la sua narrativa abbia il vero “passo” del racconto». Ecco così trapelare anche il pregiudizio maggiore, che si riverbera sull’intera letteratura italiana del Novecento, che sarebbe priva di romanzi proprio perché troppo impegnata sul versante dello stile. Viene da chiedersi in base a quale necessità la tensione stilistica dovrebbe agire in direzione contraria alla tensione narrativa. Quanti romanzieri del Novecento (a cominciare da Joyce) potrebbero smentire questa pseudo-legge, mai del resto formulata per nessun’altra letteratura se non per quella italiana?
Nel primo volume dell’opera che sarà presentata domani, Il romanzo a cura di Franco Moretti, (3) c’è un saggio di Vittorio Coletti intitolato La standardizzazione del linguaggio: il caso italiano. È l’unico in cui Gadda sia nominato. Ma ecco a quale proposito: si parla del culto della prosa che nella nostra letteratura nazionale entrerebbe spesso in conflitto con la volontà di narrare, e della «narrativa espressionista», tutta puntata sulla scrittura e «sull’idioletto dell’autore». A questo punto del mio intervento citare questo studio è una ridondanza: non aggiunge niente a ciò che ho già detto. Ma poiché se ne discuterà domani, vorrei leggervi un passo tratto da quell’unica pagina dell’intero volume in cui si parli Gadda (Moretti 2002: 328-29):
La decisione di una lingua che esaspera le distanze tra i suoi costituenti, non minimamente ridotte e anzi accentuate dalla loro presa in carico da parte dell’autore narratore, non è compatibile con alcuni principi costitutivi della narratività: la progressione e la concatenazione della trama soprattutto. L’espressionismo linguistico attira l’attenzione sullo stile ma in effetti non ha molto altro da mostrare; mette al centro le proprie parole e ne fa le protagoniste. Il libro si sbriciola in pagine, in brani, in sequenze antologiche, spesso felici, comiche divertenti, ma narrativamente senza nesso. Non è un caso che in Dossi, come poi in Gadda, i libri si costruiscano riciclando materiali e figure che affiorano in testi diversi, che la loro tenuta sia debole e in fondo non rilevante per il lettore, che si appaga del virtuosismo linguistico del momento. Giustamente Isella parla per Dossi, come ha fatto Contini per Gadda, di poemetti in prosa o prosa d’arte, di un sostanziale «disinteresse per il romanzo».
Vorrei quindi porre una domanda per la discussione di domani. Perché si continua ancora oggi a mettere a fuoco le caratteristiche della narrativa gaddiana come fenomeni di lingua o di stile, indipendentemente dalla forma romanzo? Perché parlando di uno scrittore italiano si ignora la tradizione romanzesca (quale sia lo dirò tra poco) che potrebbe illuminarlo?
Senza dubbio Gadda è un romanziere sui generis. Non organizza mai degli intrecci che tengano il lettore col fiato sospeso nell’attesa di sapere come andrà a finire. Del resto molti dei suoi romanzi risultano come non conchiusi. Ma questa caratteristica delle sue opere dovrebbe essere indagata in rapporto al tipo di costruzione romanzesca che Gadda aveva in mente, più volta a una sorta di teatro del mondo, dove gli uomini, gli animali, i minerali, i corpi celesti e tutto l’universo vivono intrecciati, in infinite interrelazioni di storie e di destini, e in cui la prospettiva della storia naturale (4) domina su quella antropologica o storiografica della storia degli uomini –, che non all’isolamento di una fabula, che per Gadda sarebbe inficiata di astrazione. Non si può quindi proiettare sulla sua opera quello stesso atteggiamento di «fuga dal racconto» che Debenedetti vedeva in Soffici e in altri vociani: un’incapacità, o quasi uno «sgomento di narrare». (5) Gadda ha tutt’altra attitudine nei confronti del racconto: un’attitudine profondamente narrativa e elettivamente romanzesca, che chiamo gioia del narrare.
Non sta comunque nell’apparente non chiusura delle sue storie la ragione per cui i critici fanno fatica a considerare Gadda un romanziere. (6) Sta piuttosto, come dicevo all’inizio, nel tipo di emozioni che egli riversa nel racconto, che molti avvertono come incompatibili con il romanzo e che Contini per primo percepì come la spia della «qualità lirica del temperamento» di Gadda. (7) Si tratta infatti di un pathos assai particolare, perché non appartiene né ai personaggi né al lettore. Non si tratta quindi (riprendendo la distinzione che poco fa Paolo Tortonese ha proposto) né delle emozioni che il romanzo da sempre rappresenta né di quelle che il romanzo provoca sul lettore. Si tratta invece delle emozioni di chi parla, da cui cioè è affetto lo stesso soggetto rappresentatore nel momento stesso in cui si appresta a rappresentare il mondo. E non hanno luogo nella diegesi ma nell’atto stesso della narrazione, modulando o perturbando quel canale comunicativo in cui a un capo del filo c’è l’autore dall’altro capo il lettore. Sono queste le emozioni che dilagano nella pagina narrativa di Gadda.
E sono anche – cosa ancora più singolare nel panorama narrativo a lui contemporaneo – emozioni in continua oscillazione, che fanno «cangiar di tono» alla pagina, facendola trascorrere da un registro all’altro con passaggi bruschi, che si consumano talvolta nel giro di una sola frase, persino di uno stesso sintagma. Dicendo «cangiar di tono» uso le parole che Gadda stesso ha usato in un breve saggio del 1951 in cui commenta una ballata di Villon, il poeta che «ride nel pianto» (come recita un suo celebre verso). Ecco il passo:
Una meravigliosa capacità di sghignazzare tra le lacrime, la risata che si alterna alla preghiera, alla pietà filiale: la voce più vera del dolore, la desolata contemplazione del proprio dolore. La invocazione alla Madonna, nella celebre ballata del Testamento: e subito dopo la beffa dell’avara meretrice, che non ha corrisposto l’amore. Questa ineguagliata attitudine a cangiar di tono da una strofe all’altra, da un verso all’altro – questa mescolanza – così drammaticamente iridata di pathos e di scherno, avvicina François Villon a due grandi poeti: Catullo e Shakespeare. (Je meurs de seuf au près de la fontaine, SGF I 527)
Questa mescolanza – aggiungiamo noi – è anche ciò che avvicina Gadda a Villon. Troviamo nelle sue pagine la stessa capacità di sghignazzare tra le lacrime, la stessa attitudine a cangiar di tono da una riga all’altra. Con la differenza però che Gadda non scrive ballate ma romanzi.
Non è che il romanzo non abbia mai conosciuto analoghe mescolanze di pathos e di scherno. Le ha conosciute in passato, ai tempi di Rabelais, del romanzo barocco e del romanzo umorista. Gadda però scrive in tempi in cui quella linea stilistica del romanzo non è più viva, superata da un’altra orami diventata egemone. Talmente egemone da far sì che i critici italiani misurino su questo modello le supposte carenze romanzesche di Gadda. Perciò il romanziere Gadda ha potuto essere immortalato come il «signore della prosa», come si legge oggi persino nel marmo della sua nuova sepoltura nel Cimitero degli Inglesi di Roma: «Qui nel cuore antico sempre vivo di sogni e d’utopie, Roma dà asilo alle spoglie di Carlo Emilio Gadda, geniale studioso, artista dalle forti passioni morali e civili, signore della prosa». (8)
Arduo scrivere una lapide per uno scrittore che in vita non ha fatto altro che sbeffeggiare la retorica delle lapidi e l’ipocrisia di quel costume che impone «l’inutilità marmorea del bene» (parole di Gadda tratte da Tendo al mio fine) e tutti i paroloni bugiardi che «gallano al di sopra de’ vermini». Anche queste sono parole di Gadda, ma prese in prestito da Quevedo, da El mundo por de dentro, che egli tradusse nel 1941 con il titolo Il mondo come è. Di questa traduzione sarebbe interessantissimo leggere qualche passo perché è nello stesso tempo molto infedele e paradossalmente fedelissima. Per esempio, dove Quevedo scrive:
mas las bravatas que en los tùmulos sobrescriben podriciòn y gusanos, se podrìan excusar,
Gadda traduce:
Però, dico io, le bischeraggini che vanno scrivendo in sul marmo, sì, sì, tutte codeste bravazzate degli epitafî che le gallano al di sopra de’ vermini e della putrèdine, quelle almeno, diobono, quelle potrebbono davvero tralasciarle, o cervelloni! (SVP 275)
Come si vede già da questo piccolo campione, il traduttore si prende molte libertà: allunga il testo di Quevedo, aggiunge di suo, gli presta persino i suoi stessi moduli stilistici (l’arcaismo vermini, le coloriture colloquiali, regionali, e tutti quei differenziali linguistici di cui Gadda fa uso nella sua pagina) – ma in una maniera che non tradisce il testo di partenza, anzi lo rafforza andando nella sua stessa direzione. Gadda tratta il testo di Quevedo come se fosse un proprio testo, perché evidentemente tra i due scrittori c’è un’affinità. C’è in entrambi la stessa suscettibilità all’ipocrisia, la stessa passione per lo sbugiardamento delle false apparenze. Ma c’è soprattutto – quello che qui più ci interessa – una stessa propensione verso quella che Bachtin chiamava la «parola patetica», intendendo con ciò una parola mossa da un pathos molto diverso da quello lirico:
Il patetismo barocco è determinato dall’apologetica e dalla polemica. È un pathos prosastico, che di continuo sente la resistenza della parola altrui, del punto di vista altrui, il pathos della giustificazione (autogiustificazione) e dell’accusa. [...] è la parola del predicatore senza pulpito, del giudice severo senza potere giudiziario e punitivo, del profeta senza missione, del politico senza potere politico, del credente senza chiesa. (Bachtin 1979: 201-02)
Un atteggiamento analogo, di continuo coinvolgimento emotivo del parlante, nei toni dell’accusa, del risentimento, della polemica, dell’invettiva, persino della predica morale, lo troviamo anche nei romanzi di Gadda. Il che spiega come mai per rendere la prosa di Quevedo, Gadda usi espedienti stilistici e linguistici che sono i suoi stessi. Il narratore barocco tende a esprimere le cose con forti connotazioni emotive: indignazione, polemica, sarcasmo, risentimento, malinconia. Il narratore moderno Carlo Emilio Gadda rincara il pathos del narratore barocco. Ma per far ciò non ha bisogno di inventarsi una scrittura adatta allo scopo. La scrittura già la possiede. È la sua propria.
Ma si noti anche una differenza. In Quevedo a parlare in quel modo è un personaggio, quello che dice di chiamarsi il Disinganno (9) e che conduce il narratore su una grande strada per mostrargli il mondo por de dentro, cioè come è davvero, dietro alle apparenze ipocrite di cui si riveste. Qui gli mostra una serie di personaggi, su ognuno dei quali svolge la sua funzione di disinganno, svelando la loro ipocrisia. Il suo pathos contro l’ipocrisia e il suo tono da predicatore è quindi in qualche modo giustificato nella finzione. Gadda invece non fa nemmeno questo. Non affida mai la responsabilità della propria parola patetica, della propria indignazione, né di tutti gli altri umori e emozioni che emergono nella sua pagina, alla soggettività di un personaggio. Non lo affida nemmeno a quel primo personaggio che ogni romanzo – per lo meno nei suoi sviluppi otto-novecenteschi – è tenuto a inventare, voglio dire il narratore. Non mi riferisco ovviamente al narratore in prima persona o omodiegetico – che è solo un caso particolare di invenzione del personaggio del narratore – ma a tutti i possibili narratori extradiegetici che vengono costruiti come dei personaggi nell’atto stesso di narrare, e che, con gradi più o meno forti, si condensano in una personalità, in una psicologia coerente, in una persona, cioè in una maschera. Gadda invece svolge in proprio le sue requisitorie più umorali, senza delegarle a nessun personaggio, a nessun narratore-personaggio e a nessun autore di convenzione. Perciò potremmo dire che sono svolte sul conto dell’autore. Così sono nel Pasticciaccio le irrisioni a Mussolini e le requisitorie contro il fascismo. Ecco un esempio minimo:
I radiosi destini non avevano avuto campo a manifestarsi, come di poi accadde, in tutto il loro splendore. (Pasticciaccio, RR II 56)
La tirata contro le false apparenze viene qui svolta alla maniera di Quevedo, con la sua tipica tecnica della ritorsione, cioè usando le stesse parole d’ordine e gli stessi simboli altisonanti del fascismo («i radiosi destini») fino a renderli grotteschi e ritorcendoglieli contro. Ma non c’è nessun personaggio a parlare. L’umore sarcastico sboccia direttamente dalla stessa voce che narra, la quale però, subito dopo, può passare a tutt’altre tonalità, magari lirico-elegiache, come quando si abbandona alla riflessione sull’inevitabilità del male:
Ci sono dei torbidi attimi nel lento gocciolare delle ore: delle ore di pubertà. Il male affiora a schegge, imprevisto, orribili schegge da sotto il tegumento, da sotto la pelle delle chiacchiere. (Pasticciaccio, RR II 75)
O come quando dà voce, con toni malinconici, alla commozione per il «dolorare delle generazioni», proiettata nelle note tristi del cucù, memoria di tutto ciò che muore, mentre l’ordine naturale rinasce in un nuovo ciclo di stagioni:
Da un olmo non veduto, ora, forse da un leccio alla scure superstite nel vuoto della campagna, l’appello intermittente, irraggiungibile, l’implorante giambo del cucù. Nel presagire le nuove fronde alla terra pareva rimemorare le stagioni eterne e perdute, dolorare della primavera. (Pasticciaccio, RR II 218).
Tutte queste tonalità emotive e registri non sono fissati a dei personaggi, e nemmeno al personaggio del narratore. Non hanno maschere personali, non si incarnano cioè nei singoli strumenti dell’orchestra come invece succede nella grande polifonia che caratterizza il romanzo moderno, dove ora emerge la voce di un personaggio, ora di un altro personaggio, ora quella del narratore, alternate o sovrapposte, ma ognuno con il suo proprio timbro, come tanti strumenti che collaborano a formare la sinfonia. In Gadda i trapassi (dal sarcasmo alla malinconia, dall’ironia alla commozione, dall’elegia agli improvvisi scatti comici), avvengono invece tutti in un unico canale: quello della voce che parla, e che ora racconta, ora commenta, ora inveisce, ora descrive, ora fa digressioni, e poi, comunque, sempre torna a narrare. Questa voce così non acquista mai la fisionomia di un narratore come si deve, cioè coerente, come gli sviluppi del romanzo otto-novecentesco ci ha abituato a richiedere al racconto. Quel trascorrere di emozioni dà infatti luogo a impasti così incoerenti da contraddire non solo i principi dell’aptum (ibridazione di comico e tragico, di sublime e di sarcastico, ecc.), ma persino i principi psicologici su cui si regge la costruzione del personaggio, compreso, come dicevo, quel primo personaggio che ogni romanzo moderno dovrebbe inventare, cioè il narratore. Il narratore gaddiano non ha una coerenza tonale, non possiede una voce univoca, e parla contemporaneamente tutte le voci e tutte le lingue della complessa pluridiscorsività sociale che lo circonda. Nessuna soggettività coerente, nessuna persona, nessuna maschera può emergere da questa singolare mescidanza. In maniera radicale potremmo anche dire che chi parla nel romanzo gaddiano non è un Io. Del resto Gadda ha più volte affermato di voler distruggere «quel pregiudizio che chiamiamo persona», o quell’astrazione che chiamiamo persona. E se la persona è un’astrazione, lo sarà anche il personaggio del narratore o dell’autore di convenzione. E questa astrazione è appunto ciò su cui si fonda la regolamentazione vocale del romanzo moderno, così come si è fissato nel modello dominante, ancora oggi dominante.
Bachtin distingueva due diverse forme di introduzione e di organizzazione della pluridiscorsività sociale dentro al romanzo:
1) la prima è la stilizzazione impersonale o diretta delle lingue sociali (dei generi letterari, delle professioni e di altro). La chiama impersonale perché qui le diverse lingue non si incarnano in personaggi, come invece avviene nella seconda forma;
2) la seconda forma di organizzazione della pluridiscorsività è appunto quella in cui le diverse lingue entrano come immagini incarnate o dell’autore convenzionale, o del narratore, o dei personaggi della storia (Bachtin 1979: 140 e passim).
La prima forma quindi non fissa la pluridiscorsività legandola a delle soggettività individuate nella finzione (che si tratti di personaggi della storia o di narratori), ma è tutta tenuta dentro alla voce dell’autore, la quale usa le diverse lingue ma separandosi da esse, quindi facendone una stilizzazione, spesso parodica. Queste lingue si alternano, senza netti confini formali, con la parola stessa dell’autore, la quale varia continuamente la sua distanza da esse, così smascherandone la falsità, l’ipocrisia, la limitatezza. E in questo continuo movimento e oscillazione c’è posto anche per la parola diretta dell’autore (di solito patetica, didattico-morale o elegiaco-sentimentale), proprio perché l’autore non si è posto alcun vincolo in proposito: non si è vincolato alla parola rifrangente di un narratore o di un autore di convenzione. Perciò egli può, assieme alla stilizzazione parodica delle lingue, anche esprimere immediatamente, senza alcuna rifrazione, le proprie intenzioni semantiche e assiologiche.
Per esemplificare questa forma impersonale (ma ovviamente gravida di parlanti, di tutti i parlanti che l’autore prende su di sé) Bachtin ricorre al romanzo umoristico: Fielding, Smollet, Sterne, Thackeray, Jean Paul e, in particolare, Dickens, di cui analizza qualche pagina (Bachtin 1979: 109 e sgg). Ma parla anche del romanzo barocco, e dell’influsso di Rabelais.
La parola romanzesca gaddiana, con il suo patetismo e con i suoi «precipitati trapassi», è una forma impersonale di organizzazione della discorsività. Sta in linea diretta con Rabelais, col romanzo barocco, col romanzo umorista, con Dickens – ma in un’epoca in cui quelli non sono più modelli per nessun romanziere. A dominare gli sviluppi del romanzo otto-novecentesco è stata infatti molto di più la seconda forma, quella personale, che orchestra e regola la pluridiscorsività entro un ordine distributivo, che non la prima; molto di più la parola rifrangente del narratore e dei personaggi che cancella la parola diretta dell’autore, che non la parola patetica o umoristica. Ed è per questo che si fa fatica a recepire Gadda come romanziere per celebrarlo come «signore della prosa». Definizione degna di Monsieur Jourdain e del suo maestro di retorica, per il quale – come ricorderete – da un lato c’era la poesia, dall’altro c’era la prosa, che era… tutto il resto. La prosa è appunto una categoria restante. Ci va a finire tutto ciò che non si sa come classificare. Quella lapide, al di là delle buone intenzioni di chi l’ha scritta, è la spia che non si sa come definire Gadda. È la lapide al pregiudizio critico, che non accenna a sciogliersi.
Mi resta ancora da dire qualcosa sulla gioia del narrare. Di tutte le emozioni la gioia è infatti quella che meno viene associata a Gadda, noto per tutt’altri umori. Di lui di solito si ricordano gli umori atrabiliari dell’indignazione, della rabbia, del sarcasmo. Del resto, per poter fare di Gadda un espressionista, cioè uno scrittore che strazia la parola nell’urlo dell’Io dolorante, occorreva enfatizzare, in mezzo a tutta la gamma di emozioni presenti nella sua pagina, proprio quella del dolore. Eppure, come sa ogni suo lettore, in Gadda si trovano anche altri umori, meno cupi, a cominciare dall’umore comico.
Per Spinoza le passioni sono «idee inadeguate». Ma di tutte le passioni, ce n’è una a cui egli dà un valore meno negativo delle altre, ed è la gioia. Per quanto anch’essa idea inadeguata, la gioia è meno negativa del dolore, perché aumenta la potenza di agire nel corpo che ne è affetto. Nella pagina dello spinoziano autore di cui ci stiamo occupando non solo le passioni gioiose abbondano accanto alle tristi, ma sono anche, spinozianamente, poste in una posizione sovraordinata, proprio perché più propizie a quella conoscenza rasserenante che si approssima alla saggezza. Lo si vede appunto dalla maniera ricorrente, e quasi sempre risolutiva, con cui l’euforia comica scoppia nella pagina gaddiana, a conclusione di un accumulo di tensione atrabiliare o malinconica.
Poiché non ho tempo di dimostrare ciò con analisi del testo, sopperirò con un rapido schema dei tre momenti (li chiamo così per sottolinearne l’aspetto dinamico) attraverso cui la pagina gaddiana trascorre continuamente:
1) il primo è il momento dell’indignazione, della rabbia e del risentimento. Esso esprime il punto di vista delI’Io oltraggiato dal destino e dai suoi «umani proietti», che concepisce la scrittura come una vendetta, mossa dal compito etico che consiste nel ripristinare una verità di contro alla falsificazione, sbugiardando le false apparenze dell’ipocrisia, deformando la «parlata falsa». Su questo momento si è concentrata la lettura espressionista di Contini e, dopo di lui, la maggioranza dei suoi esegeti. Ma poiché coglie solo un momento, io credo che questa lettura (oltre agli inconvenienti già detti) non sia nemmeno in grado di abbracciare tutta la complessità patetica di questa scrittura. Essa fissa il centro di gravità della pagina gaddiana appunto nell’Io oltraggiato «vindice del proprio diritto». Ma l’Io che reclama il proprio diritto vede e parla pur sempre da un punto di vista limitato. E questo è ciò che lo spinoziano maggiormente depreca. Perciò in Gadda, rispetto agli espressionisti, i termini assiologici sono come rovesciati. Malvagio non è solo il mondo colpevole di aver oltraggiato l’individuo, malvagio è anche il particolare che vuole persistere nella sua parzialità. Il soggetto dolorante è spesso visto da Gadda come sterile negatività: una «lercia trippa», come l’Io contro cui si scaglia Gonzalo nella Cognizione del dolore, incapace di predicar nulla su nulla. Per cui si potrebbe anche dire che Gadda sia un espressionista suo malgrado, il che equivale a riconoscere nella sua scrittura la presenza di altre spinte, di altre tensioni immaginative e etico-espressive, oltre a quella espressionistica.
2) Il secondo momento è quello della malinconia e del lutto. Qui il punto di vista è ancora quello dell’Io, ma un Io che si identifica con la comunità vivente delle anime, con il popolo delle anime che abita il mondo, alla stessa maniera del popolo delle piante. Il tema che gli si lega è quello della «pietà per le creature» destinate alla morte; ma anche quello dell’indecifrabile disegno immanente al mondo naturale (l’attesa di una rivelazione che non avviene). Quando incappa in questo momento la pagina gaddiana passa allora spesso a tonalità lirico-elegiache, come nel brano del cucù che ho letto prima.
3) C’è infine un terzo momento: quello dell’euforia per il molteplice fenomenico e per i modi dell’infinita sostanza. La stessa euforia che prende l’autore della Cognizione del dolore di fronte ai cocomeri oblunghi che smentiscono l’«entelechia delle zucche», cioè la rotondità pensata come loro forma sostanziale; o che prende Carlo, personaggio dell’Adalgisa, e paziente catalogatore di insetti, coleotteri e necrofori, quando si sofferma a esclamare: «la natüra l’è talment granda, talment infinida». Questo momento esprime un punto di vista sul mondo più vasto di quello dell’Io dolorante, ma che non è nemmeno più filtrato attraverso la percezione dell’Io malinconico. È per esempio il mondo come appare dal punto di vista della storia naturale. Questo punto di vista, che si immette continuamente nella pagina gaddiana, in maniera intermittente, funziona spesso come un improvviso allargamento della prospettiva dell’Io dolorante, provocando l’euforia comica. Oppure è il continuo richiamo della «comunità vivente delle anime» e della loro naturale polifonia, nella quale la voce che narra si immerge per attenuare l’esasperata soggettività dell’Io che lamenta nelle cose solo l’oltraggio a sé diretto. Il registro che si associa a questo momento è il realistico-euforico, con esiti spesso comici. Queste tonalità comico-euforiche punteggiano così la pagina di Gadda, proprio come sbocco di tutta quella drammatica dialettica di passioni, quasi come una catarsi euforica – non tragica – e quindi mai definitiva, al contrario sempre ricominciante, di tutto quell’accumulo di umori.
Questo momento, secondo me, è ciò che muove l’organismo romanzesco gaddiano. Mentre gli altri due momenti si potrebbero esprimere anche attraverso la lirica, o altri generi, quest’ultimo non ci sarebbe se non ci fosse narrazione. È quindi la sua spinta più forte a narrare – e la ragione per cui Gadda non è un poeta, né un prosatore, né uno scrittore di poèmes en prose.
Per finire, lascio la parola a Gadda, leggendovi un brano da cui ho attinto l’immagine della gioia del narrare. È un testo interessante anche perché è, in senso letterale, una risposta a Contini. Nel 1947, dopo che Contini ebbe usato per lui la definizione di macaronico, Gadda reagì. Scrisse un saggio, intitolato Fatto personale o quasi, poi raccolto nei Viaggi la morte, per mostrare come quell’atteggiamento, che certamente intride la sua scrittura e la sua «anima», sia però un’erba che cresce in ogni fosso: «Se il macarone è stato servito a tavola ad onor mio, e attende nel piatto, vorrei non v’aveste a credere, amici, ch’io sia il solo ad alimentarmene» (SGF I 495). E va avanti per diverse pagine sostenendo che la maccheronea la fanno e l’hanno sempre fatta tutti, non solo i letterati, ma anche le genti nelle piazze, gli alpini al fronte, e tutta la «comunità vivente delle anime». Gadda rivendica così non solo l’origine non letteraria del «procedimento», ma anche l’origine per così dire vitale, «di difesa e di offesa»: di difesa contro i soprusi che si fanno attraverso il discorso, contro le astrazioni, contro le parole che falsificano, contro i paroloni, la retorica, le bugie, le ideologie, l’imbecillità dei concetti, e tutto ciò che menoma la libertà e la vita.
Vi leggo quindi il passo invitandovi a notare come Gadda allarghi ciò che in Contini è solo una categoria linguistico-stilistica. La allarga in due direzioni. Innanzitutto verso quella cosa che Bachtin avrebbe chiamato la pluridiscorsività sociale. In secondo luogo verso gli impulsi vitali che muovono alla descrizione e alla narrazione del mondo. E sono proprio questi impulsi che, per Gadda, allontanano la parola dalla satira e dalla malinconia, cioè dalle passioni negative, per farla trascorrere, con «precipitati trapassi», verso gli «allegri segni», verso la gioia del narrare.
Dire per maccheronea è dunque, talvolta, un adeguarsi al comune modo e gusto, un rivendicare e un risolvere le istanze profonde contro i piati stanchi, un immergersi nella comunità vivente delle anime, un prevenirne o secondarne in pagina l’ingenito impulso a descrivere, la volontà definitrice del reale, per allegri segni. Tenui sfumature, sottili vincoli o precipitati trapassi, dalla satira alla maccheronea. Dalla malinconia alla maccheronea.
Dire per maccheronea […] non è un esercizio barocco d’una prezioseggiante stramberia, ma desiderio e gioia del dipingere al di là della forma accettata e canonizzata dai bovi: è gioia dell’attingere agli strati autonomi della rappresentazione, all’umore freatico delle genti, atellane o padane che le fossero, delle anime. (Fatto personale, SGF I 498-99)
Quindi, per concludere, direi che non solo non c’è incompatibilità tra quello che è stato chiamato espressionismo gaddiano e il romanzo, ma che anzi una simile mescidanza di lingue, di voci, di umori e di pathos è possibile nella pagina gaddiana proprio perché si tratta di narrazione romanzesca.
Università di PisaNote
* Relazione tenuta al IV Colloquio di Letterature comparate dell’associazione Sigismondo Malatesta intitolato Le emozioni nel romanzo. Dal comico al patetico, svoltosi il 24 e 25 maggio 2002 alla Rocca di Sant’Arcangelo di Romagna. Poi pubblicata in P. Amalfitano (ed.), Le emozioni nel romanzo. Dal comico al patetico (Roma: Bulzoni, 2004), 191-207.
1. M. Bachtin, Estetica e romanzo (Torino: Einaudi, 1979), 71.
2. Mengaldo 1999: 119. Questo rovesciare il giudizio senza intaccare il pre-giudizio è tra l’altro la prova di come i soli giudizi di valore spesso non facciano procedere di un passo l’interpretazione critica di un autore.
3. F. Moretti, La cultura del romanzo (Torino: Einaudi, 2002).
4. Su questo argomento rimando a Benedetti 1995: 71-89.
5. G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento (Milano: Garzanti, 1987), 31-32. Molti, come ho detto, estendono poi quest’attitudine ben al di là dei vociani, ritenendola addirittura tipica della nostra letteratura.
6. Tanto più che l’epoca in cui l’opera di Gadda ha cominciato a raggiungere il pubblico è quella stessa che ha esaltato in vari modi il valore dell’opera aperta.
7. Se questa percezione fosse giusta, noi non potremmo far altro che rammaricarci che Gadda abbia scritto pochissime poesie, e che abbia invece mirato alla costruzione romanzesca fin dalle sue prime prove (come mostra il grande abbozzo di romanzo incompiuto intitolato Racconto italiano di ignoto del novecento), continuando cocciutamente a narrare per tutto il resto della sua carriera di scrittore.
8. La lapide è stata scritta dal poeta Mario Luzi e scoperta il 2 novembre 2001 in occasione dello spostamento delle spoglie di Gadda al Cimitero degli Inglesi di Roma.
9. Certamente il Disinganno non è un personaggio dallo statuto forte, dotato di profondità psicologica nel senso moderno, ma è pur sempre qualcuno che rifrange le intenzioni semantiche e assiologiche dell’autore.
Published by The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS)
ISSN 1476-9859
© 2008-2025 by Carla Benedetti & EJGS. Previously published in P. Amalfitano (ed.), Le emozioni nel romanzo. Dal comico al patetico (Rome: Bulzoni, 2004), 191-207.
Artwork © 2008-2025 by G. & F. Pedriali.
Framed image: after a detail from Caravaggio, Flight to Egypt, c.1597, Galleria Doria Pamphili, Rome.
All EJGS hyperlinks are the responsibility of the Chair of the Board of Editors.
EJGS is a member of CELJ, The Council of Editors of Learned Journals. EJGS may not be printed, forwarded, or otherwise distributed for any reasons other than personal use.
Dynamically-generated word count for this file is 5714 words, the equivalent of 17 pages in print.


