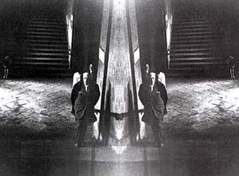 |
Gadda, o il testamento del capitano
Guglielmo Gorni
I conducenti con via la penna, quando cantavano bevuti il signor capitano, o la canzone di Celestina: o quella dei quattro pezzi. (Castello di Udine)
Gadda, o il testamento del capitano. Il titolo di questa mia lettura, o piuttosto invito alla lettura, delle prose di guerra e di prigionia prodotte da Gadda prima e dopo gli eventi narrati, può anche parere, a prima vista, bizzarro. Ma già Il castello di Udine, «imagine-sintesi di tutta la patria, quasi un amuleto dello spirito» (RR I 155), è calco, come si sa, dal ritornello di una patetica canzone alpina, O ce biel, o ce biel sischiél in Udin, essa pure citata a chiare lettere dall’autore: non sembri dunque strano che si estrapoli, da quella stessa intensa coralità popolare, un altro tema famoso per definire, con qualche complicità, le scritture militari del capitano di complemento in congedo Carlo Emilio Gadda. Le bizze del capitano in congedo è, d’altra parte, un titolo d’autore (1940) recuperato postumamente (1981) da Dante Isella a etichettare una seducente raccolta di scritti dispersi: perché, in effetti, si potrebbe applicare a Gadda quanto è detto del biblico affiliato all’ordine di Melchisedech, «Tu es capitaneus in aeternum».
Il capitano della canzone lasciava, per testamento, quattro o sei «pezzi» del suo corpo (a seconda delle versioni cantate) agli alpini, alle montagne, alla madre e alla sua bella. È singolare che anche il disperso testamento di Gadda sia stato ricomposto nelle sue parti superstiti solo postumamente: non prima, cioè, dell’edizione garzantiana curata da Isella nel 1992. L’autore aveva affidato la più parte dei suoi scritti militari (quelli dei taccuini, sincroni agli eventi) dapprima all’edizione fiorentina del Giornale di guerra e di prigionia, uscita nel 1955 presso Sansoni, e poi a quella einaudiana (1965) incrementata di un quaderno: lasciando inedito, ma con l’implicita certezza di una stampa postuma per cura d’altri (quelli a cui ne aveva fatto dono, i Bonsanti, come difatti avvenne), solo il cosiddetto Taccuino di Caporetto. Diario di guerra e di prigionia (ottobre 1917, aprile 1918), uscito per la prima volta come libro autonomo nel 1991, e poi riassorbito l’anno seguente nella grande edizione garzantiana diretta da Isella.
Richiamo in breve alla memoria come l’edizione fiorentina di Sansoni, che si deve soprattutto all’intelligente tenacia suasoria di Alessandro Bonsanti, si annettesse il secondo, quinto e sesto quaderno (il terzo, per l’anno 1917, «prezioso diario di Torino-Carso-Clodig», e anzi «il più prezioso di tutti», andò perduto per sempre nelle giornate di Caporetto); e come l’einaudiana di dieci anni dopo vi aggiungesse il primo taccuino, il Giornale di campagna, del 1915, sottoponendo però il tutto, pur ridotto a più diligente trascrizione, a censure imposte dall’autore, specialmente radicali nel caso dei nomi propri. Il quarto quaderno o taccuino – in stato precario di conservazione per l’uso, le piogge e il sudore della prigionia, durante la quale venne nascosto alle perquisizioni – è, come s’è detto, un recupero recentissimo, e tratta di fatti così traumatici per il soggetto, che Gadda non osò mai darlo alle stampe: la rottura del fronte italiano di fine ottobre 1917, narrata in forma di memoriale apologetico, ma privo d’indulgenze, a memoria futura; poche note di trincea di quello stesso mese, anteriori a Caporetto; e poi il periodo più duro e umiliante della prigionia nella fortezza di Rastatt, giungendo con le note fino al 30 aprile 1918, data in cui Gadda si trova già a Celle-Lager, nello Hannover, dove era arrivato il 29 Marzo. Questi i «pezzi» ora ricomposti. Si rammenti infine che, prima dell’edizione sansoniana, almeno due estratti erano stati anticipati su rivista, Dal Giornale di guerra per l’anno 1916 (Gadda 1951b) e Visita del Nunzio Apostolico al Campo di Celle. Dalle Note autobiografiche redatte in Cellelager (Gadda 1953c).
Ciò premesso, va detto che il testamento del capitano Gadda è molto più complesso, nella sua storia redazionale e nel rapporto con l’autore, di quanto dichiarano queste elementari indicazioni d’archivio; e che una filologia solo interna all’opera non basterebbe a dar conto, in maniera adeguata, di questo genere narrativo del «giornale di guerra», di così alta tensione e purtroppo finora così negletto dagli studiosi. C’è ancora un Gadda tutto da scoprire, tutto da spiegare e capire, ed è quello delle prose belliche. Che richiederà l’esercizio, mi è già accaduto di scrivere, di una «filologia delle parasanghe», e cioè ben addentro nelle cose d’artiglieria e dei regolamenti militari, nell’accidentata topografia dei fronti e della guerra in trincea: competenze che anche il lettore professionale più attrezzato non è in grado di assicurare senza una laboriosa documentazione preventiva. Sulle prose militari di Gadda non esiste praticamente bibliografia (onde l’invito alla lettura formulato in queste pagine). Forse anche perché il tono e la natura degli scritti sono lontani dall’immagine più accreditata dello scrittore (solo in apparenza, però: la polifonia è già operante, dall’«asineria» al sublime, e il mondo ideale già ben consolidato). Anche come documento storico, gli splendidi taccuini gaddiani sono destinati, confido, a una meritata fortuna: come anche certe lettere, capolavori assoluti, della prima giovinezza.
Ma si diceva che il gaddiano «giornale di guerra e di prigionia» è per suo statuto irriducibile al libro composito che porta in fronte questo titolo. Una bibliografia del Gadda scrittore de re militari deve risalire ben lontano, a una delle sue primissime prose pubblicate – e già a suo tempo rifiutata da Solaria, con grave delusione dell’autore –, Manovre di artiglieria da campagna, che si fregia di quell’ironico sottotitolo barocco Tiri di batteria da 75 e da 100: descrizione magnificata da due ipotiposi mitologiche e da diverse locuzioni dell’uso raro (Gadda 1928b), e che fu ripresa poi nel 1931 entro l’opera prima, La Madonna dei Filosofi. È uno studio dal vero, anche se la guerra è lontana; e l’ironia paradossale del sottotitolo servirà anche a mascherare una materia che per l’autore ha il volto della tragedia. Primi abbozzi e aggiustamenti di Manovre sono nel postumo Racconto italiano d’ignoto del novecento (1983), sotto la data 28 luglio e 2 agosto 1924, «dall’Arca di Longone sulle rocce di Sormano»: esercitazioni a fuoco, «manovre», non assalti e battaglie. Ma già in questa prosa, singolarissima per le stratificazioni implicite e per l’agglutinazione vistosa e non ben saldata delle parti, s’insinua il ricordo diretto della guerra vissuta, primo pudico affioramento della memoria.
Proprio così. «Affioramento per innesto in praeteritum tempus» è epigrafe che ricorre subito dopo nello stesso Racconto (SVP 590), a segnalare una modalità del ricordo e della scrittura. E «affioramento per innesto» – avverto fin d’ora – sarà tutta l’esperienza consegnata al Castello di Udine, e cioè alle cinque prose che ne costituiscono la «Parte prima»: perfino la dichiarazione di poetica dell’esordio, Tendo al mio fine, ne è in più punti contagiata. Sono tutte prose, queste, già pubblicate sul quotidiano L’Ambrosiano o su rivista, tra la fine del 1931 e il 1932, includendo nella serie La festa dell’uva a Marino per il finale epico e luttuoso. Del 1932 è anche, apparsa su Solaria, la recensione a Giani Stuparich, Guerra del ’15 (Dal taccuino di un volontario), di capitale importanza per la definizione del Gadda diarista. Sicché si può dire che in quel breve giro di mesi – anche La Madonna dei Filosofi, come si è visto, esce nel 1931 – s’inaugura la seconda stagione dello scrittore di cose militari, vari anni dopo che erano stati chiusi per sempre i commentari del soldato, compilati giorno dopo giorno dal 1915 al 1919, tra infiniti disagi: di fatto, è la prima serie di scritti gaddiani sulla Grande Guerra resa di pubblico dominio. E l’occasione anche, per l’autore, di riflettere sulla propria scrittura: Impossibilità di un diario di guerra, uscito sull’Ambrosiano il 7 dicembre 1931, ne è l’epigrafica sanzione.
Si assiste insomma (ma ciò appare chiaro solo al senno di poi) a un’operazione piuttosto sconcertante. Il diario di guerra vero e proprio – alludo, beninteso, ai quaderni gelosamente conservati da Gadda – è già composto, refrattario a ogni integrazione postuma o anacronistico intervento. Se ne dichiara però l’impossibilità ontologica: che non sarà dunque della scrittura in sé, ma della sua, proprio in senso etimologico, pubblicazione, della comunicabilità a un pubblico di lettori. Impossibilità che è fiero, e però (per l’autore) scoraggiante scarto, rispetto ai modelli invalsi: ai mille fortunati, confessi, e spesso più corrivi esempi, della letteratura di guerra. Stuparich, certo, di cui saranno stati suggestivi, per Gadda, anche i Colloqui con mio fratello (Carlo, irredentista, suicidatosi nel 1916 sul Cengio per non cadere in mano nemica), o il Paolo Monelli di Le scarpe al sole (1921); ma anche i detestati «corrispondenti di guerra», e dunque, mettiamo, Luigi Barzini, Olindo Malagodi, o Guelfo Civinini. Anche il popolarissimo, oleografico Piccolo alpino (1926) di Salvator Gotta dovette contribuire non poco a far cadere le mani a uno scrittore dotato, per non dir altro, di un così diverso temperamento.
E così crebbe l’odio per «certe povesie, con vignette di penna e piccozza» (Castello, RR I 178); e così «mi rassegnavo all’idea-tipo: gli alpini dovevano bere e poi cantare morendo, da farne una bella novella di cinquecento lire: o un carme pieno di lampade votive, in endecasillabi da circolo filologico» (RR I 175). Una «comunione d’umanità» Gadda confessa esplicitamente solo con Giovanni Comisso e Erich-Maria Remarque (RR I 135). Tace, significativamente, di Ardengo Soffici; di Emilio De Bono loderà, ambiguamente, «strafottenza e celerità di annotazione: e ciò, per ora, basti, anche se il discorso su questi rapporti o avversioni andrebbe ripreso ad altro fine. Non si dimentichi, a segnalare una predilezione, la dedica del Castello a Riccardo Bacchelli, di cui Gadda, in quegli anni, fu solidale recensore. Dirà in Racconto (SVP 576): «l’umanità delle lettere non si avvantaggia sempre così profittevolmente dei neri dolori». Ma ecco quanto Gadda da scrive nella recensione a Stuparich (SGF I 745-48), pensando ovviamente a se stesso:
Si tratta di un diario di guerra nel senso stretto della parola, note prese sui foglietti d’un taccuino che si sarà macerato dal sudore nelle tasche del combattente, con qualche cartolina e qualche tessera. E il diario, nella cosciente intenzione dello scrittore, è stato edito intatto, nella sua intatta veridicità. Questo spiega l’estrema obbiettività, l’estrema esteriorità del materiale: anche là dove il materiale narrativo è costituito da elementi psichici, (affettivi od estetici), questi affiorano in una luce vera e chiara di oggetti posti di fronte all’occhio stanco del soldato. Poiché prima verità del soldato è la fatica e la morte. Non c’è tempo per la pesca spiraloide delle sensazioni e per il complicato gioco di pettine con cui il bello finisce di agghindarsi: d’intorno a noi non ci sono che i bruti richiami d’una «esteriorità» (insisto) immediata, che anche il nostro intimo coinvolgono nel loro meccanismo così crudamente obbiettivo. Morire, faticare, buttarsi giù esausti, temere, veder morti, veder escrementi, sapere che bisognerà forse morire, certo faticare e temere ancora, questa la guerra, anche per una medaglia d’oro come lo Stuparich. (SGF I 745)
Anche la descrizione materiale coincide: i fogli macerati dal sudore, con qualche cartolina e tessera incollate tra la copertina e il foglio di guardia, cornispondono con affinità impressionanti alla descrizione del Taccuino di Caporetto fornita, in sede filologica, da Isella. Esaltata la «superiore fermezza e serenità» del triestino, a discapito della «folle ira» e «accasciamento» che l’autore riconosce come tratti tipici del suo sentire («mi commuove la ritenuta e generosa pacatezza dello Stuparich nel rappresentare la povertà etica media, io che ho riempito i miei diarî e le lettere di recriminazioni, di ingiurie, di sarcasmi», SGF I 747), Gadda aggiunge una frase rivelatrice, vero corto circuito dell’impossibilità:
Ma ritorniamo al diario e diciamo che un diario è fatto così, non c’è modo di integrare, non c’è tempo di elucubrare, tanto meno di recar giudizi su eventi e su cose sconosciute, sulle «retrovie» misteriose e sui misteriosi sviluppi della realtà complessa. (SGF I 746)
E ancora, più oltre il diario di Stuparich «mi trascina e m’incatena a rivivere» (SGF I 748). «Rivivere» e non poter «integrare», ecco il punto. Rivivere e di nuovo produrre, non già approntare per la stampa – magari edulcorando il tono e gli episodi, per conferire al testo una dimensione eroica che è nelle attese del pubblico – cose scritte, una volta per tutte, in quella loro, forma invariabile e di primo getto, che fa tutt’uno con la sostanza e con la verità. Ecco perchè, tra il 1931 e il 1932, Gadda scrive di guerra e di prigionia, senza però dare alle stampe il fisico libro della sua memoria che egli aveva confezionato in anni lontani, sincrono agli eventi. L’impossibilità esplicita si vuole, nella sua confessione, quaternaria: in una specie di furore sarcastico e apodittico dell’argomentazione, camuffato di urbanità e di buon senso. Quasi l’impaccio di voler dire, di voler far sapere e insieme di giustificarsi, senza che nessuno peraltro nulla pretenda. Quattro gli impedimenti dirimenti a che il diario gaddiano sia reso pubblico: presunta o sospetta retorica dei fatti eroici, o di audacia virile, del quale si dà conto; cose imbecilli contenute nel racconto e però ineliminabili da esso, pena una sorta di tradimento del testo; giudizi sui fatti e non solo nudi fatti; dolorosa parzialità della testimonianza:
1) registrazione di «banali miserie» e, «del pari», di cinque esempi di guerra guerreggiata: «Ma tutto questo è retorica, dice la gente di calamaio. Ma io vi avevo onestamente preavvisato circa la pessima qualità del mio sistema cerebro-spinale: il mio diario di guerra è una cosa impossibile» (Castello, RR I 136);
2) «Dico che mai non mi sono sentito umile, come soldato, ma orgogliosissimo sempre […] quando… quando… quando… quando… […]. Allora un fremito intenso mi pervadeva, una orgogliosa delizia, che anestetizzò l’anima, liberandola di dolori e ricordi, sciogliendola da ogni rimpianto, da ogni affetto. Come potrei scrivere queste cose imbecilli in un diario di guerra? Un diario di guerra richiede che uno sia un tipo un po’intelligente» (RR I 136-37);
3) «Accadde a me quel che mi accadde; ma, essendo io un retore, amo le scritture compiute e non amo gli edificanti stralci. Il mio diario di guerra contiene dei giudizi, esso è dunque impossibile» (RR I 141);
4) «Ho sofferto: orrendamente sofferto: e delle mie angosce il 99 per 100 lo lascerò nella penna: il mio diario di guerra è una cosa impossibile, ognuno lo vede» (RR I 142).
Cadenza ironica, shakespeariana (come, nel Giulio Cesare, «e Bruto è uom d’onore» sulla bocca di Antonio): ce l’ha forse con qualcuno di preciso? Come, poi, certamente accadrà nella polemica contro lo stereotipo dell’«umile fante»? L’impossibilità enunciata è poi, in definitiva, anche una risposta che Gadda da a se stesso. Isella ha segnalato (SGF II 1120), nel Fondo Garzanti di scritti e materiali gaddiani, un Quaderno di temi e di disegni di lavoro, dove si legge: «è meglio rinunciare a far una novella breve della storia della Friedrichsfestung – che merita invece più lungo svolgimento. – Ufficiale di cucina, guerra, ecc. / CEG, Milano, 8 gennaio 1929», e poi ancora una postilla inedita al prologo della Meccanica (RR II 1210), «Friederichsfestung [sic] fame per novella». Non ci sarà «novella» sulla prigionia in fortezza – la più dura, la più affamata: gli stessi tedeschi, va pur detto, erano impreparati a riunire, se non in campi di concentramento improvvisati, l’enorme, imprevisto numero di prigionieri italiani dopo Caporetto –, e neppure «più lungo svolgimento», e cioè, forse è lecito pensare, una specie di epos dantesco degli imprigionati. Progetto – più che semplicemente non realizzato – rimosso. Restava la guerra, e le ricorrenti tentazioni di scrittura da essa indotte.
Insomma, il libello del Castello di Udine non è affatto esemplato sul libro della memoria, integrale e segreto, formato dalla somma degli intatti diarî, ma persegue un suo diverso, tutt’altro che diaristico, progetto scritturale. E non è vero, come è stato scritto, che le prose militari del Castello «rielaborino» materiali dei futuri Giornali, e dunque dei passati taccuini. È una diagnosi infondata, che falsa il senso dell’uno e dell’altro libro. Certo – come è fisiologico in Gadda, scrittore, più che ripetitivo, ossessivo – qualche sintagma, certi fatti di lingua e di stile, e perfino qualche tenue episodio o dettaglio si possono utilmente mettere in parallelo. Ma non una delle grandi pagine, personaggi e azioni del Castello si potrebbe ritrovare nei taccuini.
A tal punto che l’operazione assume un valore tutto nuovo e piuttosto sconcertante: non di riscrittura, bensì di risarcimento all’indietro, retroattivo, della memoria. A riempire, postumamente, le lacune di allora: non, beninteso, nella fisicità intoccabile del taccuino («Quod scripsi, scripsi»), ma come a latere di quell’opera, perfetta nella sua eventuale imperfezione. Non dunque una materia bellica saccheggiata e messa a frutto nelle opere di poi, come una grande cava o serbatoio di temi dal vivo, ma implosione delle memorie di guerra sul loro punto d’origine, la cui forza di gravità, e dunque d’attrazione, risulta e perdura enorme. Questa particolarità di Gadda si presta benissimo a illustrare un caso teorico di primaria importanza: da una parte sincronia difettiva del diario, e, dall’altra, risarcimento postumo, esterno al diario stesso, della materia assente, ad opera di uno scrittore che vuol rispettare la sua storia pregressa sentita come difettiva, appunto. C’è un Gadda che, con animo e pietà di storico, rispetta con scrupolo il documento: anche quello che era stato prodotto da lui stesso soldato, quello di cui possedeva, per così dire, il copyright. Rispetto così tenace che condanna il tutto all’inedito. E c’è il Gadda prosatore, che insegue le sue ispirazioni e cede a tentazioni varie di scrittura. Uno scrittore dotato di animo meno morale avrebbe interpolato il se stesso antico con le emergenze del moderno, e pubblicato il tutto, contaminando. Gadda non interpola, sempre deferendo a quel tempo, a quell’unico tempo della sua vita transumana.
Esiste dunque – mi si consenta questa estensione metaforica – un Vecchio Testamento del capitano, allora sottotenente o tenente, e cioè i taccuini storici inediti. E c’è poi il Nuovo Testamento del Castello di Udine, che completa idealmente, con parabole insigni e là inattestate, quella scrittura antica, senza osare riscritture e metamorfosi, o azzardare varianti. Perché quella scrittura antica è, nella coscienza dell’autore, scrittura sacra, intangibile, di dolore e di morte. Ed è scrittura rimossa, se solo nel 1955 sarà in parte pubblicata; e nel 1965, poi, tradita e mutilata nel suoi referenti storici più riconoscibili.
A proposito di questa edizione einaudiana del Giornale, purgata ad usum Gaddae, va detto che sarebbe riduttivo vedervi soltanto una specie di reazione anafilattica, spropositata, alla protesta di Ambrogio Gobbi, che in una lettera privata a Gadda dell’autunno 1958 rimproverava scherzosamente l’amico autore di un suo, all’incirca, goliardico giudizio sull’«Ambrogiazzo», affidato quarant’anni prima a un privato taccuino (in data 18 luglio 1916, ora in SGF II 569). Gadda ne fu turbatissimo, in modi grotteschi ben documentati dall’editore (SGF II 1104-107), e decise di modificare tutta l’onomastica del taccuino. Perché tutti i nomi? e non, poniamo, solo quello di Ambrogio Gobbi, trasformato nel 1965, ad ogni buon conto, in Carlo Toffi?
Il fatto è che questo banale incidente rimise in moto nell’autore una serie di rimozioni e superstizioni ben più radicate, nella profondità della psiche, di quanto non lasci emergere una semplice, puntuale ammenda: Gadda, par lecito credere, acconsentì a ristampare nel 1965 il Giornale, nei modi che si è detto più sopra proprio per poter cancellare la precedente edizione di Sansoni parziale ma fedelmente esemplata (per quanto si poté e volle) sugli originali. Riedizione camuffata come implicita denuncia di un’opera rifiutata. Gadda si sarà confermato nell’idea che il suo diario era un’opera veramente impossibile.
Sono dunque in conflitto, sull’arco di oltre quarant’anni, diverse idee di libro, che non potrebbero essere confuse nella, pur doverosa, integralità di restituzione del documentato. L’edizione critica del 1992, in sé inevitabile, non annulla l’immagine che il Gadda memoralista volle dare di sé – nella sua carriera di scrittore – con la princeps di Sansoni nel 1955, e perfino, per quanto può valere il tardo ed esasperato scrupolo che la ispira, l’edizione einaudiana del 1965, incrementata e sfigurata come si è detto. Così, nella stampa integrale della pluralità dei taccuini, la prosa apologetica e narrativa La battaglia dell’Isonzo – Memoriale (s’intenda la dodicesima battaglia dell’Isonzo, quella sfortunata di Caporetto), è altra cosa, e altro genere di scrittura, dai vari Giornali.
Si noti del resto come l’autore abbia modulate, con scrupolo le sue epigrafi: Giornale di campagna quello del 1915 e delle prime settimane del 1916, perché Gadda non è ancora al fronte; Giornale e poi Diario di guerra per il 1916 e per la parte che resta del 1917, ben distinto dal Diario di prigionia; e poi, finita la guerra dell’Italia contro gli Imperi centrali il 4 novembre 1918, Vita notata. Storia, perché la prigionia di diritto, se non di fatto, è ormai conclusa. Anche le estreme parti di Vita notata, che si chiude il 31 dicembre 1919 – «Lavorerò mediocremente e farò alcune altre bestialità. Sarò ancora cattivo per debolezza, ancora egoista per stanchezza, e bruto per abulia, e finirò la mia torbida vita nell’antica e odiosa palude dell’indolenza che ha avvelenato il mio crescere mutando le possibilità dell’azione in vani, sterili sogni. Non noterò più nulla, poiché nulla di me è degno di ricordo anche davanti a me solo. Finisco così questo libro di note. Milano, 31 dicembre 1919. Ore 22. In casa» (SGF II 867) –, si aggregano a buon diritto alle pagine precedenti di vita militare, perché scritte sotto la stessa divisa: «Domani vestirò l’abito borghese, smesso 51 mesi fa e non più portato neppur per un’ora, e lascerò la mia cara divisa di alpino» (SGF II 865, 17 settembre 1919).
Quel che è doloroso assumere, per Gadda, è proprio il connubio, consumato nella sua esperienza di soldato, di guerra e prigionia: accoppiamento fatale ma non giudizioso, anzi infame beffa del destino: «Distinzione assoluta, nettissima, nella vita psichica del Ns. La guerra era sacrificio cosciente e voluto, la prigionia un male subito. Nessuna confusione possibile tra l’ardire e il patire» (Castello, RR I 177). Fu certo anche la prigionia patita, inseparabile dagli eventi registrati negli altri taccuini bellici, il freno interno che indusse l’autore a tenere inedite, per circa quarant’anni, le sue vecchie carte. La prigionia equivale per Gadda a uno smacco esistenziale assoluto, senza riparazione possibile nel corso di tutta una vita. Non soltanto per la rabbia, sempre cocente, della resa al nemico, il guasto volontario delle armi prima della cattura, e poi il disarmamento, la separazione dei soldati e specialmente il distacco forzato dall’attendente, il valtellinese Stefano Sassella di Grosio, «anima splendida e rara, devoto come gli eroi dell’Ariosto; piango come se avessi perduto mio fratello» (31 ottobre 1917): frase che non si può leggere senza sbigottimento, e che l’autore, rileggendo se stesso, avrà riletto, con disperazione.
Rabbia di prigioniero esasperata in lui, volontario di guerra, da una vergogna inconsolabile: dantescamente, per Gadda, «verecundia è una paura di disonoranza per fallo commesso», o per omissione presunta. Soprattutto per non aver potuto dare una prova di valore, tanto bramata, nella nebbia e nella confusione di Caporetto: collocato, con la sua 470a Compagnia Mitragliatrici del 5o Alpini, sugli avamposti – non però in prima linea, onde il suo cruccio – tra il Krasji Vrh (Monte Grande) e il Krn (Monte Nero), e dunque presto isolato dalla rapida manovra a tenaglia dell’esercito austro-tedesco, il 24 ottobre, tra Plezzo e Tolmino. E poi, ad accrescere lo sconforto, la cattura non già per mano degli austriaci, pluriennale nemico, ma ad opera degli ammirati e detestati tedeschi, ai quali solo da poco il governo Boselli aveva dichiarato guerra, d’intesa con gli Alleati: onde poi la prigionia in Germania. Trecentomila prigionieri e metà delle artiglierie perdute.
Nelle prose del Castello, la prigionia di Celle, dalla quale spesso Gadda meditò la fuga, è via via definita «immeritato castigo», «immeritata umiliazione», «caduta orrenda nel vuoto», «inanità mortale», «riva dell’inutilità: e io dovevo rimanerci», «Essere era disparire: sopravvivere significò non essere. Pensai, com’è perdonabile, pensai a mia madre» (RR I 153). E il prigioniero non è certo, nella coscienza dell’autore, un soldato che bene o male, pur tra disagi e fami, ha salvato la pelle: è un «essere nullo, perfettamente superfluo», «foglia morta che il vento della miserabilità può sbatacchiare dentro l’inverno, verso la gioia di tutti gli pseudo-Dostoiewski della madre terra e per la mia infinita e cruciale mortificazione» (RR I 171), abbrutito dalla fame. Prigionia è frustrazione di atti mancati, e gelosia di atti eroici che altri, intanto, libero di disporre del proprio destino, potrebbe compiere, e di fatto compie. È singolare (ma se ne vedrà una ragione taciuta) che, durante tutta la prigionia, si parli spesso di madre, sorella e amici, ma si menzioni raramente il fratello Enrico, di cui l’autore era stato pur così sollecito in tante pagine del diario di guerra.
Ma Enrico – almeno fino a una certa data – è sentito come uomo libero: aviatore alto, col suo aeroplano, sulle miserie quotidiane, su sangue e sterco, sulla vita da «porci in letargo» della trincea in seconda e in terza linea e sulle frustrazioni del campo di prigionia, in una sua sfida inebriante di coraggio. E Gadda prigioniero ridotto a sogguardare, prostrato, voli senza senso: «nuvole basse trasvolavano sopra i fari del campo, rotonde e livide: quasi a lacerarsi nel filo spinato: povere ombre uscivano con una scodella dalle baracche, verso la distribuzione del mangiare, ravvolte ne’ tetri mantelli. Le finestrette delle baracche si illuminavano, e noi camminare e camminare» (RR I 165). E poi ancora, poco più sotto, «Fuggenti sopra la gabbia non erano che nuvole perse, tetre, nere»: dove l’innegabile carduccismo delle immagini, del Carducci più scolastico (la nebbia che piovigginando sale, stormi d’uccelli neri come esuli pensieri) presta le sue parole a un’angoscia vera e diversa.
Affiora innegabilmente, nel silenzio amaro di queste pagine, la nostalgia e l’invidia del fratello maggiore Carlo Emilio, costretto all’inazione, nei confronti del cadetto aviatore. E perfino il livore deluso di chi s’era guadagnato sul campo solo (si fa per dire) una medaglia di bronzo, per le azioni compiute sul Faiti (18-23 agosto 1917). Enrico ebbe prima di Carlo la promozione a tenente, e come si legge nell’epitaffio dettato dal fratello per la sua tomba nel cimitero di Longone, fu «decorato di medaglia di bronzo e d’argento al valor militare»: «ci lasciò fanciullo e sorridendo volle il suo fato». Il tema del sorriso, del giovane che sorride, sarà sempre il segno di Enrico scomparso. La competizione di Gadda col fratello, sempre separato da lui su altri fronti, anche durante la prigionia è tremenda e disperata. Ma Enrico, a quella data, era già morto: caduto in volo il 23 aprile 1918. Carlo Emilio ne avrà notizia solo al rientro a casa, la mattina del 14 gennaio 1919. Aveva invidiato, per mesi, un uomo morto. Ragione, anche questa, d’immedicabile tormento. Soccorre in proposito la testimonianza di Gian Carlo Roscioni sull’angosciata reazione di Gadda alla vista della sovraccoperta del Giornale einaudiano del 1965: uno stupendo e cupo Caino e Abele di Anonimo caravaggesco, che nelle intenzioni dell’editore era denuncia della guerra per sua natura sempre fratricida, ma nella ricezione esasperata dello scrittore intollerabile, anche se spropositata, immagine del rimorso.
è inoltre da sapere che il trasferimento dal Carso all’Isonzo era stato sollecitato dallo stesso Gadda: destinato proprio alla zona di Caporetto, al cospetto degli alti monti, poche settimane prima della catastrofe. E anche alla «melma del Carso» era andato, a suo tempo, da volontario, lasciando le sue care montagne per inseguire un’atroce voglia di grandezza militare («al Carso ci sono andato spontaneamente, strappandomi l’animo al lasciare i miei alpini», Giornale, SGF II 833). Quello ai monti è dunque un ritorno, e un eroico proposito lo alimenta. Il Giornale non lo dice, ma dal Castello sappiamo che Gadda era posseduto dall’«idea di inoltrar domanda per i reparti d’assalto», esaltato dal «bronzino» della sua medaglia e dalla recente «promozione a tenente» (RR I 152): «combattere in montagna e in prima linea, sul fronte della gloria e del rischio, «Io che mi sono immerso con gioia nelle bufere di neve sull’Adamello» (SGF II 570).
Così il Giornale tace anche la circostanza, sempre ricavabile dal Castello, che Gadda rinunciò, poco prima di Caporetto, a una licenza-premio che gli spettava, in favore di un collega ufficiale: licenza-premio che di sicuro l’avrebbe salvato dalla cattura. Perché mai rinunciò a quel beneficio? Il Giornale, al solito, tace: solo registra, in data 21 ottobre 1917, nella parte del Memoriale, che «Favia del Core (quale fortuna!) ottenne la licenza ordinaria, che ancora forse non ha ultimata, e partì l’indomani, giorno 22» (SGF II 700). Ma l’altra scrittura (Castello, RR I 152) entra nei dettagli:
il comandante mi disse che aveva ricevuto ordini, per tramite, aggiunse, dei Comandi d’Armata. Questi ordini, che lo riempivano di soddisfazione, eran poi nient’altro che la mia licenza. Mi prospettò in pari tempo (e lasciava me giudice di decidere quel che credessi), mi prospettò la situazione d’un «collega», la cui mamma si era improvvisamente ammalata. Una cosa assai grave, una raschiatura all’utero [naturalmente la frase è ironica, designando un controllo medico di routine]. Oh! se fosse ora! Allora fui altruista come un ginecologo. Metà mi impietosii, metà non volevo lasciare il fronte. Il «collega» se ne andò a compiere i suoi doveri filiali e lo rimasi, a compiere i miei doveri inutili.
Non starò a dire quali implicazioni tormentose può aver scatenato l’utero dell’altrui madre nella mente di un autore così vulnerabile nelle categorie psichiche prime. Conta qui quell’affermazione caparbia: «non volevo lasciare il fronte». Le licenze-premio, concederà poi, «Son cose che, quando capitano, bisogna prenderle al volo. Ma la mia smania militare, verso l’autunno ’17, aveva raggiunto limiti demenziali […]. Il fatto è che non mi diedi nessuna premura della licenza. Venni trasferito ad altro reparto e il trasferimento mi portò dal Carso all’Isonzo, davanti al bastione dello Jàvorcek» (RR I 149). La cattura, dunque, e la conseguente prigionia si svolgono come esito ineluttabile di eventi irrelati, operato dal destino sugli atti ignari di un protagonista innocente, ma non totalmente puro nelle sue intenzioni: e dunque questa cattura è, proprio in senso classico e aristotelico, una tragedia, preparata da una serie di vanità e di gesti irresponsabili. Gadda dirà in altra pagina, di esser stato cieco: cieco come un Edipo senza colpa, incosciente di oscuri misfatti. Il Giornale tacerà anche un cruccio più segreto, che solo nel 1931 potrà essere confessato, pur se ancora in modo velato, trasparente solo per chi, come ogni lettore oggi, conosca nei dettagli la privata biografia di Gadda:
Alla stazione di Udine mancai persino a un incontro, fissato con persona che dovevo non più rivedere sulla terra! Per far presto, per arrivar prima!, dove ci fossero, nelle valli, cupi tuoni, fra il fumare delle nebbie autunnali. Ho scontato quella fantasia con anni di disperato rimorso, sono andato, come un cieco, al mio disperato destino. Perché dal castello di Udine, il luglio, avevo veduto le Alpi di Carnia, vetrate, e il lontano corruccio di Monte Nero: bianchi e rotondi dentro il cobalto, cumuli di nuvole incoronavano il grigiore vetrato dell’Alpe, screziata delle sottili sue vene, come ghiaccio, come cristallo. «O ce biel, o ce biel sischiél in Udin!». Gli alpini dell’ottavo cantavano la vecchia villotta: e il canto si dilatò solenne: religioso corale di giovinezza. (RR I 150)
Nella polifonia del racconto, Gadda non è solo un personaggio di tragedia: è beffato e tradito dal destino, come in un’atroce commedia d’intrigo. Era andato, come dice bene il suo titolo, dal castello di Udine verso i monti, che da sempre, nel sistema mitico dell’autore e nella pratica della guerra, erano il luogo per eccellenza dell’azione eroica, lo scenario di un ardimento elevato sopra le meschinità della palude e del fondovalle: «E i miei sogni eran là, dovunque si levassero i bastioni dell’Alpe, onnubilati di minacce nere, diademati di folgori». Quei suoi monti così a lungo desiderati, le Alpi Giulie dell’estremo bastione orientale, che nel nome ricordavano fasti romani, l’avevano tradito proprio all’apogeo delle sue speranze di rivincita e, per altro verso, proprio nei giorni in cui Gadda scriveva: «La fine della guerra, che si dice prossima, mi fa grigie queste ore, con il pensiero che la parte eroica della mia vita è ultimata» (5 ottobre 1917). Si isola nel Racconto come la riscrittura di questa delusione, e del nome stesso del Monte Nero (Krn), drammaticamente rietimologizzato:
I monti già neri le parevano enormi pietre collocate durante una notte lontana sopra giovani vite, perché tutto fosse dimenticato e sepolto: ed i superstiti non credessero che in un cupo dolore e in un odio, e si sentissero schiavi e imprecassero, come schiavi dannati. Anche i monti! E gli alberi dovevano mormorare tristezze, tristezze. Gli uomini dovevano dunque bestemmiare, e per forza, dovevano essere sporchi: nere mani, grosse voci, capelli tinti dai grumi della fuliggine. (SVP 497)
Un Gadda perduto nell’inerzia e impedito di riscatto. Anche la sua identità di ufficiale degli alpini in prigionia si scolora, insidiata dal torpore e dalla fame. Un episodio emblematico di questa perdita umiliante è provocato dall’omonimia con un tal Carlo Gadda, soldato di fanteria, in vece del quale Carlo Emilio riceve, e alla fine decide di trattenere per sé, i poveri pacchi di viveri, vanificato il tentativo di ritrovare quel poveretto:
Tra i pacchi ch’io ho ricevuto, mi sono stati recapitati due di pane, della Croce Rossa di Milano, indirizzati a un soldato Gadda Carlo del 1550 Fanteria, per evidente errore dell’Ufficio di Smistamento, che credo sia a Francoforte sul Meno. Io, che avevo respinto a Rastatt il primo di questi pacchi, me lo vidi arrivar qui, come un inseguitore; allora lo ritirai, pensando che non sarebbe più giunto al destinatario. Così feci per il secondo. Di ciò porto rimorso; sebbene certo i due pacchi non sarebbero mai giunti al povero soldato, che non si trova nel Campo. L’integrità assoluta esigeva ch’io li respingessi, anche se fossi certo che se li sarebbero mangiati i tedeschi. Ciò farò senza dubbio, se la cosa dovesse ripetersi. Ricordo ancora che il soldato non è del Campo; chissà dove sarà mai. (Giornale, SGF II 787)
Un episodio questo, compiutamente gaddiano, per quel misto di commedia (lo scambio delle persone, l’omonimia) e di tragedia, e di scrupolo assillante, che sono i canonici ingredienti del grottesco dell’autore. Di lì a pochi righi, Gadda annota: «la prigionia distrugge in me ogni fonte di alterezza d’uomo e di soldato». E poi i vani pensieri, «desiderio dei miei soldati; sogno della trincea». Sul Monte Grappa, chiave di volta del sistema difensivo sul Piave, dove la battaglia fu aspra specialmente tra il 13 novembre e il dicembre 1917, e poi ancora nel giugno del 1918 e nel finale della guerra, naturalmente Gadda non combattè mai. Ma:
Pensavo allora, sul Grappa, le schegge pazze della battaglia, i controassalti furenti: in una forma di delirio sognavo, vedevo, volevo vedere! Veder le granate a smontare pezzo per pezzo le corone delle trincere sopra le quote bruciate e i compagni andare, sapendo, sul monte! Avevano tre limoni, baionetta alla mano, magnifiche folgori davano a loro il lor senso e quasi una transumana vita: e volevo imitarli e seguirli, dal soglio dell’opere prese altri monti vedere, altre schiere avverse, altro fuggente paese. Fuggenti sopra la gabbia non erano che nuvole perse, tetre, nere. Camminavo e camminavo, fagotto di cenci, sulla strada buia dell’eternità. (Castello, RR I 165)
In questo caso il delirio, la proiezione di episodi, già veramente vissuti nel passato, in un futuro negato, surroga l’assenza d’azione: «Così la morte e la vita lo respingevano con ribrezzo», scriverà in Racconto (SVP 582). E in altro punto, con chiara suggestione shakespeariana: «Per atti e per parole è la vita degli uomini. Quanto ai pensieri che essi combinano, il più delle volte sono soltanto parole» (SVP 547).
Mi resta ancora almeno un impegno da onorare, e cioè la dimostrazione che la materia del Castello di Udine è, nella sua sostanza, un’integrazione postuma dei taccuini superstiti: difettiva sincronia da risarcire, s’è detto. Il che in parte contrasta con quanto sostiene l’autore: «Queste cose le scrivo e stampo perché possano arrivare dentro l’anima, un giorno!, di qualcheduno, che abbia lume di memoria e di cognizione e, se Iddio voglia, capacità di giusta elezione. So che mi metterò contro la gente: ma non iscrivo per me, scrivo perché salti fuori qualche cosa che possa valere a farci più forti e più avveduti in ogni futura contingenza, nelle distrette del male» (RR I 135).
E invece il Castello – lo stesso si potrebbe dire per le parti al fronte dell’incompiuta Meccanica (stesa nel 1928, edita nel 1970 e, con il necessario rigore, solo nel 1989) – fu per Gadda anche uno scrivere-per-sé, atto d’ammenda e di compensazione interna del non-detto, o almeno del non-potuto-dire, anche oltre le convenienze narrative delle opere singolarmente considerate. Naturalmente per l’autore, per quanto egli concede ai suoi lettori, le ragioni accreditate sono molto più semplici: «Il modo d’essere del mio sistema cerebrospinale durante e dentro la guerra fu cosa a un tal segno lontana dalle comuni, che credo possa giustificare il tentativo d’un breve resoconto materiato di fatti» a cui «si uniscono e si aggrovigliano» i preesistenti complessi, «cioè l’insieme delle mie cinquecento disgrazie, ragioni e irragioni»: «mi studierò d’esser breve e di non tuttavia trascurare i più bei motivi, o almeno i più significanti, della mia catastrofica sinfonia» (RR I 134), immaginosa definizione delle prose belliche fuori dei Giornali. Leitmotive di una sinfonia catastrofica – la parodia di Eroica, Pastorale, Patetica, Incompiuta e simili è evidente (e soprattutto di Eroica): si sa come Beethoven fosse uno del grandi miti e modelli sentimentali della giovinezza –, che sono piuttosto i paralipomeni di un racconto lacunoso: «Oh questo è il destino di tutti gli autobiografi. È accaduto anche a me. Quando la loro vita è seduta sopra una seggiola, nella vecchia libreria, notano le più tenui vicende della sua trama: quando la loro vita vive tra le fumanti battaglie non possono notar nulla, hanno altro a cui pensare» (Racconto, SVP 511). Di qui la postuma ammenda.
Le prose del Castello sono talmente affrancate, per l’invenzione, dai taccuini di guerra, che quando operano un puntuale, e quasi unico, rinvio a questi, la ricollazione lo rivela impreciso: «Ho dunque annotato nel mio quaderno anche le banali miserie: alle giornate, per me atroci, dell’ottobre ’17, quelle che furono la caduta del mio vivere in una vana e disperata sopravvivenza, il mio giornale registra un buon bagno dei piedi fra le sopravvenienti angosce e la muta ottusità delle nebbie: finalmente avevo trovato un paio di gavette d’acqua» (RR I 135). Sennonché, di questo pediluvio a Caporetto, nei quaderni non c’è traccia, anche se la notizia, come ci si aspetta dalla moralità assoluta del testimone, non è inventata: di un pediluvio, approntato dall’attendente Sassella, si dà conto in data 21 ottobre 1917 (SGF II 701).
Passiamo ora in rassegna, tratto dopo tratto, le prose belliche del Castello di Udine. La prima delle cinque prose, Elogio di alcuni valentuomini (Gadda 1931n), è anche la più franta (non meno di diciotto sequenze, se ho contato bene), piena zeppa di memorie scolastiche assimilate in un buon liceo milanese: dove l’urgenza del ricordo bellico affiora in modi ancora troppo allusivi e reticenti, nei righi di sapienti parafrasi per lo più liviane e oraziane, o dall’amatissimo Cesare. È una specie di ex-voto consacrato all’educazione classica dell’autore, corroborata a suo tempo con molta sollecitudine dalla madre: quasi una prova adulta di quei Commentarî cesariani vagheggiati da fanciullo.
In Impossibilità di un diario di guerra (Gadda 1931o) si prendono in conto i «fatti bruti» come assai più «discriminanti delle cose reali» di quanto non siano le facoltà nobili dello spirito, pensiero, e volere. Ebbene, qui, germi di episodi, sensazioni e umori tendono alla condizione di prosa lirica, o si dica pure studio solariano, o petit poème en prose: ma nel suo senso primo e più illustre, baudelairiano, sottratto alla moda del bello scrivere, del calligrafismo fiorentino di moda. Questo brano, ad esempio, che è forse il punto più alto:
Certo che la stanchezza, la fatica, l’ebetudine, la macerante attesa, e poi le atroci esperienze, l’odore di interi reggimenti accatastati ad aspettare il destino, e quei volti destinati allo spasimo, di quegli uomini che sbranavano del manzo malvagio nell’ultimo sole della lor vita, e inutilmente degluttivano l’ultimo pane, certo tutto questo non era fanfara d’orgoglio. Né il lamento degli abbandonati su da le forre paurose, tra le due linee; né l’odor funebre, a ventate, sulla scheggiata groppa del monte; né i cenci, né il sangue, né le mosche verdi d’attorno l’orrida turpitudine della morte: né il sibilo dei pronti colpi lungo gli orecchi, né lo schianto atroce di quegli altri, che arrivavan da via. Tutto questo non è orgoglio: è anzi un frego dato sull’orgoglio. (RR I 137)
Ma si tratta qui veramente, in senso proprio, di una prosa di diario, e insomma di una riscrittura fatta à la manière dell’antico soldato di una volta? o non è questa, invece, una tirata da tragedia shakespeariana, per quel misto di sublime e plebeo in un affresco smisurato? o un’ode lirica messa in prosa, un’orazione funebre nella sua tradizione più alta, e dunque barocca? Viene in mente, qui, per l’accumulazione affannosa, una strofe del Cinque maggio manzoniano: «E ripensò le mobili | Tende, e i percossi valli, | E il lampo de’ manipoli, | E l’onda dei cavalli, | E il concitato imperio, | E il celebre ubbidir». Gadda travolge i generi e le loro convenzioni: la materia sarà anche guerresca, i ricordi saran quelli del signor tenente, ma lo stile epico-lirico ne fa un evento assoluto, Giudizio universale di un’umanità rassegnata o disperata: certo votata alla sconfitta. Dal diario puntuale di singole miserie, a una cognizione cosmica del dolore: promozione dei ricordi dal contingente all’assoluto.
Pura avventura di guerra è invece l’episodio che si consuma sull’Adamello, e in particolare sulla vedretta della Lobbia, nell’aprile 1916. Nel Giornale non ne resta traccia, perché il fatto era accaduto durante la sospensione del diario decisa dallo scrittore: «Mi duole solo che quella soluzione di continuità nelle mie note, fino al 3 giugno 1916, comprendesse il periodo del mio servizio sull’Adamello (Ghiacciaio del Mandrone e della Lobbia) che è un bel tratto della mia milizia» (SGF II 646). Si tratta della duplice corvée sulle rocce innevate e sul ghiacciaio, due volte nove ore di montagna, eseguita da Gadda al comando di due diverse compagnie alpine, a cui era stato dato l’ordine di portare, oltre i tremila, proiettili di cannone e munizioni. Prima di toccare il secondo traguardo, il sottotenente Gadda che, a norma di regolamento, è in coda alla fila, s’accascia esausto sulla neve e si rintana nel ghiacciaio «fra bluastre caverne». Sono ore di pura ascensione e fatica, le famose ore di «felicità» della guerra gaddiana, e a questo titolo vengono recuperate e rese pubbliche dallo scrittore. Altra azione affine – sempre sull’Adamello, che fu teatro di imprese tecniche di eccezionale difficoltà nella storia militare; relegata in nota, ma poi ripresa all’inizio della prosa successiva – è il trasporto da Temù fino al Rifugio Brizio del pesantissimo cavo della teleferica Rifugio Garibaldi-Brizio: «Lungo 900 metri all’incirca, occorsero 100 uomini a reggerlo, come in un’immensa e pesante cordata. Vetrato e rigido, tagliava le mani, lacerava le vesti in sulle spalle. Ardue difficoltà nell’ultima e precipite rampa, sotto il passo. Ghiaccio, tormenta, temperatura. (Aprile 3000 metri)». E questa volta, come è evidente, non di racconto lirico si tratta, ma di un foglietto additizio, vergato à la manière di una pagina di diario.
In Dal castello di Udine verso i monti, sono almeno tre i tratti memorabili, oltre a quanto si è già anticipato su certe circostanze della vita militare di Gadda. Anzitutto quello sulla testa di ponte italiana di là dall’Isonzo: «una sola!, deprecava un caporale, che nella vita civile era fattorino della ditta di trasporti Fratelli Gondrand». I fatti gli diedero ragione, e si vide come un solo varco non bastasse allo sgombero di uomini e mezzi, dopo la rottura del fronte: a ciò si aggiunga la «brillante idea», noterà Gadda, di aver fatto «brillare» troppo in fretta i ponti. Il secondo tratto è quello che narra del giovanissimo ufficiale portaordini, «bersagliere irrefrenabile, stregato di mobilità», che saltando giù dalle balze del Monte Lémerle si burla delle cannonate, schivandole audace come un garzone di lattaio le «pompose matrone dalla dignità sistematica». E infine il quadro di un altro ufficiale (è infatti armato di pistola), «quasi un fanciullo», incontrato a quota 309 del Faiti:
Sedutosi, appoggiò il capo sul palmo sinistro, la mano armata la lasciò sul ginocchio, pareva un poeta fra le rovine, in una calcografia wertheriana. I fumi nitrici, nel mezzogiorno, lo indussero in un lieve tossire, decorosissimo, come un po’ di raucedine d’una persona ben educata […]. Ma il suo pensiero, lo sentii, andava disperatamente profondo, e più disperatamente lontano; quasi l’angoscia di un bimbo, muta davanti la solitudine. Gli uomini lo abbandonavano!
Gadda lo ritroverà, poco dopo, morto: «Oh! non posso dir come né dove, dopo alcuni minuti, rividi il suo volto: dico soltanto il suo volto!». Naturalmente la chiave dell’episodio è «wertheriana», appunto: l’ufficiale giovinetto si è suicidato in prima linea, travolto da una sua delusione o angoscia senza speranza. Anche questo è un personaggio che, come gli altri, invano si cercherebbe nei Giornali, perduti, per questa parte, nelle giornate di Caporetto. Si dava conto, invece, nel Giornale di campagna di un ufficiale napoletano, il sottotenente conte Gaetani d’Aragona, collega di Gadda, suicida per amore con l’amica, «figlia del ministro d’Olanda a Roma», durante un congedo.
Compagni di prigionia è il solo testo per cui, con le debite cautele, si potrebbe forse parlare di riscrittura: sennonché, a parte i personaggi storici fissi di Ugo Betti e di Bonaventura Tecchi (ma anche Anguissola e Raspaldo sono conservati come tali, riconoscibilli nella loro identità anagrafica), tutti gli altri compagni di prigionia della baracca 15 (sono elencati in SGF II 803-07) assumono identità velate, o diventano senz’altro maschere di una commedia dell’arte, mista di più caratteri e poliglotta: c’è il bergamasco, il bresciano, il siculo-milanese, il romano e altri. Baracca 15 C sarà anche il titolo di un tardo libro (1961) di Tecchi, al quale, si rammenti, è dedicato il Giornale fin dalla sua prima stampa sansoniana, con la lusinghiera epigrafe «ricordando la sua fermezza nei giorni difficili».
Più di tutti indimenticabile è il tenente Chitò: l’ombra più tragica e alta delle pagine gaddiane di prigionia a Celle, e ospite dunque non già di questo primo volet, di tono farsesco ed elegiaco (le poesie di Betti), bensì del secondo e ultimo, di stile tragico, che sotto il titolo, deviante, Imagine di Calvi, prolunga il racconto. Forse è un titolo d’autore coatto, dato che Compagni di prigionia e Imagine di Calvi uscirono sull’Ambrosiano rispettivamente il 15 gennaio e il 12 febbraio 1932: ma l’Italia e i lettori milanesi di allora, reduci tutti dalla guerra vittoriosa, di sicuro non avrebbero gradito troppi racconti di prigionia, uno di seguito all’altro: il nome eroico, notissimo, di Attilio Calvi, che di fatto occupa solo il finale, serviva a mascherare a fini di decoro esterno la diversa sostanza del resto. E che di due volets di prigionia si tratti lo indica anche, senza soltizione di continuità temporale, l’attacco di Imagine, «Trascinai verso dove sapevo le scarpe senza più suola».
Calze piene di buchi, e dopo quaranta giorni a brandelli; viaggio di cinque giorni verso il luogo di concentramento, trenta ufficiali stipati in un vagone merci; due fette di pane, cinque marchi l’una, divorate di nascosto nella latrina di Rastatt; le immagini dantesche suggerite dal sito della caponiera 17: tutto ciò si ritrova sia in Imagine, sia nel Giornale vero e proprio. E così sarebbe istruttivo comparare la scena delle «immondezze superstiti», rovistate alla ricerca di qualche frustolo di cibo, torsoli e bucce di patate, nell’uno (SGF II 685, 687) e nell’altro libro (RR I 167): forse la tangenza più estesa. Ma la sostanza di Imagine è tutta nuova rispetto ai precedenti: «Non voglio più scrivere; ricordo, troppo» (18 gennaio 1919, SGF II 850), si registra nel diario appena appresa la morte del fratello («sempre Lui nella mente e negli occhi, raccolto disperatamente intorno alle manovre del suo acroplano»). Gadda potrà nuovamente scrivere di guerra quando la scrittura sarà risarcimento e non semplice ricordo, compiuto exemplum epico e non pura vita vissuta.
E allora, solo a quel punto, potrà emergere dall’ombra un collega ufficiale «insegnante di francese, territoriale dai baffi, temperamento di ginevrino», titolare di «una fantasmagoria di congiuntivi inverosimilmente circonflessi» e di una sicura fede pacifista: inviso all’autore, ma non a tal punto da meritare, a suo tempo, uno degli «sfoghi di rabbia» (SGF II 650) consegnati al Giornale. E così manca, nei quaderni, la scena improvvisa del prigioniero che sfoggia mutande e camicia da donna, raccattate fortunosamente nei giorni della rotta. E poi, come s’è detto, le pagine strazianti sul tenente Chitò – Pietro, secondo l’indice dell’edizione garzantiana – ferito al polmone e destinato a sicura morte, ma dignitosissimo e inflessibile, alle soglie dell’ombra, nel dedurre i suoi eleganti matemi; ferito al polmone da una «pallottola»: come tanti altri, i più, dalla tisi. E poi la non narrata (a suo tempo) impresa degli alpini del battaglione Val d’Intelvi, sagome nere sulla neve per la fucileria nemica, lanciati in un eroico quanto insensato assalto (RR I 173-75 e 178).
Infine, la «voce di un bergamasco» udita in prigionia richiamò alla mente allora – assicura lo scrittore –, e richiamerà sempre, nella fissità temporale di Imagine, quella del tenente Attilio Calvi, incontrato dapprima a Temú e poi, supino e ferito a morte, al passo Brizio, «ideale imbocco dei destini glaciali». Quello di Calvi è, per eccellenza, tema di silenzio: occhi calmissimi e cèruli, «piccolo e privo di parole», «brevi parole di occasione», oppure di una laconicità aspra, fatta di frasi in bergamasco: «Cosa devo farmi coraggio, che non posso neanche respirare», replica alle vane parole di conforto portegli dal cappellano; «Le mie labbra, dopo quella risposta, non ebbero una parola per il morente. Lo guardai a lungo, senza osare dir nulla, mi ritirai» (RR I 176). Suo fratello, l’altro Calvi, che a sua volta cadrà in guerra, adempiva intanto «in quel momento, come in ogni momento, ai suoi doveri militari: a pochi chilometri, sotto le difese ultime del nemico». L’incrocio dei destini fraterni, che si rivela difettivo nel reduce sconfortato Carlo Emillo, s’intreccia al caso dei fratelli Gadda: non dunque vite parallele, ma istanze d’idendità sognata. Nonostante l’unificazione operata dall’indice garzantiano (che inoltre non registra il nome del fratello di Attilio, alpino sull’«eccelso Adamello»), non sarà però Attilio, che era bergamasco, il sottotenente Calvi incontrato a Edolo il 3 novembre 1915, «figlio del locale gerente la succursale della Banca S. Paolo» (SGF II 487). Con lui, singolarmente, Gadda aveva discorso a lungo di Enrico.
In prigionia, Gadda aveva scritto che, oltre la fame, la sofferenza per la patria e la famiglia, «il dolor bestiale, il macigno che devo reggere più grave, la rabbia porca, è quella, che già dissi: è il mancare all’azione, è l’essere immobile mentre gli altri combattono, è il non più potermi gettare nel pericolo, ch’ero venuto ad amare sopra ogni cosa» (SGF II 796-97). Gli sembrava di aver toccato il fondo. Sotto quella stessa data, 21 luglio 1918, l’ultima menzione di Enrico, in prigionia: il cui nome, per sei mesi, fino alla crudele rivelazione del vero, non sarà più menzionato nel Giornale: «Dall’Italia e da casa buone notizie, fino al 25 giugno. C’è mio fratello, che mi tiene in ansia». L’ultima lettera di Enrico che si registra tra la posta ricevuta è rubricata sotto il 22 gennaio 1918. Dunque è un caso di rimozione: di Enrico, a un certo punto, non si parla più, perché, dal silenzio epistolare, se ne sospetta o teme la morte. E così, dopo Caporetto e la prigionia, il destino gli riserva un dolore più grande:
Un anno fa stavo per partire da Celle, per lasciare la baracca 15, l’odiato campo, lo squallore della sabbia e delle brughiere e la tortura della reclusione. Stavo anche per incontrare il più orrendo dolore della mia vita, quello che ha superato per l’intensità il tragico 25 ottobre 1917, che si è fuso con questo in una sola onda di atroce agonia. (SGF II 867)
In quel 25 ottobre, nero presagio, «aeroplani italiani […] mi davano un ultimo addio (ero già prigioniero) e svanivano con la luce al di là della montagna verso Ovest». Per districare quel nodo, per riaprire il libro chiuso della memoria – con intento meno circostanziato, e già sublimato dall’esemplarità – non basterà però il Castello di Udine. Solo nella Cognizione del dolore – distaccandosi dalle ragioni della guerra immediata, e perfino dalla Brianza boreale (l’unica che figuri sull’atlante), deformata da una lente grottesca – il capitano reduce rappresenterà sotto il nome di Gonzalo «reduce senza endecasillabi», il dolore dell’esistenza nella sua globalità: dolore cosmico e profondo, congenito e senza vere ragioni contingenti: dolore oscuro, oltre gli accidenti della vita vissuta e di un assillo puramente autobiografico. Così i pezzi del capitano – resi alla loro quiete, una volta pagato il debito ai monti, agli alpini, alla madre – si ricomporranno in un testamento più alto, in una compiuta tragedia di senso universale.
Université de Genève |
Published by The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS)
ISSN 1476-9859
© 2002-2025 by Guglielmo Gorni & EJGS. Previously published in M.A. Terzoli (ed.), Le lingue di Gadda (Rome: Salerno Editrice, 1995), 149-175.
artwork © 2002-2025 by G. & F. Pedriali
All EJGS hyperlinks are the responsibility of the Chair of the Board of Editors.
EJGS is a member of CELJ, The Council of Editors of Learned Journals. EJGS may not be printed, forwarded, or otherwise distributed for any reasons other than personal use.
Dynamically-generated word count for this file is 9819 words, the equivalent of 29 pages in print.


