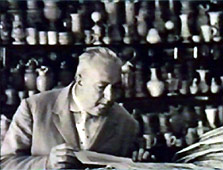 |
I titoli di Gadda
Walter Pedullà
Il giornale di guerra e di prigionia (1955, ma 1915-18)
I tre sostantivi della sua vita e della sua arte. Giornale, guerra, prigionia. Dal diario della propria vita una narrativa ad alta percentuale di autobiografia. Raccontare ciò che ha visto e sentito, con molto sentimento. Brucia il risentimento. Sotto il fuoco di nemici reali o immaginari. Sempre in fiamme. Come se fosse successo oggi, anzi in questo momento. Detto così, a caldo, sarebbe potuto piacere a un vociano. È questo un espressionista? Un cattivo soggetto. Sempre in guerra, cogli austriaci e coi militari italiani, nonché coi borghesi; coi superiori e con le classi inferiori: povere vittime della dissennatezza propria e dei generali! Ma c’è anche altro, c’è uno che urla dall’interno. Il prigioniero tenta di uscire dalla nevrosi: lo incatena. Ha ragione a prendersela con la madre o è pazzo? Se Gadda fosse stato saggio, sarebbe mai diventato il grande narratore che è? Quanta energia nella camicia di forza che è un romanzo di Gadda. Forse è un simulatore questo demente. Una sapiente finzione il linguaggio del pazzo. Artifici per essere più naturali. Viene naturale chiedersi: il diario è un libro? Ogni libro gaddiano è un giornale? C’è guerra tra i critici. Alcuni sono prigionieri del luogo comune: Gadda non sarà mai un romanziere. È un mito. Liberiamo Gadda dalla prosa d’arte. Non lo tollerebbe la vita di questa infelice creatura.
Le bizze del capitano in congedo (1981, ma 1918)
è falso che Gadda sia andato mai in congedo. Metaforicamente parlando. In pratica sì magari, ma nella sua mente non c’è pace che tenga. L’ufficiale è convinto d’essere diventato bizzoso da quando si è congedato, ma anche prima era molto nevrastenico, irascibile, furioso. Potesse essere freddo e dissimulatore! Starebbe meglio coi nervi e verrebbe meglio la letteratura. Si faccia una bella confessione (bellissima in verità non è), si scriva quel che viene in mente (meglio se c’è la memoria). Com’era felice in guerra! E in pace? Non c’è pace per il combattente. Solo in guerra, sola igiene, se non del mondo, del suo cervello. Carattere involutivo. Lì c’era un nemico visibile, il bersaglio era chiaro: l’avrebbe abbattuto. Ora invece si spara su tutto e su tutti per futili motivi, ma abbattuto è sempre Gadda: tranne quando urla. Spari a salve ma, se la ferita è aperta, basta la polvere a farti urlare. Ti arrovelli contro avversari inesistenti o nascosti. Qualcuno fa del cecchinaggio dal tuo interno, dal più profondo te stesso. Verrebbe voglia di congedarsi dalla vita per questo male invisibile.
Racconto italiano d’ignoto del novecento (1983, ma 1924-25)
La parola è detta. Ecco cosa scriverà. Il racconto è la sua vocazione. L’Ingegnere sarà un narratore e vincerà un premio. Viva i premi letterari, tengono in vita chi sta morendo di fame o quasi. Perciò Gadda scrive un romanzo. Resterà incompiuto: quando si dice il destino. Forse per scaramanzia lo chiama racconto. I racconti infatti Gadda li finisce a regola d’arte. In questo romanzo di formazione un irregolare tenta di comporre un’opera narrativa. Prima o poi questo esordiente, da milite ignoto della letteratura, andrà a diventare un celebre romanziere nel Novecento.
Attenti alle date, non perdete di vista la storia, bisogna raccontare il proprio tempo, l’Italia uscita a pezzi dal fascismo. In laboratorio, in laboratorio! Bisogna essere assolutamente contemporanei. C’è il fascismo, ci sia il ritorno all’ordine: è tempo di edificare: ricominciando dal romanzo. Se è necessario, si faccia La Ronda a difesa del buon italiano. Gadda però ancora non tira fuori la sua biforcuta lingua contro l’italiano dei benpensanti. Non è ancora nata la miscela linguistica esplosiva di Gadda.
Ma il romanzo va in mille pezzi. Raccogliete quelli di teoria del romanzo. Sono migliori quelli di Teoria della prosa di Sklovskij? Anche Gadda prepara la mossa del cavallo: darà scacco matto a tanta narrativa del Novecento, scattando e gettando dal cavallo ogni dannunziano. L’animale più intelligente è un mulo, un incrocio naturale. Gadda li farà innaturali ma così si va più veloci. All’uopo tenetevi pronte cinque maniere umoristiche di raccontare e qualcuna potrebbe funzionare. Sennò inventatela. Non ha inventato lui l’ars combinatoria. Gadda non è un gesuita, non è del Seicento, non ha ancora trovato la combinazione con cui arrivare al proprio segreto. Il romanzo viene sbranato. E i frammenti sono sparsi in tanti altri libri. È carne viva e palpitante ma non regge lo scheletro. Urge una nuova struttura del romanzo. Lo pretende il Novecento. È però ignota al nuovo narratore. Che fare? Ci deve pensare il romanziere, se vuole essere noto e vincere il premio Bagutta. Prima o poi arriverà la vittoria che premia tutti i sacrifici di uno scrittore sempre in guerra con le parole e con le idee.
Meditazione milanese (1974, ma 1928)
Non si tratta di filosofia provinciale. C’è metodo in questo discorso che a qualcuno sembra folle. L’ha sentito un medium, cioè un critico: ci batte più d’un colpo lo spirito di Cartesio. Lo stile è bertoldesco, è molto spiritoso, alta gradazione di pensiero con linguaggio basso. Si sente l’odore del vino come in osteria, ma lo scrittore non parla da ubriaco. Gadda non è un cacasenno. Gli uomini, secondo lui, non ne hanno abbastanza da buttarlo via. Non è una meditazione milanese, l’ha pensata anche a Firenze e a Roma, nonché in Argentina. Quell’aggettivo così perspicuo è una metafora? A Milano si pensa così. Le idee vengono meglio se si parte da terra, dalla propria terra. E allora diciamolo: questo lombardo fa meditazioni più elevate di tanta filosofia italiana. Così pensano i lettori del saggio gaddiano. Che ora si domandano: i poeti sono pensatori più grandi dei filosofi di professione? Questo lo dicono i lettori di Leopardi, che usava un linguaggio più aristocratico di quello di Gadda. In Meditazione milanese c’è un disegno – è evidente, sulla copertina del libro postumo –, ed è pure una poetica. Attenti agli spigoli del poliedro che il milanese accampa in una pagina. Sono davvero acuti i pensieri di questo ingegnere. Non sarà messo agli angoli da nessuno. Se non gli altri, Gadda ha pungolato se stesso. Gliene è grata la sua dilaniata, e dopo meditazione, ricomposta narrativa.
La meccanica (1970, ma 1926-29)
Serve il genio lirico espressivo ma che ci fai se non hai la tecnica. Si possono compiere miracoli con l’infinito presente. C’è del futurismo? Ha problemi di dinamica la macchina narrativa. La ruota sembra quadrata. È il cubismo? Guardate sulla faccia opposta del lato del cubo. La forma e la sostanza di un oppositore. Non sono poemetti in prosa. Quanti conigli (vanno in guerra quasi solo i poveri) in questi cilindri. È nato un grande clown. Nasce l’acrobata della parola. Talvolta si procede a singhiozzi (piange la solita madre) ma spesso si ride. Combaciano perfettamente il motore di Paolo e la carrozzeria di Zoraide. Si prende la scossa. Gadda non ha ancora fatto il pieno, consuma parecchia benzina per i primi episodi, resta a secco nei capitoli finali, e la macchina si ferma. Ci ha lasciato se stesso dentro. Coi pezzi di ricambio usati comincia a montare altre macchine. Ci si possono fare accoppiamenti giudiziosi, ma questo è il primo bel romanzo dell’Ingegnere. Il romanzo è in guerra con Gadda, scrittore interventista e antisocialista. Perché questa macchina che sembra perfetta è in panne prima che finisca il viaggio? La meccanica lascia una scia. Non appiccicate i capitoli pubblicati postumi. Il non finito, l’infinito. Il sistema ha le porte aperte. Tira un forte vento dalla periferia. Soffia il dialetto veneto di Zoraide. Uno schianto. Urge fare marcia indietro: lo impone il romanzo al suo autore. Chi ha ragione? I socialisti, risponde il romanzo all’esterrefatto Gadda. La polifonia le ha suonate alle sue idee politiche. Vince sempre il narratore nascosto.
Il castello di Udine (1934)
Proteggete i confini, innalzate castelli contro il caos e la dissennatezza. Il narratore come poliziotto. In difesa delle patrie lettere. Non bastano i documenti: come osano questi barbari parlare in dialetto dentro il territorio nazionale? Non si abbatte così l’alta costruzione di Petrarca. E Dante? I poveri stanno malamente. Un napoletano sul Carso? Quasi La paura di De Roberto. C’è anche panico a quella quota. Che silenzio nelle segrete! Il prigioniero non si vede, e per ora si sente poco, forse è rassegnato. Qualcuno però canta, il narratore è lirico. Non è un trovatore, ma è alla ricerca di se stesso. Chi abbassa il ponte levatoio? Si vuole comunicare. Non con le avanguardie.
Bisogna frenare il magma, dare forma all’informe. Una roccaforte per un soggetto debole. Non è ancora caldo l’olio bollente della prosa gaddiana. È scritta guardando dall’alto. Ora però tocca scendere in pianura, a valle, in linguaggi più bassi. Ci sarà Caporetto ma anche la rinascita. Qui nasce ufficialmente la narrativa del sottotenente Carlo Emilio Gadda, l’imbecille di famiglia. Non basta l’alta quota sentimentale, i picchi morali, i cocuzzoli del commento. L’aria è pura, ma non è arte pura quella di Gadda. Pure lui va in paradiso passando dall’inferno? Un narratore letteralmente dantesco. Dal Castello si guarda e si racconta da almeno tre punti di vista: manca il quarto, tocca scendere, servono linguaggi più bassi. Urge ritirarsi da Udine e portare la guerra in Italia e altrove. È tempo di viaggiare. Una letteratura di viaggio che non si riposa mai. Ha il mal di mare? Ha il male invisibile: non si vede ma si sentono gli urli. Chi ha messo il coperchio sull’anima bollente di Gaddus?
La Madonna dei Filosofi (1931)
La religione del pensare. Il pensiero sia ispirato. Il filosofo cerchi la Verità. Non può essere solo un punto di vista. La madre adorata di un povero Cristo. Schiaccerà il serpente penetrato nel cervello di Gadda. Non si scrive col cranio scoperchiato di Joyce. Quanti pensieri per scegliere ogni parola. Ci vuole l’aiuto della Madonna per avere il genio lirico espressivo, ma è il diavolo a offrire le idee giuste per andare all’inferno. Non sembrava un predestinato. Tutti lo consideravano un imbecille. Gadda ha il pensiero debole? La teoria c’è ma sono ancora piccole le buone azioni. Il castigo di Dio sopra questo miscredente. Non sarà mai perdonato il delinquente, colui che abbandona la retta via della letteratura, il narratore che fa il doppio gioco. Peccati veniali, piccoli furti, timide trasgressioni. Qualcuna l’ha pensata bella. Sia ringraziata la Madonna per non averlo lasciato così com’era in natura. Filosofi, con una cultura diversa pensate una grande cosa nuova e credeteci.
L’Adalgisa (1944)
Cherchez la femme nella narrativa di Gadda. È un imperativo di Contini. Più che il francese, il milanese? In dialetto chi pensa carota dice carota? Lo smacco del realismo. Tocca essere più espressivi, usi i traslati chi vuole avvicinarsi fulmineamente alla verità più segreta. Meglio scappare dalla tangibile patata dei naturalisti. Il prigioniero tenta la fuga in abiti femminili? Zoraide, Jole, l’Adalgisa, figure a tutto tondo. Cosa sta rotolando lo scarafaggio del geologo? Così va il mondo. Una palla di sterco. Un mondo di merda ma quali nobili cose non si possono fare con la materia! L’epica dello scarafaggio: la si prenda dove c’è. Ateucus Sacer è valoroso come Aiace? La scienza trasforma tutto, lo deforma e così conosce. Riconoscete Bouvard e Pécuchet? Che ci fanno questi due imbecilli in Italia? Non sono morti, si sono trasferiti nel nostro secolo. Se sono un mito moderno, non moriranno mai. Circola il fantasma di Flaubert nei romanzi di Gadda? L’Adalgisa fa pulizia al cimitero. Come è facile scrivere sul marmo. Lo stile non è epigrafico. C’è chi vorrebbe scalpellare le digressioni di Gadda. Si chiami il poliziotto, lo si rinchiuda, nulla lo trattiene. Che temperamenti queste donne di Milano! Nemmeno la madre scherza. Gadda è il sior Carlo o è l’Adalgisa? Le si faccia un brutto scherzo: si rida e così la ferisci mortalmente. Una figura quadrata che non rotola via, nemmeno se l’ammazzi. È un’esperienza da fare, ci proverà. L’Ingegnere le prova tutte. L’Adalgisa non l’ammazzerà mai nessuno.
Novella seconda (1971, ma 1928-30)
Non si può andare avanti così, è intollerabile restare prigioniero della prima novella, quella raccontata dalla madre. È insopportabile la lingua madre, quello che si può dire con essa e quello che si pensa con la testa di una borghese dell’Ottocento. Sheherazade racconti una novella seconda, se vuole vivere per un altro giorno. Pure il caffè di cicoria è caffè. Una novella eccitante, anche se poi ti butta giù. O meglio, butta via la madre, il suo linguaggio tragico, il suo pensiero benpensante. Si faccia luce nell’inconscio, con ogni mezzo, con tutti i metodi vecchi e nuovi. Paradisi artificiali, artifici tecnici, overdose di metafore, visioni incongrue, giochi dall’interno e dall’esterno, babele di lingue, ossessivo rincorrersi di immagini, precipitare di digressioni, frasi che si annodano, voci che urlano o ridono. Scendere nel profondo e poi risalire col proprio segreto. Quali orrendi desideri, che insane voglie. Non ci si era mai visti così feroci. Altro che burle e beffe, come nel San Giorgio in casa Brocchi. Ora una madre la puoi anche uccidere. Gli altri, Tozzi, Savinio, Kafka, fanno fuori il proprio padre. Qui, nei romanzi di Gadda, si ammazzano madri.
Tocca colpire il male invisibile alle origini. La colpa della nascita. È questa la natura o è solo una cultura? Si può raccontare diversamente la vita? Bisogna delinquere come il latino, cioè lasciare il vecchio modo di pensare e bere il caffè di cicoria. E allora si aggredisca la madre, la sua mentalità e il suo essere: genitrice di una vita dissennata. Dalla beffa al matricidio? Solo in così poco la seconda novella cambia rispetto alla prima. Mente o braccio che sia l’organo che lo fa, il gesto è strutturalmente identico. Data N, poi la conoscenza procede così: N+I, N+2, N+3 ecc. Urge cambiare lettera. Cambierà poi la sostanza della questione privata? Lavoriamo alla lettera, ma attenti alla metafora.
La cognizione del dolore (1963, ma 1939-41)
Duole tutto, il fegato, il cuore e il resto del corpo ma duole specialmente l’anima. La devastante nevrosi, l’invisibile male insensato, l’angoscia che deforma all’interno e all’esterno. Un dolore per cui si urla e per cui gridano i colori dei pittori espressionisti. Questa smorfia aiuta a conoscersi. Si può smorfiare l’anima? Il personaggio è piagato dentro. Quanti mostri in questo romanzo. C’è anche la caricatura. E allora si ride. La comicità che è pure tragedia. Lo diceva Socrate o Platone, lo dicevano Bontempelli e Debenedetti. La madre preferisce la tragedia, fa la tragica, non è più comica come quando era la madre del meccanico o del contino Brocchi. Qui si parla con cognizione di causa. Gadda sa tutto della psicoanalisi. Si può morire senza ragionevole motivo. Da quando è morto il positivismo, come s’è ridotto il personaggio uomo. Che rovello, un trapano. Si faccia un foro per lasciare sfiatare l’angoscia.
Uccidete quel linguaggio, abbiate pietà della madre e del figlio. Un viaggio agli inferi. L’indovino Teresia tace e la madre guarda indietro, verso altre ombre. Nemmeno agli inferi è consentita la conoscenza della verità. Questa è una fatica di Sisifo. È proibito l’ingresso al profondo. Si possono fare tutte le smorfie che si vogliono ma non c’è comunicazione tra le anime. Quell’abbraccio alla madre è soffocante. Alla lettera: il poliziotto non scopre mai il colpevole. Provate con le metafore. Nessuno vuole confessare, non c’è da credere a nessuno. «I pronomi sono i pidocchi del pensiero». Gratta gratta c’è sempre una tragedia dentro l’umorismo. La cognizione del fascismo. Una malattia dell’anima italiana? Hanno visto in tutto il mondo il male visibile degli italiani e il male invisibile di Gadda.
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957, ma 1946-47)
Dopo la via milanese (San Giorgio in casa Brocchi, L’incendio di Via Keplero, La meccanica), ecco la via romana al capolavoro. Letteratura di strada. Il palcoscenico naturale ora è la città. Il centro dove confluiscono tutti i modi di parlare, il grande quadrivio che prima ancora è un trivio. Una grassolana città, un narratore grasso, che si allarga verso la periferia. Strade ma anche sotterranei, un reticolato di arterie e capillari con cui si butta il sangue per sopravvivere. Se fate l’analisi, è un cancro, immensa metastasi che invade ogni spazio e che cresce inesauribilmente. In questo pasticciaccio, c’è uno straordinario consumo di energie. Non vi accontentate della celebre gallina. C’è la porchetta al mercato di Piazza Vittorio. Non si butta proprio niente della cucina gaddiana. Troppe calorie nelle grasse digressioni? Non si vede l’osso, sembra assente la struttura, gronda di saporite metafore la scrittura. Se manca la parola per dire una cosa, la si inventi. Creazione o rappresentazione? Il realismo di una catastrofica visione. Quale pasticcio è mai questo, se quanto più metti in ordine tanto più aumenta il caos? Le braccia di San Pietro non ce la fanno più a trattenere il dilagante magma. La mente di Gadda è un vulcano che erutta lapilli da cui non si salva nessuno. Verrà la polvere e seppellirà un’umanità così dissennata. Si salva solo Ingravallo? Salvate Liliana Balducci, la Zamira, Ines Cionini. Come vengono bene le donne a Gadda, anima femminile!
I viaggi la morte (1958)
Meditazioni non solo milanesi. Sono saggi ma ci sono molte idee matte. Con esse si viaggia oltre la morte? Viaggiando tra un secolo e l’altro (dall’Ottocento di Manzoni e Flaubert al Novecento di Moravia), dalla lingua al dialetto, da un dialetto settentrionale a uno centro-meridionale, da un linguaggio all’altro (dal naturalismo al cubismo e all’espressionismo), dall’onnipotenzialità (maschio e femmina) alla polarizzazione (maschio o femmina), dal gioco ab exteriore al gioco ab interiore, dalla natura alla cultura e viceversa, dal tragico al comico, dal sermo humilis a quello prezioso, dal discorso indiretto libero al monologo interiore camuffato, dalla prosa alla poesia, dal poemetto in prosa alla narrativa, dalla favola al romanzo. Sempre in viaggio per sfuggire al linguaggio che deperisce e muore. Dal Giornale di guerra e di prigionia al Pasticciaccio.
Teoria, storia, tecnica, critica. Con simile saggista si va lontano, all’indietro e in avanti. I grandi stili, secondo Heisenberg, sono sempre complementari al presente. Gadda viaggia verso il futuro per essere sempre presente. Un mito? Il pasticciaccio in cui dolcemente affoghiamo per l’eternità. Questo è solo l’ordine naturale delle cose, ma viaggiando nel tempo e nella storia le cose cambiano. Deformando, ne fa conoscere di cose ignote questo spastico saggista! Gadda non avrebbe mai parlato di morte della letteratura, anche se poca gliene piaceva, compresa la propria. Pare che il Gran Lombardo sia morto facendosi leggere I promessi sposi. Il viatico e l’estrema unzione. Si può vivere per scrivere Quer pasticciaccio brutto de via Merulana.
Eros e Priapo (1967)
Il sesso divinizzato. Gliel’ha detto Freud che si tratta degli dei del nostro tempo e Gadda ci ha creduto. Naturalmente a parole, così si dice. L’erotismo della parola ha il suo dio in Gadda. Sa fare di tutto con la lingua. Metaforicamente parlando. Ricordate il brigadiere insonnolito sulla moto verso i Castelli? Gadda ha messo un tigre nel proprio motore. Ogni strada conduce a Roma con l’energia trasmessa alla frase. Il kamasutra della sintassi. Mille posizioni contro la routine. La deviazione dalla norma, effetti shock, straniamenti. Ogni tecnica dell’amore per la letteratura. Un manierista, un onanista, un formalista? Barocca è la vita. Anche così si cerca la vera vita. Quanti nipotini. La lingua di Gadda non è sterile. Pensate a Zoraide e a Jole. Supremo è il linguaggio del corpo. Un pittore molto sensuale. In verità c’è anche satiriasi, priapismo figurale, tasso elevato di traslati, periodi masturbatori, maniacale partenogenesi verbale. Il parossismo di chi si sta avvicinando al centro della questione. Sul fascismo gira un po’ intorno. Non hanno tante colpe le donne che hanno generato i fascisti per la guerra del duce. Gadda perde la testa dietro ai propri fantasmi. Un visionario della satira politica.
Accoppiamenti giudiziosi (1963)
Le coppie di Gadda. Natura e cultura, forma e sostanza, lingua e dialetto, struttura e scrittura, autobiografia e romanzo, filosofia e letteratura, deformazione e conoscenza, comico e tragico narrazione e dialogo, maniera e vita, gioventù e bellezza, ordine naturale e ragionevolezza, metafora e verità, caos e mondo, padre e dissennatezza, borghesia e stupidità, fascismo e farsa, esistenza e follia. Sterilizzate padri, fascisti, borghesi, e, perché no? madri. Possono nascerne imbecilli, matti, nevrastenici, psicopatici. S’ha da fare questo matrimonio: fra avanguardia e tradizione, fra naturalismo ed espressionismo, tra liricità e narrazione. Il frutto non è più proibito. Non è peccato prendere capitoli de La meccanica e trasformarli in racconti, ma il romanzo è un’altra cosa, è padre di più significati. Una coppia di racconti di Accoppiamenti giudiziosi, San Giorgio in casa Brocchi e L’incendio di via Keplero, è felice di stare assieme ai più belli del Novecento italiano. Ecco i miei gioielli.
Novelle dal Ducato infiamme (1953)
Non è andato a fuoco solo il Ducato. I danni irreparabili del Duce. Questa non era una novella nel secondo dopoguerra. Era sotto gli occhi di tutti, era tangibile, era reale. Aiuto! al fuoco, attenti al neorealismo. La seconda novella è che brucia non solo l’Italia fascista, non è in fiamme solo l’Italia. Chiamate i pompieri, è in pericolo tutto il mondo, e non viene risparmiata la vita. Non è nuova nemmeno questa, ma nessuno prima l’aveva raccontata in modo così scottante. La buona novella è che, anche quando il fascismo è in fumo, nonché gli altri ismi derisi da Gadda, il racconto resta caldo. Gadda ha la struttura infiammata, non c’è acqua che possa spegnerla. Al suo contatto prende fuoco ogni tema. Questo narratore è a suo modo un piromane. Con la anima ulcerata ha sentito che questo è un mondo da bruciare. Fiamme, esplosioni, scoppi di risa. La legna Gadda se la procura da sé. Il rogo sul quale è celebrato il rito funebre in onore di un narratore che è anche un’araba fenice. Dove sia il focolaio ce lo dice lo psicoanalista, cosa sia Gadda la critica lo sa. Non date fuoco alla critica gaddiana, gettate acqua su alcune idee. Gadda non ha scritto solo novelle o poemetti in prosa. L’ultima novella: Gadda è autore di tre grandi romanzi, di più di dieci racconti bellissimi e di almeno cento pagine infuocate di diario. Lo dice il Giornale.
Un monarchico, un liberale di destra, un conservatore. Conservare l’Italia dopo Caporetto? Fosse pazzo. Che disordine, che confusione, che gran pasticcio! Non bastava un re qualsiasi. Non poteva essere Mussolini, una macchietta. C’è qualche macchia sull’antifascismo di Gadda. «Franza o Spagna purché se magna?» Gadda ha sempre masticato poco la politica. Non è ingrassato con la letteratura. Davvero una vita non regale, ma il portamento, il comportamento, è sempre nobile. Avrebbe volentieri fatto i Luigi o i franchi o lire al mercato del libro. Gli sarebbe piaciuto essere uno scrittore venduto al libero mercato. Non chiedeva protezione per le sue opere, non pretendeva un editto regale per stabilire che era lui, Gadda, il re dei narratori italiani. Migliore di tanti scrittori di Francia che fanno i napoleoni.
Il primo libro delle Favole (1952)
Non è un libro per bambini. Gadda non racconta mai favole. Sono troppo brevi e fanno la morale. Questi animali sono veri, ma usano una lingua troppo preziosa. Sarebbe bello far parte del gregge, essere uno come gli altri. Che variante è la propria vita rispetto alla altrui? La favola è sempre la stessa? Non gli è permesso comporre una del tutto nuova? Qualcuno gli impedisce di scrivere il secondo libro della favole. La sua arte consisterà sempre nel deformare le favole degli altri, nel mettere la gobba alle parole della tradizione? Oh, fosse possibile raccontare in poche e chiare parole la sua vera favola. Ma nel Novecento questo sarebbe favoloso. Nessuno sa più dire la verità. Nemmeno ai bambini. Ai quali si continua a fare la morale su vecchie favole.
Non finiscono mai di meravigliare Quer Pasticciaccio e La cognizione del dolore. Sono quasi al livello dei capolavori alcuni racconti (San Giorgio in casa Brocchi e L’incendio di via Keplero). Non meravigli che si giudichi un gran bel romanzo La meccanica. Da quel dì poi che L’Adalgisa è considerata un’opera meravigliosa. Non meraviglia più invece che continui a farsi leggere come un libro di cocente attualità Il giornale di guerra e di prigionia. Vi meravigliereste, se si dicesse che la prosa di Meditazione milanese merita di far parte dell’antologia universale della scrittura filosofica? Non vi meravigliate: acuto pensatore, Gadda è anche un grande saggista in I viaggi la morte. Lo ha scritto qui che il suo fin non è la meraviglia. Certo vorrebbe far girare la testa con ogni parola: lo sguardo sempre rivolto dalla parte da cui potrebbe apparire la verità. Quando si spalancano gli occhi, c’è la rivelazione? Purché non sia un abbaglio. Un narratore illuminante. Non meravigli che tra i suoi titoli abbia un posto così eminente l’Italia. Ci meravigliamo invece che non sia celebre come merita nel resto del mondo il narratore che ha raccontato meravigliosamente quale pasticciaccio brutto è la condizione umana nel Novecento.
Verso la Certosa (1961)
Gadda non va verso Stendhal né in convento. Non sta mai fermo, il suo linguaggio è tarantolato, avrebbe bisogno dell’esorcista. Etica, stilistica e metafisica ma non sarà mai un certosino. Avere l’imperativo di andare e insieme l’interdetto di arrivare. Versus: cioè contro. Non è questione di gambe, Gadda ha una testa che raggiunge ogni obbiettivo. Gli piaceva il parmiggiano. Con tutta la sua metafisica, sarebbe potuto diventare un abate. Questo miscredente corre sempre contro le minuscole verità, verso la Verità. Con l’iniziale maiuscola. Il Pasticciaccio è una grandiosa opera architettonica che ora è meta dei viaggi di innumerevoli fedeli. Tra gli altri si distinguono i volti di Pasolini, Testori, Mastronardi ed altri narratori espressionisti. I certosini della parola spastica.
Gli Anni (1943)
Dal 1957 al 1967 Gadda ha avuto un decennio glorioso. Sono gli anni dello sperimentalismo, del mistilinguismo, della priorità del linguaggio, della trasgressione, dei linguaggi bassi, della comicità. Gadda ha messo su famiglia, ha molti nipoti, assai più piccoli, detti i nipotini dell’Ingegnere. Negli Anni Venti era già un eccellente narratore (La meccanica). Gli Anni Trenta: Firenze, gli ermetici, gli inizi dei romanzi infiniti, La cognizione del dolore. Scrisse il Pasticciaccio nei neorealistici Anni Quaranta, che non amano il barocco Gadda. Negli Anni Cinquanta, dopo i fatti d’Ungheria, il mondo è un pasticciaccio sempre più brutto. Gnommero gaddiano gli Anni Sessanta, il disordine programmato, la contestazione, lo schizomorfismo, l’alienazione, il ribaltamento dei valori, l’integrazione della malattia, ecc. Ormai è fatta. Gadda è narratore massimo anche negli Anni Settanta, decennio di nuovo realismo sempre più ostile ai formalismi. Negli Anni la parola torna al centro, non piace più il gioco agli estremi, si scrive in ilaliano puro, vengono epurati gli espressionismi, gli sperimentalismi, e tutti i linguaggi moderni. Nel postmoderno c’è posto anche per Gadda? Il suo posto, dopo Svevo e Pirandello, non glielo toglie nessuno, almeno per ora, negli Anni Novanta del Novecento. E nel terzo millennio cristiano? Se Gadda vive per mille anni, è fatta: è immortale. Metaforicamente parlando.
La Sapienza, Università di RomaPublished by The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS)
ISSN 1476-9859
© 2002-2026 byWalter Pedullà & EJGS. Previously published in I titoli. Landolfi Gadda Savinio (Rome: Le impronte degli uccelli, 1999), 23-44.
artwork © 2002-2026 by G. & F. Pedriali.
All EJGS hyperlinks are the responsibility of the Chair of the Board of Editors.
EJGS is a member of CELJ, The Council of Editors of Learned Journals. EJGS may not be printed, forwarded, or otherwise distributed for any reasons other than personal use.
Dynamically-generated word count for this file is 4872 words, the equivalent of 14 pages in print.


