EJGS Supplement no. 5, EJGS 5/2007
Archivio Manzotti – Le ragioni del dolore
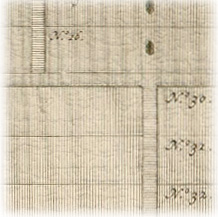 |
Le occasioni di Gadda
Giulio Ungarelli
1. La servitù giornalistica
Sul declinare degli anni trenta – e già iniziata la scansione drammatica del calendario del secondo conflitto mondiale – gli annali bibliografici gaddiani registrano, oltre s’intende le nutrite collaborazioni a fogli ed effemeridi letterarie, una insolita ed abbastanza fitta attività su periodici di varia cultura ed attualità: dalle gloriose ed anziane testate della Nuova Antologia e delle «geografiche» Vie d’Italia, al modernissimo quindicinale Panorama dell’editore Gianni Mazzocchi, fino all’illustrato Tempo, settimanale diretto da Alberto Mondadori, grafica di Bruno Munari. Minore, invece, anche se mai in assoluto intermessa, l’attività inscritta sotto i titoli dei quotidiani: primi fra tutti, anche nella genealogia delle collaborazioni giornalistiche gaddiane, il milanese Ambrosiano, la piemontese Gazzetta del Popolo e, acquisizione più recente forse in omaggio alla nuova residenza, la fiorentina Nazione.
Avviatosi, infatti, a divenire – anagraficamente – fiorentino in Arno, Gadda ancora una volta progetta l’agognato abbandono dei lavori ingegnereschi per dedicarsi unicamente agli studi diletti: vivere di letteratura, da non intendersi ovviamente in senso del tutto economico, ché anche allora i carmina non riuscivano ad assicurare neppur poco e stentato pane. Alla sopravvivenza avrebbe soccorso, più che una remunerativa attività giornalistica sempre aleatoria e nel caso di Gadda di difficile effettuazione, la rendita cinque-per-cento dei buoni del tesoro nei quali egli aveva investito buona parte del suo capitale (alcune centinaia di migliaia di lire di allora), frutto di economie e di sacrifici. Quanto il progetto si rivelasse, poi, per la parte economica, assolutamente erroneo, Gadda ebbe modo di lì a poco di accorgersene, e con rabbia, quando cioè i sopraddetti patriottici buoni del tesoro rovinarono miseramente assieme ai destini della patria imperiale: una involontaria storia gaddiana dal vero, un po’ parente dei risvolti economici degli affabulati disegni milanesi.
Comunque la preferenza accordata da Gadda per i suoi scritti mercenari ai settimanali ed ai mensili piuttosto che ai quotidiani, risiede soprattutto in una sua insofferenza per la severa misura della pagina giornalistica. Scriverà anni dopo: «Io quando devo fare un elzeviro mi sento morire: annaspo annaspo con lo spettro del direttore e del suo pubblico di serve davanti al naso». (1) In un’epoca nella quale quasi tutti i letterati italiani si ingegnavano con le quattro-cinque cartellucce, corrispondenti più o meno alle classiche due colonne d’apertura della terza pagina, e in una situazione culturale in cui questa asfittica misura finiva col divenire come un dono innato, una sorta di seconda natura dell’essere scrittore, Gadda combatteva da isolato una sua personale, personalissima battaglia contro quella gabbia ossessiva che nella sua fantasia si materializzava, da una parte nella figura autoritaria, minacciosa del direttore pronto ad ogni reprimenda per l’eccessiva lunghezza dei prodotti giornalistici gaddiani (e conseguente punizione di una lunga quarantena), e dall’altra nell’immagine di un pubblico raffigurato come ingordo, insaziabile consumatore di classici, misurati elzeviri.
C’è da dire inoltre che se c’era uno scrittore del tutto inadatto a collaborazioni giornalistiche questo era proprio Gadda, estraneo al demone delle mode quanto a quello dell’effimera attualità, ma estraneo anche, prammatico com’era, a qualsiasi forma di assenza lirica dalla realtà, ornamento questo quasi d’obbligo nell’allora esornativo limbo giornalistico della terza pagina. Così la sua indomabile vis documentaria non trovava spazio, luogo conveniente nella stampa quotidiana del tempo (e forse non l’avrebbe trovato neppure in quella odierna).
Scrittore intermittente quant’altri mai, Gadda poteva invece ciclicamente sperimentare sedi più idonee solo nelle riviste di larga periodicità, dove l’impegno, l’occasione, l’attualità e le stesse scadenze divenivano naturalmente meno pressanti, dove soprattutto l’ossessione dello spazio occorrente per il sempre più digressivo discorso gaddiano poteva stemperarsi, contare su un numero maggiore di pagine.
Certamente rimaneva, neppur lontanamente scalfita, la singolare contraddizione fra un proposito più volte dichiarato di scrivere articoli a scopo eminentemente lucrativo (o meglio su commissione, quelli che Gadda chiamava «richieste su temi vari») e l’impossibilità non solo accertata, ma alla fine addirittura accettata, di poterli scrivere currenti calamo. Soltanto a prezzo di una lunga elaborazione e di una strenua stesura Gadda riusciva a portare a termine i suoi scritti mercenari, con il risultato che il tempo e la fatica impiegati erano del tutto sproporzionati rispetto allo scopo prefissato e finendo così col ridurre a ben poca cosa la relativa mercede. Insomma, in termini monetari il risultato non valeva assolutamente l’impresa. Altro che vivere di articoli e di collaborazioni: da queste Gadda poteva trarre al più un modesto contributo per il suo sostentamento. Non solo, ma se la «musa triste» (l’attributo è dello stesso Gadda) che presiedeva al suo lavoro creativo lo visitava con pochissima regolarità, per non dire che si assentava per lunghi periodi con risultati facilmente prevedibili (le famose inadempienze gaddiane), non diversamente avveniva anche con quella più modesta musa che avrebbe dovuto ispirarlo per i lavori d’occasione. Per cui i ritardi, le promesse non onorate non possono certamente essere messe in conto semplicemente a mancanza di impegno o di senso di responsabilità da parte di Gadda. Tutt’altro. Si deve semmai parlare, assieme all’autore, di un’oscura impossibilità di scrivere: «La Musa, specie la triste», – così in una lettera a Lucia Rodocanachi del 26 febbraio 1941 – «ha dei fading insormontabili: zone di silenzio o di notte della volontà inchiostratrice in cui non soltanto la possibilità di composizione (come dicevano i romantici) ma anche la sistemazione, traslitterazione e ricopiatura delle pagine già scritte diventa una… impossibilità. E le ragioni dell’impossibile lei le può immaginare, anche se talvolta ha deriso (un po’ montalianamente) le mie complicazioni “démodées”» (Gadda 1983d: 129).
Se a quanto sopra certificato si aggiunga poi la natura particolarmente ansiosa di Gadda, il suo a volte spropositato senso di responsabilità, la sua incorreggibile predisposizione ad offrirsi, accettando, se non addirittura proponendo articoli su i più disparati argomenti (e secondo uno scadenzario che era poi impossibile rispettare), è facile immaginare in quale piccolo inferno potesse trasformarsi l’officina gaddiana. Così ad un’ampia disponibilità a proporre ed offrire articoli giornalistici fa riscontro una vissuta impossibilità di scrittura corsiva: ancora una volta il demone della contraddizione sembra governare anche questo settore minore dell’attività di Gadda. Né vale, al riguardo, richiamare le sue rispettabilissime esigenze economiche, atteso che sovente operazioni del genere finivano per inscriversi nel libro mastro della vita come voci passive. Semmai c’è da considerare nell’accoglimento da parte di Gadda di curiose richieste (che ritroviamo esemplate nella sua bibliografia) l’attivazione di quella mobile sua curiosità del reale, o addirittura su un gradino più alto, la sua profonda esigenza di conoscenza ed insieme il suo gusto enciclopedico che lo portavano ad indagare nei più riposti ed impensabili luoghi della realtà.
Soltanto ove si consideri tale aspetto è forse possibile trovare una ragione un po’ più fondata di quelle troppo semplicemente invocate da Gadda (la sua «meticolosità», la sua «diligenza») a giustificazione dei lunghi tempi di esecuzione richiesti dalla faticosa fattura dei suoi articoli giornalistici. Il sospetto che ne deriva è una sorta di coinvolgimento dello scrittore che va ben oltre l’impegno assunto: una sorta di natura che superando tutte le qualificazioni moralistiche investe la sostanza propria della scrittura gaddiana, scrittura che è soprattutto testimonianza di un rapporto di lui, Gadda, quanto contrastato è inutile sottolinearlo, con il mondo circostante.
«Per tirare avanti» – scrive sempre a Lucia Rodocanachi sotto la data del 26 febbraio 1941 – «e per guadagnare qualcosa, ho accettato di sobbarcarmi a qualche fatica pamphletaire, tecnico-propagandistica, cavandone gloria nessuna, denaro poco, e noia molta. La mia natura diligente e meticolosa ha reso inutilmente perfetta la fatica, e disastrosamente imperfetto il guiderdone. –» (Gadda 1983d: 129). «Inutilmente perfetta la fatica», ma pur sempre perfetta: così il severo giudizio autocritico, «la fatica pamphletaire tecnico-propagandistica», si stempera con una tonalità non del tutto negativa.
Ma conviene analizzare sul campo la fatica gaddiana. L’occasione dell’articolo, anzi degli articoli di cui parla nella lettera sopra citata fu la «celebrazione» – quanto richiesta a Gadda o invece da questi proposta, non è dato sapere – di una delle «opere» del regime, la cosiddetta riforma del latifondo siciliano. L’impresa richiese anche una trasferta invernale in Sicilia, «disastrosa» a dire di Gadda, per i disagi del viaggio ed il freddo patito, riuscendo così a sfatare il mito dell’assolata Trinacria: «La settimana antecedente il Natale» – ancora dalla lettera a Lucia Rodocanachi del 26 febbraio 1941 – «è stata occupata da un disastroso viaggio in Sicilia (neve e freddo settentrionali) – da cui ho ricavato alcuni mal pagati articoli sul latifondo» (Gadda 1983d: 128). Ed al cugino Piero Gadda Conti aveva già scritto in data 3 febbraio 1941: «Ho fatto due articoli piuttosto fessi sul latifondo per la Nuova antologia e le Vie d’Italia, ma ti prego di non parlare del doppione con gli interessati!» (Gadda Conti 1974: 54). La solita paura, i soliti timori conseguenti alle ingenue furberie gaddiane. In realtà gli articoli furono per l’occasione tre: «Volevo dirti» – questa volta il destinatario della lettera (10 aprile 1941) è Enrico Falqui – «che per il latifondo siciliano ho scritto 3 = tre articoli: uno per la N.A., di cui ti invierò estratto, uno per “Le vie d’Italia” della C.T.I., con molte fotografie: uno su “La Nazione”: con fotografia». (2) Si va così dagli articoli «piuttosto fessi» al premuroso invio a Falqui dell’estratto: un’oscillazione cui Gadda ci ha ormai abituati. Perché dalla figura di un Gadda giudice impietoso, sovente ingiusto, dei propri lavori, che non tiene in alcun conto le sue sudate fatiche giornalistiche, si stacca, come un doppio inseparabile simile ad un’ombra, un altro Gadda preoccupato oltre ogni dire di accreditare, soprattutto nell’ambiente letterario e degli amici, la propria immagine ufficiale di pubblicista-scrittore, quasi per rivendicare una professionalità che poteva essere oscurata da quell’altra, quella diciamo anagrafica, da carta di identità, di ingegnere (d’altronde, già nel 1931 dichiara, in un documento militare, come professione quella di «pubblicista-scrittore»). Soltanto così si comprende la malcelata soddisfazione con cui scrive delle molte fotografie che arricchiscono il suo testo apparso sulle Vie d’Italia.
In quegli anni, infatti, Gadda vive la condizione di chi non sa (non può) dire di no; nel timore evidente di non essere cercato da nessuno, accetta ogni richiesta di collaborazione, avanza ogni proposta. Così si spiega anche l’equivoco tecnico dei suoi articoli. Gadda non amava confondere il suo lavoro di ingegnere, cioè il suo lavoro tecnico (niente affatto nobilitato da alcun attributo scientifico) con quello letterario. Il primo in fondo gli serviva per far bollire la pentola, ne avrebbe fatto volentieri a meno. Nessuna tentazione quindi di voler contaminare la sua attività di scrittore con gli aspetti più o meno scientifici della sua attività o preparazione tecnico-professionale. I richiami alle sue esperienze di fabbrica e di cantiere, di ingegnere, sparsi in tanti suoi testi, hanno esclusivamente, al pari delle sue esperienze militari, una valenza nettamente autobiografica: sono cioè brani della sua vita metabolizzati nel testo letterario.
Non bisogna dimenticare che Gadda vive una netta dissociazione: da una parte l’ingegnere, applicatore perfetto, ma non creatore e nemmeno speculatore di teorie, dall’altro lo scrittore, esploratore di mondi anche oscuri; da una parte chi opera all’interno di un sistema almeno formalmente razionale, dall’altro chi sa di muoversi in un ambito dove malgré lui l’irrazionale la fa da padrone. Certo questa opposizione soffre, come d’altronde ogni opposizione, di una sorta di schematismo; incursioni vicendevoli fra i due estremi ce ne sono, né potrebbe essere altrimenti. Il tecnico che in concorrenza o addirittura falsificando i procedimenti della natura si accorge che qualcosa di imprevisto o di demoniaco si è interposto fra i suoi calcoli, bloccando gli ingranaggi delle sue costruzioni e mettendo così a dura prova le sue raziocinanti convinzioni, fa pendant con lo scrittore che proprio con la scrittura finisce invece per esorcizzare, formalizzare –id estrazionalizzare – i suoi incubi, i suoi mali invisibili.
Comunque, di fatto, nel caso di Gadda l’opposizione rimane. E per quanto attiene il discorso sul suo giornalismo c’è da chiedersi quanto di veramente voluto, quanto di veramente intenzionale ci fosse nella realtà delle sue collaborazioni tecniche, nei suoi excursus divulgativi. Se cioè nel consentire o addirittura proporre siffatti argomenti lo scrittore fosse del tutto libero. Su di lui, infatti, grava fin dall’inizio l’ipoteca dell’ingegnere, dell’ingegnere-scrittore: una sorta di maledizione politecnica-milanese della quale, pur nel sottile gioco del rispetto-dileggio, egli ha fatto più che altro bersaglio per i suoi dissacranti sarcasmi. Un certo signor Carlo Emilio Gadda, ingegnere (insegna professionale che incute sempre, anche fra gli intellettuali, un certo rispetto), si aggira, figura singolare ed un po’ spaesata fra le aure novecentesche, rasentando i luoghi deputati dell’agape letteraria. Un personaggio che viene accettato in un ambiente piuttosto difficile ed esclusivo quale quello letterario italo-fiorentino (ed immediate adiacenze) soprattutto per la sua diversità, una diversità eminentemente seria e distinta, che esclude del tutto qualsiasi forma di bohème, semmai il contrario. I rigorosi abiti scuri, le riservate cravatte dell’ingegnere, il suo eloquio fiorito e rispettoso, un po’ démodé, anche se non esente da improvvisi scoppi d’ira, disegnano in esterno il continente Gadda, ma sono anche un marchio di fabbrica che in anni tutt’altro che facili per i commerci culturali può essere spendibile, può avere mercato. Questo Gadda lo sa, l’ingegner Gadda. Soltanto negli anni ormai tardi, quando il suo laboratorio è già inoperoso, sarà solo Carlo Emilio Gadda scrittore.
Quanto fosse poco gradita all’interessato l’etichetta ingegnere-scrittore ci vuol poco ad immaginarlo. Negli anni più fecondi della sua attività Gadda sembra tuttavia far buon viso a cattiva sorte, indulgendo spesso a questa curiosa doppia e contrastante qualificazione, offrendosi come pubblicista-tecnico, anche quando la richiesta riguardava soltanto lo scrittore. Al fondo di questa sottile mistificazione c’era la proiezione tutta gaddiana del committente come un severo, sussiegoso personaggio uso a considerare la letteratura nei quotidiani e nei periodici d’attualità come un inutile, ingombrante ornamento ed in fondo neanche tanto serio, poi. Convinzione, è bene sottolinearlo, che era un po’ anche quella di Gadda. Al di là delle simpatie od antipatie, egli era uso a considerare la genìa dei letterati, degli scrittori come inutili sofi, buoni a darsi soltanto delle arie, ma per il resto perfettamente inutili. Circa poi la letteratura, beh era cosa troppo importante per metterla in gioco. Comunque la serietà del distinto professionista era pur sempre da preferire al colore letterario in odore di quella bohème tanto esecrata da Gadda. Insomma, distinguersi fra tanti elzeviristi da caffè, con l’aplomb di chi per impegni altrove assunti era uso a documentarsi minutamente, a misurare il reale, a rendere conto di una situazione negli infiniti dettagli, non poteva che riuscire un’ottima presentazione. Tutto questo è, ovviamente, pura fantasia gaddiana.
Quanto poi ad addebitare (con ira) questa finzione tecnica sia ai terribili direttori di giornali e di periodici, sia ai poco seri letterati coi quali bisognava pur non confondersi, tutto ciò deve essere sussunto nel complesso codice etico gaddiano, un codice secondo il quale ad ogni concessione fatta per compiacere qualcuno, corrispondevano nei confronti del malcapitato – sovente ignaro – terribili, segrete maledizioni elargite abbondantemente secondo un rituale altrettanto segreto.
Ma, al di là delle singolari procedure gaddiane, resta pur sempre da chiarire la complessità, se non addirittura a volte la macchinosità degli articoli dell’autore della Cognizione, che richiedevano, non v’è dubbio, lunghi, antieconomici tempi di lavorazione.
Il primo campione scelto è l’uno e trino articolo sulla riforma del latifondo siciliano, sufficientemente probante anche per la non lieve fatica del suo autore ad eseguire le tre variazioni su un unico tema. L’esame, ristretto in buona parte all’articolo pubblicato sulla Nuova Antologia, I nuovi borghi della Sicilia rurale (Gadda 1941c; Gadda 2005a: 109-20) che è un po’ l’archetipo della tema, consente di individuare una peculiare divisione in tre tempi del dettato gaddiano, riscontrabili in buona parte della sua produzione giornalistica:
1. tempo – digressione o ricostruzione storica attinente l’argomento trattato, non esente talvolta da spunti filologici, con richiami letterari non sempre conferenti (singolari, al riguardo, le citazioni nominali di artisti e scrittori contemporanei, amici di Gadda);
2. tempo – le opere e i giorni: qui la visione tecnica di Gadda –la realizzazione di opere di ingegneria – cede sovente alla descrizione di esterni ispirata all’amore tutto padano per il paesaggio agricolo (il richiamo della terra) dove si armonizzano la natura ed il lavoro dell’uomo, due temi questi cari alla poetica gaddiana e che danno vita a singolari accensioni liriche del tutto estranee alla funzionalità del testo;
3. tempo – che potrebbe essere definito legislativo-encomiastico, quello che Gadda chiama «fatica pamphletaire, tecnico-propagandistica», che si risolve sovente in una sorta di riscrittura aulicizzata di dispositivi ed istruzioni emanate per l’occasione dallo stesso regime.
Una strutturazione, come si vede, del tutto singolare, soprattutto ove si consideri il cosiddetto 2. tempo, laddove la scrittura gaddiana non facendosi più carico di alcuna esigenza documentaria od esplicativa, si libera in una tensione tutta sua, quasi di sfogo. Ai fini dimostrativi, si riportano qui di seguito due campioni prelevati, il primo dall’articolo pubblicato sulla Nuova Antologia ed il secondo dal fratello apparso sulle Vie d’Italia. Del primo frammento, la visione geometrica dei borghi colonici si trasforma in una sorta di affresco primitivo carico di vita:
Ho veduto i raduni bianchi dei cubi nella immensità della terra, quasi gregge portatovi da Geometria: e una limpida disciplina di masse, riquadri, diedri, gradi; e li avviva una grazia semplice, un’opportunità dell’atto, una speranza. E mi parvero già custoditi dal senno: non nati dall’arbitrio tetro, come può accadere a chi ha matita tra mano da fare i rettangoli, e soltanto matita. E vi erano brevi, puri portici: tinti alla calce i volti, i pilastri: e a sfondo il sereno. Archi a sesto, campiti di turchese. E la torre. Sul lastrico del cortile erano portate le ombre, come ore. E gli sgrondi cadevano alla serpentina lunga dei tegoli veduti in taglio, quasi ghirigoro o belluria: ma non ghirigoro, disegno sano anzi e venuto da necessità. E la porta era accesso già sacro, e la cucina in luce, con l’acquaio, pareva sbandire tutti i mali del luogo come dèmoni il fulgore dell’Arcangelo. (Gadda 1941c: 286; Gadda 2005a: 119)
Del secondo frammento si notano i colori di una campagna che diviene nella scrittura gaddiana un po’ paesaggio, fondo dell’ anima:
Le fitte alberature degli agrumeti inselvano la vallèa con il loro verde lustro, incupito, come di smalto; fronde e foglie dal contorno ricurvo, preciso, con l’offerta repentina delle loro arance color vèspero, come le vediamo dietro la Madonna in trono e i Santi del Ghirlandaio. Piccole abitazioni rurali si sono collocate umilmente, saggiamente, nella meravigliosa campagna, o verso i poggi a cui non è aliena dolcezza, e una grazia chiara del risalire nel cielo; dove il mandorlo di rada foglia non adombra il granire precoce de’ frumenti, e il tardo popolo degli ulivi, figlio dei secoli, mette i suoi cespi rotondi, scuri, su acclivi arature, e poi su, su, fino a varcare, quasi trasmigrando, le grige spalle del monte. (Gadda 1941e: 336-37; Gadda 2005a: 123-24)
Si sarebbe tentati di considerare i due brani come due frammenti, nel senso gaddiano di involontari espunti da una rappresentazione più vasta, immagini e figure simili a quei pezzi d’affresco strappati da un più ampio contesto andato perduto, sommerso dal tempo: frammenti nell’ordinaria accezione del termine, senza alcuna indulgenza a poetiche dell’epoca ben estranee, in fondo, ai moti della scrittura gaddiana. O, forse, inversamente, annotazioni strappate da un taccuino d’appunti, note di getto, trafugate dalle opere, dalla fatica dei cantieri. Due ipotesi opposte, ma ambedue ammissibili, che hanno in comune l’estraneità all’assunto pratico dell’articolo e che rinviano direttamente al frastagliato arcipelago gaddiano, le cui emergenze, separate dal mare del tempo, sono solo in apparenza staccate le une dalle altre, ma nel profondo ben unite in un’unica sostanza. I frammenti sopra riportati sono spie di un coinvolgimento – volontario od involontario che sia – dell’autore, indicano cioè in termini di tensione il costo degli articoli gaddiani e legittimano la loro varia, disinvolta utilizzazione da parte dell’autore (si veda, ad esempio, come un paragrafo dell’articolo L’uomo e la macchina trascorra temporaneamente, nella silloge Verso la Certosa, in un altro testo, a concludere cioè Dalle specchiere dei laghi, un testo questo di ben diversa e complessa stazza autobiografica).
Quale esigenza imponeva all’autore, a Gadda, di immergere nella fatica mercenaria degli articoli d’occasione lacerti del suo lavoro di scrittore, passando a volte – e non solo grammaticalmente – dalla terza alla prima persona, come a rivendicare un impegno personale, una proprietà?
La risposta al quesito non può che coinvolgere la storia di Gadda scrittore, una vicenda dove tutto gli appartiene, nulla gli è estraneo; a volte il quasi delirio della sua esigenza di conoscenza investe anche ciò che a prima vista potrebbe risultargli assolutamente remoto od estraneo: il tutto in un singolare gioco di compromissione attraverso il quale, nell’atto stesso di cedere a richieste altrui, di concedere e di concedersi, egli mette in moto anche un meccanismo di riappropriazione singolarmente violento. Doppia fatica quindi negli scritti giornalistici: quella di una certificante scrittura corsiva e quella di una scrittura a tutto tondo appartenente ai momenti alti della sua tensione creativa. Se Gadda offre più di quanto richiesto dal committente, in realtà lo offre a se stesso, sovrapponendosi, per non restarne prigioniero, ai vincoli dell’attualità, dell’effimero, della cronaca, quando poi, invece, non li esalta, stravolgendoli, facendoli apparire ancora più severi, più soffocanti. Ma all’atto stesso in cui sembra sottomettersi ad un codice, a delle regole, di fatto le sovverte, si direbbe per eccesso di zelo. O meglio, enfatizzando la servitù giornalistica, cerca paradossalmente di affermare la propria libertà di scrittore.
2. La collaborazione alla Nuova Antologia: nascita di Tecnica e poesia
Il gruppo di lettere inviate da Gadda, dal 1940 al 1943, ad Antonio Baldini, all’epoca redattore-capo responsabile della Nuova Antologia, e riguardanti la collaborazione alla rivista, consente di ricostruire sul campo il singolare procedimento gaddiano di adesione e nello stesso tempo di distacco dalle esigenze della committenza, esigenze – inutile sottolinearlo ancora una volta – spesso più immaginate dall’autore della Cognizione che veramente esternate dalla redazione della rivista.
La conoscenza con lo scrittore romano risaliva agli anni vaticani dell’ingegnere (1932-34): «Ho incontrato un giorno» – scrive al cugino Piero Gadda Conti nell’ottobre 1932 – «il taciturno Baldini» (Gadda Conti 1974: 34). L’incontro, officiato da Falqui (assieme a Gargiulo uno dei punti di riferimento per Gadda nella topografia letteraria romana), dovette riuscire non sgradito, anche perché l’autore di Michelaccio, uso a coniugare umori a reminiscenze classiche del buon liceo italiano (prima della riforma Gentile), poteva trovare posto nel piccolo pantheon letterario novecentesco della libreria gaddiana.
La collaborazione di Gadda alla Nuova Antologia inizia nel 1939 con una recensione dedicata al libro Nizza e l’Italia di Ermanno Amicucci (3) – allora direttore della Gazzetta del Popolo, atto dovuto secondo le norme dell’esigente codice gaddiano (l’antica testata piemontese era stata una delle prime ad ospitare articoli di Gadda). Il secondo testo che appare sulla rivista romana è un lungo servizio sulla milanese Mostra leonardesca (Gadda 1939f), un servizio dove il puntiglio documentario gaddiano si esercita con acribia sui materiali esposti (carte, documenti, disegni, modellini rappresentanti le macchine leonardesche), ma anche dove l’eccesso delle occasioni per l’accensione delle fantasie gaddiane finisce, curiosamente, col limitare la libertà d’invenzione della sua scrittura.
La prima lettera conservata della corrispondenza con Baldini porta la data del 14 marzo 1940 e contiene due proposte di collaborazione alla Nuova Antologia. La prima, di natura tecnica, ma che lascia presagire un’ampia libertà: «Si tratterebbe» – scrive Gadda – «di uno scritto descrittivo-biografico in forma quasi di narrazione o di lunga impressione, relativo agli impianti idroelettrici del periodo primo e alla vita di un antesignano di essi, il sen. Ettore Conti [era parente di Gadda]. Io vorrei dare la sensazione di quello che fu lo sforzo tecnico ed economistico degli inizi (1905-1910) con descrizione di lavori in montagna, distribuzione e ricerca della clientela in città. Un tratto di vita e di lavoro italiano, e una “persona dramatis” al centro; presa come esempio, fra i molti che si potrebbero citare». (4)
«Un tratto di vita e di lavoro italiano»: due temi centrali della meditazione gaddiana ai quali in fondo è dedicato il suo primo romanzo, quel Racconto italiano di ignoto del novecento dove si parla anche della costruzione di una centrale elettrica:
I miei quaderni di studio per un «romanzo sul lavoro italiano», 1922-1924, son pieni di improvvisi, note di getto, di strappo, tutte trafugate dall’opera, dal cantiere, specie dagli impianti e dai lavori idroelettrici di montagna: venute al mio quaderno senza speranza tra il sudore degli anni e degli uomini poveri, operosi. (Tecnica e poesia, SGF I 252)
Ma i rinvii sono da ricercarsi ancora più addietro: il primo articolo pubblicato da Gadda, Caratteristiche del problema idroelettrico, sulla milanese Perseveranza del 20 dicembre 1921 e firmato «Ing. C.E. Gadda»; ed ancora sempre più a ritroso, le ultime pagine del Giornale di guerra e di prigionia, sotto la data del 31 dicembre 1919:
In questi giorni scorsi fui con Piero Gadda, mio cugino, a Baceno, in Val Devero, in Valle Antigorio e in Valle Formazza a vedere gli impianti elettrici della Società Conti; visitammo quello stupendo di Verampio, poi quello di Crego; il canale di Crego, a mezza costa; lo percorremmo. Poi, il giorno 28, visitammo la centrale di Goglio; (al ritorno); prima salimmo per la scala in ferro della condotta forzata fino al bacino di carico, e di lì andammo a Devero, nella neve. […] Degli insegnamenti tecnici e pratici che riportai non discorro qui. Notevole l’impressione avuta salendo nel gelido mattino, fra neve e ghiaccio vetrato, la scala di ferro della condotta, fra i due tubi, con una pendenza di 65 gradi o 70 nel tratto medio, (il più ripido), e superando un dislivello di oltre 400 metri. Fu, tra l’altro, una bella fatica. (Giornale, SGF I 866)
è divinazione da poco profetizzare che questi appunti sarebbero stati utilizzati se Gadda avesse scritto l’articolo proposto. Così materiali sparsi, diversi ed eterogenei, strappati al corso del tempo, tentativi letterari, note di diario, lettere, confluiscono alla costruzione dell’articolo e tutto sommato finiscono per contare molto, molto di più dell’occasione-spinta. Le vere occasioni di Gadda risiedono infatti in quei momenti della sua vita, tratti dal dolore, dalla fatica, dalla strenua conoscenza, che si levano dal tempo e dalle opere, registrati non importa dove, ma di sicuro in una sorta di segreto, insondabile repertorio.
La seconda proposta di Gadda si richiama ad un modulo ripetitivo, di piccola serie, cui spesso egli informa la sua pubblicistica: «Un altro articolo che proporrei (e questo di più brevi dimensioni) sarebbe relativo a una operazione chirurgica (trapanazione del cranio): simile, ma nello stesso tempo dissimile, da quello che Le spedisco oggi a parte, stampato nell’Ambrosiano di jeri – oggi 14 marzo: questo riguarda una operazione viscerale e mi è costato veramente molta fatica». Anche questa proposta non ebbe seguito: del progetto si può comunque avere un’idea rinviando all’articolo scritto per L’Ambrosiano, Anastomòsi, che non a caso Gadda porrà poi a conclusione degli Anni, un titolo che privilegia un eccipiente primo della natura, il tempo, il tempo della terra e delle opere. Anastomòsi è un po’ l’epica del lavoro e dell’esperienza che a prezzo di una «spaventosa effrazione» riescono ad estirpare dall’uomo «ritornato ad argomento di natura» se non l’impossibile male invisibile, almeno il male visibile. Ancora di un altro impegno di Gadda si parla nella lettera, questa volta, come si desume dal testo, di una recensione richiesta dalla redazione: «La recensione della Storia della Matematica [si tratta della Piccola storia della matematica da Pitagora a Hilbert di Egmont Colerus, pubblicata da Einaudi nella collezione «Saggi» nel 1939] è stata aggiornata, ma la farò in ogni modo, se anche la N.A. non potrà più accoglierla».
Facile vaticinio prevedere che mai Gadda avrebbe assolto (come avvenne) l’impegno pure assunto nella sua veste di scrittore-tecnico. Per chi è del tutto digiuno di una specifica preparazione o cultura, l’aspetto tecnico e quello scientifico potevano fare tutt’uno, così come quello applicativo e quello teorico: anzi per l’indòtto la teoresi poteva sposarsi meglio della meccanica con l’arte o la letteratura. Ma Gadda era troppo lontano per interessi, gusto e vocazioni dai processi formalizzanti per poter considerare la matematica – lui pur fornito di ottime nozioni matematiche anche superiori – come qualcosa di più di un semplice mezzo, strumento, cioè come un sistema formale in sé autonomo. Così il libro di Egmont Colerus sarà rimasto intatto nello scaffale dell’ ingegnere (la Piccola storia della matematica è conservata tuttora tra i libri di Gadda presso la Biblioteca teatrale del Burcardo di Roma).
Alle proposte di Gadda fa seguito una controproposta – o almeno così è da presumere – della Nuova Antologia, che commissiona un articolo celebrativo della «giornata della tecnica» (siamo nell’ambito, come si vede, dello scrittore-ingegnere) indetta dal regime in data, al momento, ancora da definire:
Se l’articolo [risponde Gadda il 29 marzo 1940] dovesse essere dedicato proprio alla «giornata della tecnica» – (cioè con la «giornata» come protagonista) – io mi sento alquanto impreparato: ma penso che un tale stretto obbligo sia forse più dei quotidiani che della N.A. = Sarei lieto, invece, di poter mandare alla N.A. un breve articolo o saggio, di cui Voi potrete assegnare le dimensioni massime, relativo alla «psicologia» dei tecnici; e ci sarebbe da scrivere un volume. «Stati d’animo» e «mentalità» e «urti» e «amori» ed «entusiasmi» dell’ingegnere, del capo-tecnico, dell’ operaio di fronte allo sforzo, al sacrificio che la «tecnica» esige: e nel cerchio del lavoro collettivo. Comunque cose «vissute» o almeno percepite in una esperienza e in una visione diretta, non parole. Vorrei evitare facilità occasionali. | Attendo Vostre istruzioni: propongo un articolo di 5 ÷ 6 pagine della N.A. = Se l’articolo dovesse trattare determinati argomenti, avere cioè un particolare «contenuto», – tale o tal’altra industria, tale o tal’altra provvidenza statale specifica – allora penso che occorrerebbe una preparazione che non ho: e sarebbe forse il caso di rivolgersi a competenti di ben maggiore levatura. | Dell’onore fattomi da S.E. il Direttore [Luigi Federzoni] pensando al mio nome, vogliate, Ve ne prego, ringraziarlo nel modo più sentito, esprimendogli la mia profonda e deferente considerazione, nonché il mio spirito di «disciplina».
Segue a pochi giorni di distanza, il 2 aprile, una cartolina postale nella quale Gadda riafferma con forza il suo progetto:
Confermo a titolo prudenziale la mia lettera del 30 u.s. [in realtà 29] in risposta al Vostro biglietto relativo alla «giornata della tecnica» e a uno scritto per la N.A. su tale argomento. | Nella lettera stessa proponevo un tema, in relazione a quanto da Voi chiestomi, spiacente di non aver avuto maggiori informazioni qui a Milano [sulla data precisa della celebrazione].
è piuttosto raro trovare nell’epistolario gaddiano una posizione così ferma, aliena cioè da qualsiasi compromissione o cedimento di fronte ad una proposta di collaborazione. Ma tant’è. L’argomento indubbiamente stava a cuore a Gadda, al punto di sovrapporsi progettualmente alla stessa committenza, quasi che l’articolo-saggio fosse già stato scritto e nessuna modifica fosse più possibile apportare, o meglio che l’autore non fosse disposto in alcun modo ad apportarne.
Il deciso atteggiamento gaddiano – ma quanto è difficile immaginare un Gadda che impone un suo articolo – è premiato: la sua cartolina si incontra con l’accettazione da parte della rivista del suo progetto: «Vi ringrazio» – risponde con sollecitudine a Baldini il 6 aprile 1940 – «della conferma che mi date circa l’articolo tecnico-psicologico, che sarà approntato entro il mese di Aprile, nel formato da Voi stabilito di 5 pagine della Rivista».
Sorprende la scadenza così ravvicinata, appena 25 giorni dal consenso ricevuto dalla rivista e per un articolo-saggio di cinque pagine piuttosto nutrite quali quelle della Nuova Antologia. Conoscendo le promesse di Gadda, ma conoscendo soprattutto i suoi tempi di lavorazione piuttosto lunghi fra preparazione, documentazione, stesura, revisione, ecc., vien fatto di affermare con sicurezza – e invece erroneamente – che egli non avrebbe onorato il suo impegno alla scadenza prestabilita.
In data 24 aprile 1940, diciotto giorni dopo, scrive sempre a Baldini: «Sono stato trattenuto a Milano da arretrati di lavoro: e credo che solo a fine settimana potrò librarmi verso Roma [la venuta a Roma riguarda un premio di L. 2000 che l’Accademia d’Italia gli aveva concesso]. Ho già iniziato l’articolo per la N.A. circa la giornata della tecnica: e spero di poter mantenere la consegna a fine mese». Ancora con una cartolina in data 2 maggio 1940 rassicura Baldini: «Sto lavorando “accanitamente” all’articolo tecnico. è già redatto, ma per ricopiatura, perfezionamento, qualche accertamento, ecc. mi occorrono ancora 2 giorni di lavoro. Chiederà 7 pagine N.A. anziché 5. Ve lo spedirò sabato a mattina [4 maggio 1940] e lo avrete domenica».
A stare alle notizie di Gadda, malgrado gli impegni arretrati, l’articolo iniziato il 24 aprile è già scritto il 2 maggio, cioè in solo 8 giorni. Non solo, ma è venuto più lungo del previsto: 7 pagine della rivista anziché le 5 stabilite, quasi un 50% in più. Raramente i rendiconti gaddiani registrano lavorazione a tempi così brevi: per un articolo, poi, in cui il periodo di avvio, di preparazione, di documentazione incideva in proporzione elevata. Si consolida il sospetto che buona parte del testo dell’articolo preesistesse alla richiesta della Nuova Antologia o, se si vuole, che Gadda abbia utilizzato largamente parti di un suo scritto più ampio conservato nei cassetti.
L’articolo non ha ancora un nome. Scrivendo a Baldini, Gadda parla di «articolo-saggio», «articolo tecnico», «articolo tecnico-psicologico», «articolo per la giornata della tecnica».
Non si crede di sbagliare, però, affermando che il titolo fosse già in mente a Gadda: Tecnica e poesia, un titolo binario non certo desueto per lo scrittore e comunque di sicuro non redazionale; un titolo infine per nulla celebrativo, come d’altronde per nulla celebrativo è il testo. Senza il sussidio delle lettere di Gadda a Baldini sarebbe stato piuttosto difficile, se non impossibile, indovinare la genesi esterna di Tecnica e poesia.
Ma torniamo alla microstoria del saggio. In data 7 maggio 1940 Gadda comunica trionfalmente a Baldini: «Vi ho spedito oggi, con un poco di ritardo sulle promesse, l’articolo per la “giornata della tecnica”: mi sono studiato di essere il meno noioso possibile, ma non so se sarò riuscito ad esservi grato». Poi continua, e qui inizia un piccolo mistero:
L’articolo comprendeva, in bozza, una seconda parte, riguardante qualche mio ricordo e impressione su tecnici e operai da me conosciuti. Tuttavia mi sembrò che ciò non potesse gran che interessare il pubblico, mentre per una trattazione seria e sistematica della «psicologia» del tecnico occorre un volume: e non mancano volumi al riguardo. | Credo che l’articolo speditovi arrivi ad occupare le 5 pagine da Voi assegnate. La seconda parte (16 cartelle dattiloscritte, se mi mettessi a elaborarla definitivamente), ne chiederebbe altre 6 ÷ 7 di Nuova Antologia. Potrei inviarvela soltanto a fine settimana.= | Vedo che la giornata della tecnica è stata trasferita al 2 giugno: e questo mi ha salvato.
Che cosa è accaduto? L’articolo che doveva occupare 7 pagine della rivista, ora ne occupa a malapena soltanto 5. Una parte, la seconda, quella del vissuto di officina e di cantiere, promessa sin dall’inizio, sarebbe stata estromessa e comunque non potrebbe essere inviata prima di quattro-cinque giorni. È probabile che, con la scusa che questa parte difficilmente potesse interessare il pubblico, Gadda, non volendo procrastinare l’invio, abbia semplicemente preso tempo, mandando soltanto una parte dell’articolo. È solo una congettura. Due giorni dopo, il 9 maggio, Gadda non avendo ricevuto conferma dell’arrivo in redazione del suo articolo, ne invia una seconda copia, facendo seguire nella stessa giornata una lettera a Baldini dove chiede, preoccupatissimo, a proposito del suo testo: «Vi sarei grato se poteste dirmi che lo accettate o no, prima della mia partenza, fissata per domenica 12. Verrò a Roma, ma devo fermarmi a Grosseto per ragioni giornalistiche 2 ÷ 3 giorni. Sarò a Roma solo il 15 sera».
è ipotizzabile quindi che, con la sua visita a Roma, Gadda abbia consegnato anche la seconda parte dell’articolo, ché il testo di Tecnica e poesia occupa, nel fascicolo dell’1 giugno 1940 della Nuova Antologia (Gadda 1940j), ben 9 pagine, quasi il doppio rispetto alle cinque annunciate e comprende, come seconda parte, un ampio stralcio autobiografico.
Il regesto della corrispondenza gaddiana segnala ancora in data 25 maggio un ringraziamento a Baldini «per la ospitalità e la gentilissima accoglienza». E ancora, in merito ad eventuali collaborazioni:
Ora mi attendo da un giorno all’altro un richiamo militare [in realtà il 1. capitano di complemento Carlo Emilio Gadda era stato trasferito nella riserva perché giudicato permanentemente inabile al servizio militare fin dal 1937], e ogni proposta di collaborazione cadrebbe nel vano. Passando da Firenze, ho dato un fugace sguardo alla mostra del ’500 toscano: (più rigorosamente artistica e pittorica di quanto non fosse la variopinta Leonardesca). Se fossi libero in giugno-luglio, Vi avrei chiesto, nel caso che mi riteneste idoneo a parlarne in una variazione, di fare un breve articolo per la N.A. Ma così è impossibile prendere impegni. E poi, forse, ci vuole un competente di pittura; perché si tratta (in sostanza) di quadri.
Singolare come sempre la proposta gaddiana per un articolo ed insieme la minuta esposizione di tutte le ragioni per non poterlo (o doverlo) fare. Ma qui è doveroso segnalare l’interesse di Gadda per le arti figurative, anche se la sua bibliografia non rende completa giustizia, ché le voci riguardanti i pittori sono piuttosto rade. C’è da dire comunque che l’attenzione di Gadda per la pittura ha anche una valenza letteraria, nel senso che l’idea del disegno, dell’abbozzo è all’origine della sua prosa. La lettera conclude: «Attendo il fascicolo del 1. Giugno, se non fosse troppo chiedere, gradirei qualche estratto del mio articolo».
Sempre sulla pubblicazione di Tecnica e poesia Gadda ritorna il 18 luglio 1940, di passaggio a Roma, scrivendo in un biglietto a Baldini:
Vi sono grato della ultima ospitalità: e spero che forse possa avverarsi la mia speranza (un giorno), di darvi un racconto, ossia di essere autorizzato al racconto. Per ora non ne ho alcuno ultimato. Il «saggio» o «variazione» mi tenta molto: ma sono troppo lontano dalla civiltà, con le mie idee.
Vale la pena di confrontare questa dichiarazione con quanto scritto dallo stesso Gadda nella bandella firmata con un asterisco dei Viaggi la morte (1958), in sede di un bilancio consuntivo della sua attività di «opinante edito»:
Saggi, brevi saggi, è il nome che nelle letterature occidentali si suol conferire a un siffatto genere di lavorucci. Meglio forse varrebbe, per il libro che ci occupa, il francese Entretiens. Il lettore vi potrà scorgere, a dispetto di qualche impressione momentanea, una coerenza tonale nell’istruttoria e nel giudizio delle cause, lievi cause: quella coerenza che al secol nostro si usò chiamare una linea. Il guaio è che la linea del Gadda, le più volte, s’impenna e diverge dalle linee più accreditate: donde la severa imputazione che gli vien fatta, non aver egli avuto la reverenza debita alle linee degli altri, rette o curve che fossero.
Ci sarebbe da aggiungere, un po’ malignamente, che qualche peccato di reverenza Gadda lo ha commesso, anche se più che di vera e propria adesione ad una linea che in fondo gli apparteneva ben poco, si può parlare invece di quell’eterno suo timore che nessuno lo cercasse, che nessuno l’invitasse a collaborare, timore che è alla base di tante mistificazioni gaddiane – da intendersi anche come captatio benevolentiae – almeno per quei tardi anni del regime fascista.
La corrispondenza di Gadda con Baldini si conclude con una lettera del 18 giugno 1943 con la quale informa di aver fatto spedire una copia degli Anni e precisando che «Alcuni degli scritti che vi si contengono sono praticamente inediti: uno Tecnica e poesia è stato pubblicato nella “Nuova Antologia”, se qui, pure, figura ampliato». Si tratta, infatti, di due aggiunte: una, la digressione intorno alla celebrazione di antichi riti romani, l’altra, una reminiscenza storica della battaglia di Jemmapes, vinta dal generale della Francia rivoluzionaria Dumounez.
La collaborazione di Gadda alla Nuova Antologia, sempre sul risvolto degli articoli-saggio (in quello stretto giro di anni fra il 1940 ed il 1943 lo scrittore sembra denunciare una netta preferenza per tale genere), conta altri due lemmi: uno, I nuovi borghi della Sicilia rurale, cui più sopra si è fatto cenno per illustrare la complessa struttura delle fatiche «pamphletaire tecniche-propagandistiche»; l’altro che conclude i rapporti di Gadda con la rivista, I Littoriali del Lavoro (Gadda 1941f; Gadda 2005a: 133-47), un articolo che proprio per il suo carattere celebrativo potrebbe essere in qualche modo posto a confronto con Tecnica e poesia (o almeno con l’intenzione redazionale che presiedeva al testo); un confronto comunque che non può che evidenziarne le differenze, più che i punti di contatto.
Infatti I Littoriali del Lavoro è un eloquente esempio di giustapposizione di materiali diversi: una prima parte piuttosto ampia è un excursus sull’economia ed il lavoro attraverso i secoli, di per sé un testo di tutto rispetto nella pubblicistica gaddiana, e di registro piuttosto alto, cui segue un paragrafo relativo ad un vissuto di cantiere e di officina; una seconda parte, quella che conclude l’articolo, del tutto staccata ed estranea rispetto alla prima e dove l’intento celebrativo, ossequioso ed encomiastico alle direttive del regime, perviene ad una scrittura che sarebbe del tutto irriconoscibile se non fosse per il tono aulicizzante e paludato che ne tradisce la paternità. Viene naturale il sospetto che la prima parte preesistesse in qualche forma alla seconda scritta currenti calamo, ma certamente non senza fatica. Cioè che alle due scritture presiedessero istanze del tutto diverse.
Accanto a Tecnica e poesia e ai Littoriali del Lavoro (si intende per questo testo solo la prima parte) è da collocare anche L’uomo e la macchina, pubblicato sul quindicinale di attualità Panorama del 27 aprile 1940 (Gadda 1940i), quando cioè l’officina gaddiana è in piena attività per la preparazione dell’«articolo tecnico-psicologico». A parte le coincidenze tematiche riscontrabili fra Tecnica e poesia e L’uomo e la macchina, i tre testi sono sul piano stilistico correlati su di un unico registro piuttosto alto, ed al punto da far sospettare che trattasi di frammenti, pur di diversa ampiezza, di un unico vasto testo scritto (o pensato), una summa sull’argomento caro a Gadda del «lavoro umano», andato poi disperso nel tempo (o non realizzato). Non solo, ma il sospetto si estende anche ad un frammento pubblicato come inedito molto più tardi, venticinque anni dopo, con il titolo Il dolce riaversi della luce – sottotitolo fra virgolette: Il tempo e le opere (Gadda 1966a). Anzi questo sintagma, il tempo e le opere, già presente nella segnalazione autentica (cioè di Gadda) degli Anni su Letteratura e che ben sottolinea le componenti fondamentali del volume (dove, con aggiunte, sono appunto riuniti fra gli altri Tecnica e poesia e L’uomo e la macchina), potrebbe benissimo essere il titolo del lungo saggio-variazione da cui Gadda ha poi estratto, ritagliato articoli o pezzi di articoli (fra l’altro un titolo binario caro alla consuetudine gaddiana).
Ancora, pur rimanendo sempre come è ovvio nel campo delle ipotesi, quando Gadda nella lettera a Baldini del 29 marzo 1940 parla ampiamente di «psicologia dei tecnici», dei «sacrifici che la tecnica esige», del «cerchio del lavoro collettivo» sembra riferirsi non tanto all’articolo che egli vuol scrivere (ché una tematica così vasta – «ci sarebbe da scrivere un volume» – difficilmente poteva essere contenuta in un articolo) quanto invece ad un testo sul quale da anni aveva meditato e lavorato.
Si ipotizza, insomma, che anche per il genere saggio-variazione Gadda abbia talvolta operato come per la narrativa, dove dai grandi ma incompiuti affreschi di romanzo, quali La meccanica e Un fulmine sul 220, ha tratto e pubblicato frammenti proponendoli come racconti.
Per altro con operazione niente affatto arbitraria, ché la sua tipologia del romanzo è in fondo una sorta di aggregazione di costituenti narrative, grumi di racconto, disposti secondo il canone dell’ incompiuto, ma anche con l’aspirazione ad un continuum senza alcuna cesura. Ciò vale in un certo senso anche per l’ambizione gaddiana, tanto simile a quella per il romanzo (ma a differenza di questa mai realizzata), del grande saggio, il trattato, la «memoria accademica» dedicata proprio ad uno dei temi centrali della sua mai intermessa meditazione: il lavoro umano nelle sue secolari trasformazioni. Appunto il tempo e le opere.
3. Gadda illustrato
Una ideale bibliografia iconografica dei testi gaddiani dovrebbe registrare, accanto agli articoli pubblicati dall’ingegnere (qui la menzione professionale è d’obbligo) sulle Vie d’Italia corredati da un anodino materiale illustrativo (taglio delle fotografie e didascalie del tipo cartolina illustrata, secondo il gusto un po’ vecchiotto della rivista geografica), anche una breve serie di pezzi – in tutto tre – pure illustrati apparsi sul quindicinale di attualità nello stesso breve giro di tempo (per gli articoli su Panorama il 1940). E ciò non certo per gusto di simmetria, quanto invece di opposizione, ché la breve serie di articoli si giova della grafica estremamente moderna della rivista.
Panorama inizia le pubblicazioni a Roma nel 1939 come «enciclopedia della attualità». Formato libro, diretta da Raffaele Contu e per la parte editoriale da Gianni Mazzocchi, proponeva una formula del tutto nuova: testi brevissimi, rapidi ma completi repertori di notizie, numerosissime rubriche secondo una suddivisione per materie che richiamava curiosamente quella della fortunata Nuovissima Enciclopedia Pratica Bompiani (1938). Trasferita nel 1940 la redazione a Milano, la rivista cambia formato (in quarto) e soprattutto impostazione: ad una rigorosa, severa adesione all’attualità subentra un’indiretta e più ampia illustrazione dei principali eventi; ma soprattutto la rivista registra ora una particolare attenzione agli aspetti di costume, alle consuetudini di vita, alle curiosità. Pubblica anche racconti di autori come Moravia, Brancati, Comisso. Il formato più grande consente una elegante disposizione del ricco materiale illustrativo (fotografie a piena pagina, impaginate senza alcun margine secondo una grafica allora d’avanguardia). Nel periodo in cui Gadda collabora a Panorama la rivista è diretta dall’architetto urbanista Giuseppe Pagano, fra l’altro fondatore e direttore insieme a Edoardo Persico di Casabella, la rivista di architettura alternativa alla cultura imposta dal regime. Fra i redattori di Panorama il poeta salernitano Alfonso Gatto, divenuto all’epoca milanese d’elezione.
Questa la cornice. Quanto al quadro, cioè gli articoli di Gadda, la prima sorpresa è la scansione, senza soluzione di continuità dei tre pezzi: Fiera a Milano, Terra lombarda, L’uomo e la macchina. Essi infatti vengono pubblicati in tre numeri consecutivi della rivista (Gadda 1940e, 1940h-i). Caso piuttosto raro per un collaboratore intermittente come Gadda e tenuto conto anche che in quel periodo il carico di impegni assunti lo opprimeva più del solito:
Ora tutti mi sono addosso [scrive a Leone Traverso il 3 maggio 1940] e, per soddisfare a tutti, dovrei scrivere un articolo al giorno, io che sono il vero tipo adatto per scriverne uno al mese. Eccoti la lista degli inviti pressanti, reiterati, minacciosi: Prospettive di Malaparte, Primato di Bottai, Civiltà di Federzoni-Cecchi, Nuova Antologia di Federzoni, Gazzettino di Venezia – Cantalamessa, Messaggero di Roma – Malgèri, Lettura di Simoni-Piovene, La Ruota di Petroni, La Sera di Damiano ed Emmanuelli, ecc. ecc.: Panorama ha già avuto mia prosa, e ha pagato. Darò dei magri acconti a tutti e poi li manderò in collera con le mie carenze, assenze, inadempienze e promesse da marinaio. (Gadda 1950f: 45)
Circa le inadempienze basta scorrere la bibliografia degli scritti per accertarsene. Comunque, indubbiamente Panorama ebbe senz’altro un trattamento di favore dovuto, non è escluso, sia al tipo di rivista, sia anche alla ricca dotazione di immagini che soleva assegnare agli articoli (come avvenne puntualmente anche nel caso dei testi di Gadda).
Si affermava infatti in quegli anni nella stampa italiana una cultura fotografica, della quale antesignano era stato Longanesi con il suo Omnibus, una cultura che era anche indubbiamente figlia del nuovo procedimento tipografico, il rotocalco. Il servizio fotografico su alcuni periodici finiva col sostituirsi all’articolo o meglio il testo scritto diventava semplicemente un commento se non una didascalia delle immagini. Il periodico allora più avanzato su questa linea era il settimanale Tempo (sul quale Gadda pubblica Montale, o l’uomo mùsico – Gadda 1943c) diretto da Alberto Mondadori e con Bruno Munari direttore artistico responsabile dell’impaginazione.
Dei tre articoli di Gadda pubblicati su Panorama ed illustrati abbondantemente con riproduzioni fotografiche a tutta pagina o inframmezzate al testo, due, Fiera a Milano e Terra lombarda, sembrano essere stati redatti sulla base delle fotografie che li accompagnano, tanto i testi aderiscono non solo tematicamente, ma addirittura nella enumerazione e descrizione particolareggiata degli oggetti e dei paesaggi a quanto riprodotto nelle illustrazioni. (5) Per Terra lombarda, poi, si tratta di qualcosa di più di un sospetto perché già nell’incipit del testo gaddiano sono richiamate esplicitamente le aerofotografie che illustrano l’articolo. Non solo, ma le conferenti didascalie poste in calce alle illustrazioni che corredano i due articoli sono fedelmente riprese dai testi di Gadda. Diverso il caso dell’Uomo e la macchina, illustrato con immagini di officina senza un diretto riferimento al testo.
In particolare, per quanto riguarda Fiera a Milano (dove la puntigliosa enumerazione delle «carabattole» esposte nel mercato delle pulci milanese ha un preciso riscontro con le immagini, ma ricorda anche l’irresistibile enumerazione delle cianfrusaglie nell’Incendio di via Keplero e nell’Adalgisa), vale la pena di segnalare che a distanza di neanche un anno appare sul Tempo un articolo illustrato di Alberto Lattuada sul medesimo argomento, La Fiera di Sinigallia, (6) anche se ovviamente su un diverso registro, qui puramente descrittivo. Il futuro regista, allora appassionato fotografo e raccoglitore di fotografie antiche, era autore ovviamente anche dell’imagerie che corredava l’articolo, per cui nel caso specifico il problema della precedenza delle immagini rispetto al testo non si poneva. Come nota in margine si aggiunge anche che il titolo dell’articolo di Lattuada, La Fiera di Sinigallia, è il medesimo di una delle Passeggiate all’alba di Cletto Arrighi, comprese nell’opera collettanea Il ventre di Milano (Milano: Aliprandi, 1888, I, 115-20). Una curiosa coincidenza tematica e topografica che investe anche l’intervento di Gadda, qui richiamata non certo per istituire delle concordanze, semmai il contrario, ché il confronto fra il testo di Cletto Arrighi e quello di Gadda consente di misurare la distanza che separa l’orgoglioso radicalismo municipale dell’autore della Scapigliatura e il 6 febbraio dalla sottile parodia combinatoria alla Roussel dell’ingegnere.
Per tornare al rapporto testo-immagini occorre precisare che, se non si può certamente parlare per i tre interventi gaddiani su Panorama di semplici commenti alle riproduzioni fotografiche – ché comunque il libero, divagante ductus dell’autore della Cognizione non lo consentirebbe mai – tuttavia non si può fare a meno di rilevare la funzione indubbiamente importante riservata alla parte illustrativa. Cosa che non doveva affatto spiacere all’autore che nei suoi anni giovanili aveva professato accanto all’esercizio dilettantesco del disegno anche la passione per la fotografia. Di questa passione vi sono numerose tracce nel Giornale di guerra e di prigionia: «Mi giunse» – scrive sotto la data del 18 luglio 1916 – «il pacco più grosso speditomi da casa contenente la desiderata macchina fotografica (West-pocket-Kodak), delle negative […]» (SGF II 569). La Kodak lo seguirà nei suoi spostamenti al fronte come un oggetto privilegiato e necessario; e poi la rabbia violenta quando gli smarriscono i negativi, il dolore per la perdita del materiale documentario dopo la rotta di Caporetto.
La vis documentaria di Gadda non poteva non scoprire questo prezioso strumento. Così all’abitudine di tracciare schizzi, disegni nei taccuini di lavoro, nei diari si viene via via aggiungendo quella di fermare con l’obiettivo – per memoria oggettiva – un paesaggio, un manufatto, un volto. Il sottile ma resistente filo che per Gadda congiunge la parola scritta e l’immagine, l’appunto e lo schizzo e che ben s’intravvede nel suo interesse per la pittura ed il lavoro dei pittori, ha collegato anche la fotografia al testo. Soltanto, qui per interposta persona. Perché quella passione di cui è traccia eloquente nel Giornale di guerra e di prigionia sembra si sia poi come spenta, interrotta con il trauma della disfatta, della prigionia e del ritorno amaro del reduce. Rimane il rimpianto dei suoi lettori per il prezioso materiale andato disperso (inghiottito dal tempo, come d’altronde alcune sue carte) nelle dolorose vicende e nei traumatici trasferimenti che hanno segnato la sua vita.
Chissà se le immagini di Panorama che alluminano i suoi interventi abbiano reso un po’ più lieve a Gadda la fatica inchiostratrice, la servitù giornalistica cui si sentiva condannato «cavandone gloria nessuna, denaro poco, e noia molta», quella servitù che nella lettera già citata del 3 maggio 1940 a Leone Traverso avvelenava, a suo dire, la sua vocazione a contemplative meditazioni:
Università di RomaAddio! Non soltanto monti sorgenti dall’acque ma poetica e serena meditazione (sic!) ligure o tusca, in riva d’Arno e la gran villa, o tra Siestri e Chiaveri dove s’adima una fiumana bella, o tra le fontane di Brenta e di Piave! Tutto sprofonda in un guazzo d’inchiostraccio stento e occasionale senza occasione, per servire a destra e a sinistra con inverecondi becchezzi, come dici tu. (Gadda 1950f: 45)
Note
1. Lettera inedita a Silvio Guarnieri del 18 agosto 1948. Archivio Guarnieri, Feltre.
2. Lettera citata in Andreini 1988: 173.
3. Nuova Antologia 74, 404 (1939): 111-13.
4. La lettera inedita, come le seguenti che vengono citate nel testo, appartiene ad una serie – in tutto 12 fra lettere e cartoline postali autografe inviate da Gadda ad Antonio Baldini – conservata presso l’archivio Baldini di Roma.
5. L’osservazione è stata fatta da Liliana Orlando nella Nota agli Anni (SGF I 1264 n.).
6. Tempo 5, no. 84 (1941): 24-25.
Published by The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS)
ISSN 1476-9859
ISBN 1-904371-16-7
© 2007-2026 by Giulio Ungarelli & EJGS Manzotti Archive. First archived in EJGS (EJGS 5/2007), Supplement no. 5. Previously published in E. Manzotti (ed.), Le ragioni del dolore. Carlo Emilio Gadda 1893-1993 (Lugano: Edizioni Cenobio, 1993), 53-71.
Artwork © 2007-2026 by G. & F. Pedriali. Framed image: A Cabinet of Curiosities (Wunderkammern) – detail from an illustration in V. Levinus, Wondertooneel der natuur, tome II (1715), Strasbourg University.
The digitisation and editing of EJGS Supplement no. 5 were made possible thanks to the generous financial support of the School of Languages, Literatures and Cultures, University of Edinburgh.
All EJGS hyperlinks are the responsibility of the Chair of the Board of Editors.
EJGS is a member of CELJ, The Council of Editors of Learned Journals. EJGS may not be printed, forwarded, or otherwise distributed for any reasons other than personal use.
Dynamically-generated word count for this file is 9741 words, the equivalent of 28 pages in print.


