EJGS Supplement no. 5, EJGS 5/2007
Archivio Manzotti – Le ragioni del dolore
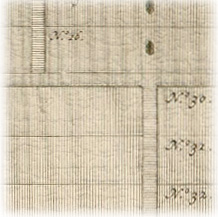 |
Premessa
Emilio Manzotti
Fermiamoci, per cominciare, sopra un campione gaddiano minimo: un frammento di paesaggio laziale del Pasticciaccio, (1) che cercheremo di commisurare alla sensibilità del lettore odierno:
Era l’alba, e più. Le vette dell’Algido, dei Carseolani e dei Velini inopinatamente presenti, grigie. Magia repentina il Soratte, come una rocca di piombo, di cenere. Di là dai gioghi di Sabina, per bocchette e portelli che interrompessero la lineatura del crinale, il rivivere del cielo si palesava lontanamente in sottili strisce di porpora e più remoti ed affocati punti e splendori, di solfo giallo, di vermiglione: strane lacche: nobili riverberi, come da un crogiuolo del profondo. (RR II 190)
è plausibile che un simile specimen di prosa descrittiva, tipico della maturità dell’autore, susciti ora alla lettura reazioni contrastanti: di rispetto perplesso, ad un estremo, per la preziosità del lessico («inopinatamente», «repentina», «si palesava»; il dantesco e dannunziano «affocati», già provato in Notte di luna, ecc.) e la corrispondente preziosità delle scelte morfologiche (si guardi al congiuntivo di «interrompessero» e alla stessa preposizione di «per bocchette e portelli») – caratteristiche di una scrittura iperletteraria, radicata in un clima culturale ormai lontano. Ad un altro estremo, si troverà forse l’ammirazione senza riserve nei confronti di una sintassi moderna per la sua varietà: alternativamente ascetica, cioè ridotta ai minimi termini, e esibita nella sua ricchezza. Dal punto di vista della sintassi, in effetti, l’apertura del passo che si è citato sembra anticipare, col «lucido gioiello» del minimo periodo iniziale e le ellissi verbali dei due seguenti appena più estesi (dalle predicazioni sapientemente incrociate), la linea di una sperimentazione minimalista alla Pizzuto. L’ultimo periodo, per contro, si distende nell’ampia voluta di una rappresentazione degna del più acceso Longhi, per concludersi poi, appositivamente e simbolicamente, su una concentrata comparazione d’origine («come da») che evoca, con probabile allusione shakespeariana, un misterioso crogiuolo-cauldron di sottoterra in cui si prepara inquietante l’avvenire. Quale sarà, se ve ne è una, la cifra stilistica complessiva del paragrafo? – maniera? tradizione? modernità?
Una lettura ripetuta e approfondita del passo, tuttavia, permette di cogliervi un tratto peculiare, che annulla l’apparente dissidio fra le tensioni contrastanti della maniera e dell’innovazione, o della tradizione e della modernità. Questo tratto può essere identificato con ciò che vorrei chiamare un assoluto dominio intellettuale esercitato ad un tempo sulla realtà extralinguistica e sulla combinatoria degli ingredienti linguistici; esso si manifesta, specificamente, nella funzionalizzazione di realtà e lingua ad uno scopo rappresentativo più elevato. La vis descrittiva piega ai suoi fini ogni aspetto del significante. La ricca polimorfia sintattica, gli eterogenei materiali lessicali, di tradizione alta o tecnicamente esatti (si pensi al geografico «bocchette» (2) e a «lineatura») o trasposti da altri ambiti (i marinari o militari «portelli»), il cultismo dei nomi propri geografici (in cui è condensata per lampi onomastici la storia della Roma latina) (3) – tutto questo viene impiegato per costruire una peculiare visione del paesaggio, per distendere su di esso la geometria di esatto reticolo, che lo ferma, lo rende leggibile, lo rende razionalmente reale, così come la vegetazione provvidamente trapiantata dalla mano dell’uomo fissa la mobilità della sabbia nell’incipit di una prosa di viaggio del Castello di Udine: «Lo sparto irretisce la duna». Il paesaggio così configurato in rigoroso anfiteatro di cime può allora caricarsi di valore simbolico, preannunciare gli eventi che si covano nel grembo della campagna, gravida di divenire per la vicenda del romanzo. Ora, ciò che accade di poter osservare sul caso particolare di un frammento è generalizzabile a gran parte dell’opera di Gadda. Ad assicurarne la modernità, a sottrarla al tempo (surrogando a volte l’assente o troppo defilata – come appunto nel Pasticciaccio – tensione degli accadimenti), sono soprattutto, al di là della complessità dei materiali lessicali e del pure stupefacente virtuosismo del gioco sintattico, la densità, la forza, le escursioni fantastiche della elaborazione concettuale.
* * *
Omaggio minimo alla memoria di Carlo Emilio Gadda a cento anni dalla nascita (il 14 novembre 1893), la presente raccolta (che riprende ed estende un precedente fascicolo della rivista ticinese Cenobio, il primo del 1993), comprende sette contributi e materiale iconografico inedito o comunque raro. (4)
I contributi, sommati, combinano il quadro d’assieme e l’approfondimento su temi specifici. Essi vanno dal profilo complessivo dell’autore, all’esame di sottogeneri, singoli testi, aspetti formali, sino alla testimonianza e ad un frammento di Wirkungsgeschichte. Eccone, in breve, obiettivo e contenuti.
Il Profilo introduttivo, (5) pensato didascalicamente come guida alla lettura, presenta anzitutto in forma compatta un sommario di temi e procedimenti caratteristici della scrittura gaddiana. Esso si sofferma poi, nella sezione centrale, più tecnica, a dettagliare la genesi complessa di un frammento lirico ed a illustrare una sorprendente soluzione al problema classico di come rappresentare la simultaneità degli accadimenti narrati; e propone in conclusione un orientamento bibliografico di massima. Al Profilo segue un ampio studio di Giulio Ungarelli (di cui si ricorderanno tra i molti meriti gaddiani i primi seri tentativi di ricostruzione bibliografica – qui evocati nell’affettuoso Tombeau di Una visita bibliografica) sulle occasioni giornalistiche della scrittura gaddiana. Sottesa a molti di tali contributi giornalistici, si apprende, è una architettura ternaria con un primo tempo tendenzialmente digressivo, di inquadramento storico, un secondo – le opere e i giorni – di descrizione di paesaggi agricoli modellati dal lavoro, e un terzo tempo tecnico-encomiastico, spesso vera e propria velina di regime. Il secondo tempo, «non facendosi più carico di alcuna esigenza documentaria od esplicativa», vede spesso l’inatteso insorgere di straordinari momenti lirici («Ho veduto i raduni bianchi dei cubi nella immensità della terra, quasi gregge portatovi da Geometria: e una limpida disciplina di masse, riquadri, diedri, gradi» ecc.). Nel capitolo centrale (La collaborazione alla «Nuova Antologia»: nascita di «Tecnica e Poesia») si individuano ulteriori pezze di quella summa sul «lavoro umano» particolarmente cara a Gadda e che abbraccia in ideale ciclo tutta la sua produzione, dalla «Sinfonia» (Notte di luna, in Adalgisa) del Racconto italiano al tardo (1966) Dolce riaversi della luce (Il tempo e le opere) (6) o addirittura al patetico Umanità degli umili del 1970. Il terzo capitolo (Gadda illustrato) affronta, infine, sulla scorta di tre articoli ampiamente illustrati comparsi nel 1940 nella rivista Panorama, specifiche manifestazioni del legame tra parola scritta e immagine, vale a dire, di un caso particolare della elevata leggibilità visiva delle descrizioni gaddiane.
In Immota manet, Liliana Orlando ricostruisce la storia esterna e interna di una prosa di viaggio – Antico vigore del popolo d’Abruzzo (rititolata poi Le tre rose di Collemaggio) – apparsa nel 1935 nella torinese Gazzetta del Popolo: servizio giornalistico che è ad un tempo splendido esemplare di prosa poetica. Qui, come nella sezione sulle nuvole del Profilo, il lettore è convitato al tormentato nascere della frase e del paragrafo entro quel peculiare processo gaddiano di sperimentazione combinatoria che è, almeno in parte, indipendente rispetto al testo singolo a cui è strumentale. I materiali così generati valgono in effetti in primo luogo come tessere di un repertorio in fieri: repertorio di gaddiane elegantiae a cui testi precedenti e successivi possono aver contribuito o attinto (si pensi a come una variante qui ricusata come i «chiari […] mattini» fosse stata adibita alcuni anni prima a suggellare il solariano Autunno – v. 80: «in ogni novo cuore, per chiari mattini» – prima di risorgere, in posizione cruciale, il I tratto della seconda parte, nel dettato stesso della Cognizione: «il male che risorge ancora, ancora e sempre, dopo i chiari mattini della speranza»). Il lettore rileverà ancora, «assunti a dignità di argomento», cioè a sezioni dello schema composito, temi gaddiani caratteristici: i temi del «popolo degli alberi» (l’usuale trattamento etico contrasta appena nella esecuzione l’esasperato dannunzianesimo del lessico e delle immagini: «e i popoli commisti dei pioppi, dei salci, degli olmi hanno alle rive la loro sede serena») o delle «galline», che «si molcono il gozzo per la infinita scaturigine dei coccodè» (per cui si ricorderà almeno, con le pagine celebri del Pasticciaccio, dei Viaggi di Gulliver, degli Accoppiamenti, ecc., la parodia pascoliana della Cognizione: «Una gallina in ritardo, di quelle che fan l’ovo al tocco, ruppe il silenzio: dalla vastità del quale gorgogliò fuori ancora una volta [...] il caldo, barocco gèmito, scandito in ebbrezza e in protervia: ecco un cocco, ecco un cocco, – ecco un cocco – che è»).
In un lavoro – il quarto della serie – a cui l’argomento stesso impone momenti di maggiore tecnicità, Maria Antonietta Terzoli esamina modi e funzioni nella poesia e nella prosa gaddiane di quell’istituto metrico – la rima – da cui Gadda dichiarava (7) (nel ’54) di «astenersi», in prosa almeno – «salvo che per consapevole gioco». L’idea centrale è che in Gadda la rima tenda a farsi strumento di una «opzione stilistica», quella di un «esuberante gioco retorico» fondato sulle «deformazioni di un nucleo fonico originario». La rima, e più in generale le ripetizioni di suoni, fungono dunque da catalizzatore della invenzione fonica e lessicale, che si irradia dalla sede della rima al cotesto più o meno immediato. È curioso che alla «rima vitanda», così come alla altrettanto vitanda «ripetizione continuata di un medesimo suono», Gadda avesse intitolato due «regole generali assolute» (la 8a e la 9a) di un opuscolo di servizio – a tratti ironicamente antifrastico rispetto alla pratica dell’autore – comparso anonimo nel ’53: le Norme per la redazione di un testo radiofonico. (8) Gadda vi prescriveva di «evitare le rime involontarie, obbrobrio dello scritto, del discorso, ma in ogni modo del parlato radiofonico. Una rima non voluta e inattesa travolge al ridicolo l’affermazione più pregna di senso, il proposito più grave»; prescriveva, inoltre, di «evitare le allitterazioni involontarie, sia le vocaliche sia le consonantiche, o comunque la ripetizione continuata di un medesimo suono». Ma più sorprendente ancora è che Gadda sviluppi in questo scritto l’intuizione formalista-jakobsoniana (ma avanzata quasi nei termini del dibattito celebre prima la musica-prima le parole) di un «poetico nonsense», di un «disturbo comunicativo» indotto dalle rime e in generale dalla elaborazione del significante. Questa intuizione, che è capitale tener presente per la lettura nonché della scarna vena poetica gaddiana di grande parte della sua prosa, va vista, credo, nel quadro più generale dell’ansia gaddiana di contrappunto (un vero modo della sua personalità): il bisogno cioè d’associare ad una singola linea rappresentativa altre linee consonanti o dissonanti con la prima. Certo «il parlato radiofonico non è pretesto o supporto a una frase musicale; deve essere compreso per se stesso; il suo valore deriva unicamente dal contenuto logico». Ma nel non-parlato della scrittura gaddiana il «contenuto logico» viene sistematicamente condotto ad interagire – per negarlo, irriderlo, sottolinearlo, complicarlo o semplicemente arricchirlo – con altri contenuti logici o paralogici, e come soprattutto qui importa con il significante stesso che lo veicola. (9)
Ancora, dopo, come si è già detto, la rievocazione di una visita bibliografica di Ungarelli a Gadda nella sua abitazione romana di via Blumenstihl, Raffaella Castagnola esplora coi ticinesi (10) Giovedì della signorina Giulia, un giallo di successo di Piero Chiara, un capitolo italiano della fortuna letteraria, per l’essenziale ancora da scrivere, di Carlo Emilio Gadda (una fortuna che dovrà un giorno annoverare oltre ad un prevedibile Plinio Martini – il Requiem del ’75 foisonne, a volte con la ingenuità entusiasta del neoadepto, di formulazioni e stilemi della Cognizione (11) – anche insospettate voci straniere). (12) Come il Pasticciaccio gaddiano, il giallo di Chiara – di cui è esaurientemente descritta la vicenda redazionale – prende lo spunto da un fatto di cronaca (qui per la prima volta identificato e ricostruito): le vicissitudini giudiziarie dei coniugi Bebawi. Ma nello stampo del giallo Chiara introduce del Pasticciaccio precise reminiscenze e opzioni costruttive: in particolare la figura della vittima dalla malinconica femminilità e quella di un commissario alla Ingravallo, dilettante psicologo o filosofo, ma soprattutto prossimo agli accadimenti e ai loro attori.
Viene infine, a chiudere la raccolta nella «lingua meravigliosa» di La Fontaine (Gadda dixit), un ampio scritto, arricchito di preziosi dettagli extravaganti, (13) del traduttore francese del Castello di Udine, di Eros e Priapo e d’altri testi gaddiani di ardua resa: Giovanni Clerico.
Il tema prescelto – Gadda e la traduzione – consente gli svolgimenti simmetrici del Gadda traduttore e del Gadda tradotto, tradotto, in particolare in francese. Così l’autore presenta da prima una rassegna della (ristretta) attività di traduttore di Gadda stesso: dallo spagnolo, (14) o per pochi versi o singoli componimenti anche da altre lingue (il latino, il francese, ecc.); come pure dei suoi occasionali interventi (per modo di dire) teorici sulla traduzione, o dei suoi giudizi (severi) su traduzioni di altri. Mutato verso, si stabilisce quindi un inventario, non privo di sorprese, (15) dei testi gaddiani disponibili in Francia. Si delinea (generalizzando maliziosamente dall’autobiografico) un curriculum ideale del buon traduttore (di Gadda), altrettanto sconfortante, per i potenziali candidati, dei desiderata di Lausberg per il filologo romanzo; e si termina con una applicazione per forza di cose impietosa dei principi appena enunciati ad una minutissima analisi dell’ultimo Gadda francese.
* * *
Il curatore esprime infine la sua gratitudine alla Redazione di Cenobio che ha accolto con favore il doppio progetto di un numero monografico della rivista prima e quindi del presente volume. E conclude ricordando l’immenso debito che ogni nuovo contributo, e in maniera più o meno diretta tutti quelli qui presentati, deve alla «lunga fedeltà» gaddiana di due maestri degli studi sul gran lombardo: Dante Isella e Gian Carlo Roscioni.
Université de GenèveNote
1. Si cita da RR II. I cinque volumi (1988-1993) della edizione delle Opere di C.E. Gadda, diretta da Dante Isella per la collana «I libri della spiga» di Garzanti, chiudono un’epoca in qualche modo pionieristica degli studi gaddiani, fornendo ai lettori e agli studiosi un corpus di testi accertati o in alcuni casi sapientemente ricostruiti e preziose note critiche (complessivamente la migliore introduzione filologica all’autore). Di fatto l’edizione sancisce l’assunzione di Gadda nel canone dei classici italiani.
2. Che Gadda, in una prosa abruzzese (nella quale compare a breve distanza anche il Velino), dichiarava caratteristico della orografia norditaliana: «Alti monti, con disegno e nomi d’una gravità chiara ed antica, circonvènnero me transpadano dagli orecchi pieni di pizzi, corni e bocchette».
3. Scontate le armoniche oraziane del Soratte (ma a dire il vero l’ovvia allusione a Odi, I, 9 «Vides ut alta stet nive candidum | Soracte» è presente qui solo nella trasposizione nominale di stet in rocca) e dell’Algidus (nei colli Albani), è più peregrina in Carseolani – la catena di monti tra le valli del Turano e del Salto, tra Lazio e Abruzzo: il nome viene dalla cittadina di Carsòli, anticamente Carsioli, sulla via Valeria – l’allusione a Livio e a Ovidio (nei Fasti); il Monte Velino, dal canto suo, non può non richiamare il virgiliano Velinus Lacus, ingresso dell’Averno.
4. Per il quale il curatore è grato alla generosità e alla cortesia di Giulio Ungarelli.
5. Comparso in una precedente meno estesa versione (e inserito in un contesto di riflessioni didattiche su «come presentare in maniera compatta un autore»), nella rivista bresciana per l’insegnamento secondario superiore Nuova Secondaria 9, no. 7 (1992): 29-45.
6. Notevole la coincidenza degli incipit rispettivi: «Un’idea, un’idea non sovviene mentre i sibilanti congegni degli atti trasformano in cose le cose ed il lavoro è pieno di polvere»; «Un’idea non in tutti è viva al momento del disegnare l’opera e deliberarne la esecuzione».
7. Per quanto egli stesso di rima pronta, come attesta, secondo una dichiarazione (SGF I 1119 – in cui Gadda stravolge la locuzione francese «du tac au tac», ribattere parola per parola) ricordata da M.A. Terzoli, l’esito della sfida di Betti ad evitare su una non facilissima rima in -acca (che pure è dantesca: Inf. «fiacca», «insacca», «lacca» e «vacca»; Pur. «biacca», «fiacca», «lacca») lo scoglio scatologico della rima goliardica.
8. Gadda 1953f (rist. anas. nel 1989). Il testo gaddiano, ripreso prima nel Caffè 16, 1 (1969): 3-18, e riedito nel 1973 (Roma, ERI, con riproduzione parziale nell’Espresso dello stesso anno), si legge ora in SGF I 1081-091.
9. Gli esempi di allitterazione vocalica citati da Gadda – i versi danteschi «orchestrati in a sulle sedi toniche» Suso in Itàlia bella ›,‹ giàce un làco (Inf. XX, 61), E quella ›a‹ cui il Savio bàgna il fianco (Inf. XXVII, 52) – richiamano analoghe orchestrazioni gaddiane in altre tonalità: ad esempio quella in |i| dell’Incendio di via Keplero: «con zampilli, spilli liquidi, dai serpi inturgiditi e fradici dei tubi di canapa»; o quella in |z| in un passo del Pasticciaccio ricordato nel Profilo:«Aveva fatto una cazziata al generale Rebaudengo perché i suoi carabinieri non erano buoni a raggiungerlo su nessuna strada o stradazia, il topazio maledetto, il giallazio».
10. Pubblicati in effetti originariamente nel Corriere del Ticino, tra il 2 febbraio e il 23 marzo 1962. Del resto, proprio nel Corriere del Ticino (del 2 dicembre 1992) il presente contributo di R. Castagnola è stato ante litteras pre-recensito da F. Roncoroni in un ampio intervento sui Giovedì, riproposti in veste scolastica corredata di note appunto da R. Castagnola e M. Camboni (Milano: Mondadori, 1992).
11. Si vada, per un assaggio, all’ultimo capitolo del Requiem, dove «Ed era tutto ciò che sarebbe rimasto del travaglio di una vita» riprende in tono minore l’apertura della seconda parte della Cognizione: «Ed erano quei muri, quel rame, tutto ciò che le era rimasto? di una vita» (integrandovi oltretutto il travaglio – leopardiano, oltre che gaddiano – della chiusa di altro tratto: «nel tacere della fatica di tutti ripreso per sé solo il travaglio»).
12. Tra cui sicuramente Héctor Bianciotti, nel cui L’amore non è amato (trad. dall’originale argentino – El amor no es amado – di A. Morino, Palermo: Sellerio, 1984), risuonano distinti molti echi della Cognizione. Si confronti ad esempio p. 62: «Lei, adagiata sul divano, lontana, intenta a doppiare i capi di una geografia incerta, quasi tentasse di scorgere in lui gli arcipelaghi ultimi, abbandonata all’ignorante speranza, intravvedendo forse, dalla terrazza della sua vita, la curva del mondo» ad un memorabile passo del V tratto della Cognizione, dove alla madre sembra di «scorgere la curva del mondo»: «dalla terrazza di sua vita», e dove, subito sotto, Alvise e Antoniotto «doppiano capi dalla realità senza nome incontro al sogno apparito degli arcipelaghi».
13. Uno fra i molti è l’indicazione dell’infedeltà della memoria gaddiana nei confronti del celeberrimo «Abat-Jour» di Cobianco e Neri, che compare, nella Fidanzata di Elio, come «Abat-jour, tu che spandi la luce blu…». La citazione contamina – credo del tutto involontariamente – secondo e sesto verso del ritornello: «Abat-jour | che soffondi la luce blu | di lassù, | tu sospiri, chissà perché, | Abat-jour, | mentre spandi la luce blu, | anche tu | cerchi, forse, chi non c’è più», regolarizzando quindi il metro con l’inserzione di un «tu» che del resto è anche appena sotto e che altrove è iniziale di verso («Tu ci facevi d’azzurro i bei sogni»).
14. Con risultati – di «distensione sovrana e, a suo modo, classica» (in cui è forse «il livello più alto di Gadda») – citati ammirativamente da Gianfranco Contini: come lo «stupendo elogio della fronde d’ulivo»: «Ell’è, dunque, luce alle luci. Consideratene la facoltà, l’onnipresente valore. Contro uggia e tristezza, un verde allegro e festante, giocondo ammanto dei colli e della riviera. Allegro, e quel che conta, perenne. Contro necessità e fame, un prezioso alimento. Contro le cieche tenebre dell’ignoranza, lume e splendore», la cui perfezione si misurerà sull’originale della Peregrinación sabia di Alonso de Salas Barbadillo (cfr. Gadda 1977a: 204-05): «Volved los ojos a miralla, y hallaréis en ella: contra la tristeza, alegre y festivo verdor, tan constante como alegre; contra la necesidad, regalo y sustento; contra las tinieblas ciegas de la ignorancia, lucidísimos y valientes resplandores».
15. Il trovarvi ad esempio Divagations et pagaille, vale a dire le brevi pagine di uno scritto (Divagazioni e garbuglio) caro, e molto, ai cultori di Gadda, ma di dubbia rilevanza per il lettore francese.
Published by The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS)
ISSN 1476-9859
ISBN 1-904371-16-7
© 2007-2025 by Emilio Manzotti & EJGS Manzotti Archive. First archived in EJGS (EJGS 5/2007), Supplement no. 5. Previously published in E. Manzotti (ed.), Le ragioni del dolore. Carlo Emilio Gadda 1893-1993 (Lugano: Edizioni Cenobio, 1993), 9-15.
Artwork © 2007-2025 by G. & F. Pedriali. Framed image: A Cabinet of Curiosities (Wunderkammern) – detail from an illustration in V. Levinus, Wondertooneel der natuur, tome II (1715), Strasbourg University.
The digitisation and editing of EJGS Supplement no. 5 were made possible thanks to the generous financial support of the School of Languages, Literatures and Cultures, University of Edinburgh.
All EJGS hyperlinks are the responsibility of the Chair of the Board of Editors.
EJGS is a member of CELJ, The Council of Editors of Learned Journals. EJGS may not be printed, forwarded, or otherwise distributed for any reasons other than personal use.
Dynamically-generated word count for this file is 3731 words, the equivalent of 11 pages in print.


