EJGS Supplement no. 5, EJGS 5/2007
Archivio Manzotti – Le ragioni del dolore
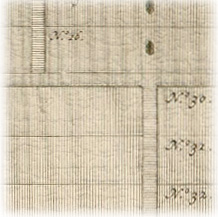 |
«Immota manet»:
variazioni e vicende di un testo gaddiano
Liliana Orlando
Tra gli elzeviri che frequentano con una certa assiduità le terze pagine dei quotidiani degli anni ’30 figura il genere appunti di viaggio. Vengono tratteggiati itinerari più o meno familiari, ma l’orizzonte dell’interesse non è esclusivamente nazionale e nemmeno solo europeo; più generosa attenzione sarà concessa, dopo il ’35, alle appendici coloniali. La Gazzetta del Popolo di Torino, diretta da Ermanno Amicucci, annovera, per cogliere solo qualche esempio tra il ’34 e il ’35, i contributi di Leonida Rèpaci, di Paolo Monelli (al primo è dovuta una serie di reportages extraeuropei, da New York alla California, dai Caraibi alle Filippine; al secondo una sequenza di servizi dall’«Africa Orientale», oltre a numerose cronache di viaggi attraverso l’Italia). Ma si leggono anche interventi sparsi di Comisso, di Bontempelli, degli amici di Gadda, Betti e Tecchi, di Ercole Patti, di Bruno Barilli.
Con tre interventi accomunati dal soprattitolo Taccuino di un italiano all’estero, Gadda, chiamato anch’egli a prestare la propria firma, inaugura nell’autunno del ’34 la sua collaborazione al quotidiano torinese, che prosegue fino alla primavera del ’35. L’estero, per Gadda, è l’Argentina, è la Lorena francese, che la memoria ricompone attingendo al ricordo degli anni della sua attività di ingegnere espatriato. Seguono due servizi sui macelli di Milano (i primi di una felice serie dedicata alla sua città) e un fastello compatto di sei pezzi sull’Abruzzo. Tutti questi scritti confluiranno nella raccolta del ’39 Le meraviglie d’Italia. (1)
Inviato speciale dal giornale per un reportage sull’Aquila e dintorni, Gadda affronta un itinerario turistico-culturale fatto di incontri ufficiali e occasionali, di contatti con la natura, con l’arte, con le nuove tecnologie. Il perfetto congegno della funivia del Gran Sasso d’Italia coinvolge nelle sue competenze tecniche e scientifiche un tale osservatore, non meno ammirato dall’edilizia moderna e funzionale di un albergo montano a gestione pubblica.
Ne ricava i sei servizi giornalistici che, pubblicati in sequenza, definiscono il percorso segnato dalle tappe al Gran Sasso, a Tagliacozzo, alla piana prosciugata del Fùcino, all’Aquila.
Il settimo contributo, sicuramente già steso in vista della pubblicazione, non trova più posto nella terza pagina della Gazzetta del Popolo radicalmente trasformata proprio in quel periodo (l’impaginazione passa da sette a otto colonne, gli articoli risultano tipograficamente molto più compressi). A troncare il rapporto di collaborazione non sembra essere Gadda, che lamenta in una lettera del giugno ’35 all’amico Bonaventura Tecchi: «La “Gazzetta del Popolo” non mi pubblica più, è quasi tramontata. Appena possibile andrò a parlare» (Gadda 1984b: 120).
Lo scritto, che segnava la conclusione dell’itinerario dopo la sosta all’Aquila, rimase inedito fino al ’43, quando verrà accolto, dopo una serie significativa di aggiustamenti, tra le prose poetiche dell’opera Gli anni, col titolo di Verso Teramo.
* * *
La sesta e ultima puntata edita del servizio giornalistico appare sulla Gazzetta il 28 marzo 1935, col titolo Antico vigore del popolo d’Abruzzo; (2) è un esemplare risultato di prosa poetica che travalica, nell’esito finale, i limiti definiti dall’intento originario. Pensato come articolo storico-celebrativo, ma permeato fin dall’inizio da una vena elegiaca nella raffigurazione dei luoghi e delle cose, lo scritto finisce per privilegiare questa componente, sacrificando il dettaglio della ricostruzione storica.
La procedura è singolarmente documentata dalle carte gaddiane che abbiamo potuto esaminare. (3) Gadda progetta una geometria rigorosa del testo, che rispetta solo parzialmente: assegna agli argomenti i corrispettivi spazi, ma durante la stesura finisce per lasciarsi prendere la mano, per poi doversi assoggettare a drastiche autoriduzioni, imposte dalla necessità di contenersi entro i confini della misura tipografica prevista.
Il piano di lavoro è attestato dal manoscritto-abbozzo dell’articolo (nella sua prima fase redazionale senza titolo) (4) che presenta, dopo la stesura quasi completa delle prime tre pagine, lo schema del restante progetto:
= Cenno storico e 3 colli, brevissimo 1/2 pag. = Pioppi ― Aterno 1/2 pag. + = Galline ― mura Federiciane 1/2 } 1, 1/2 = Collemaggio ― Celestino 5° 5 pagine = Edifici fascisti e finale 1 pagina } tot. 10 piene
La digressione storica (non così «brevissima», occuperà infatti una pagina e mezza del manoscritto) si innesta dopo la rappresentazione d’apertura della piazza principale dell’Aquila e della fontana dalle 99 cannelle. Sottoposta a una tormentata elaborazione, verrà drasticamente decurtata quando la bozza dell’articolo della Gazzetta era già stata composta. Scrupolosamente conservato tra le carte gaddiane, un ritaglio di bozza in colonna della giustezza di quella del quotidiano torinese attesta infatti l’avvenuta amputazione; i piombi della composizione sono inequivocabilmente gli stessi. Della definitiva stesura sopravvivono nell’articolo, dopo alcuni aggiustamenti, soltanto le poche righe iniziali (rr. 50-53).
Il «cenno storico», rimasto anche in seguito inedito, delinea per sommi capi i tentativi autonomistici vissuti dall’Aquila nel corso di sei secoli, e le incursioni subite ad opera dei diversi occupanti. Si comprende così come un passaggio oscuro del finale del testo pubblicato nel giornale (rr. 128-29) dovesse essere letto, nella stesura originaria, in correlazione con alcune notizie comprese nella porzione cassata. Si chiarisce infatti l’identità dei due personaggi storici a cui è fatta allusione, Filiberto di Châlons, principe d’Orange, generale di Carlo V, e Napoleone I, responsabili, si dice, del furto dell’argento alle tombe, rispettivamente, di Celestino V e di San Bernardino.
Il frammento espunto si legge qui per esteso:
L’Aquila anzi, specie di fronte ai Normanni e agli Svevi, si direbbe avesse costituito un elemento indesiderabile nella compagine dello Stato; divergente poi ed inossequente, o comunque infido alla potestà centrale del reame. Parte audacissima nelle rivolte promosse e capeggiate da Pietro, conte di Celano, e da suo figlio Tommaso, contro il «sultano battezzato» che aveva corte a Palermo. Ribelle ancora nel 1228 durante l’assenza di lui, crociato ed eretico, congiura con i comuni lombardi quasi in una tentazione continua di imitare il reggimento e di aggiudicarsi le libere fortune di quelli.
La battaglia di Cortenova (1237) e il perduto gonfalone de’ milanesi la deprimono: l’aiuta il Papa, Manfredi le rompe le corna, il primo Angioino la costituisce (per modo di dire) in comune, a rimeritarla, forse, degli aiuti palesi ed occulti cavàtine durante la campagna contro l’ultimo Svevo, che gli vàlsero di poterlo superare a Tagliacozzo.
Elegge l’Aquila i suoi «capitani del popolo» come i lombardi: e batte moneta libera, come i lombardi: mi assicurano i numismatici che dalla sua zecca uscissero 232 tipi, fra il 1382 e il 1556. Si sgranàvano, anno per anno, i secoli: i secoli coniatori di monete! Per lei vollero morire Attendolo Sforza, annegato nel Pescara, e Braccio di Montone, ferito assediandola.
Filiberto di Châlons, principe di Orange ed ex prigioniero di Andrea Doria, v’entrò invece senza che lo accoppassero il 2 febbraio del 1529 a ore undici, con tutta la bravura per non dir braverìa dell’esercito e il caravanserraglio dello stato maggiore imperiale. Ed è dopo quella bella festa che gli Aquilani «dovettero» erigere a loro spese il castello, l’alta e chiusa rocca che li terrà buoni e bravi, se non in perpetuo (secondo favoleggia sul portale la làpide), ma almeno per qualche anno o decennio.
«Securitati perpetuae regno rum gentium Carli V orbis pacatoris…» Si sgrànano i secoli. La rocca non li salverà dal fùlmine «di quel secùro» della scuola di Brienne e dalla sua fuggitiva masnada: «more solito», fu proprio durante il soggiorno all’Aquila delle truppe liberatrici che sparì di San Bernardino la teca d’argento racchiudente le venerate ossa del Santo. Le ossa, per fortuna, le lasciarono. Oh! non premeva tanto il metallo, quanto piuttosto il meraviglioso lavoro, che fu divozione e gloria degli orafi, dei cesellatori d’Abruzzo. E andò finalmente a pezzi, trafugato dalla caporalàglia rapace.
Privato di questo resoconto vivace, il testo nella redazione finale attenuerà gli effetti chiaroscurali derivati dall’accostamento di registri espressivi contrastanti.
Con passaggio repentino di tono, infatti, alla digressione storica si contrappone un brano dal tono interiorizzato e sommesso: che si realizza per reiterati tentativi, attraverso la dilatazione di un enunciato prima approssimativo e la sperimentazione di soluzioni provvisorie: (5)
Nel chiaro mattino decido che *›lo‹ devo dimenticare il passato → il passato ›è passato‹ ›non conta‹ ›deve sp‹ ›è bello‹ è il mio regno: *esso è combinato di biblioteche e di tarme → esso continuamente mi parla ed è combinato di deliziosi libroni e di tarme → esso continuamente mi significa ›le sue verità‹ la sua somma di cose che contengono impliciti ›e pure chiari‹ ma evidenti giudizi e talora durissimi: ma ho bastante coraggio a guardarli: è combinato di deliziosi libroni e di tarme.
Nella tormentata stesura si può cogliere il passaggio da una formulazione grezzamente enunciativa all’intensità dell’esito finale, dove frequenti sono gli incisi, insistita la punteggiatura, in un dettato franto e rallentato (rr. 54-57):
Nel chiaro mattino si insinua, per suoi segni nobili, il tempo: il tempo fluito, ch’è irripetibile agli atti, ed è il taciturno regno delle ànime. Esso, del continuo, mi significa la somma de’ suoi pensieri: e porta, alla mia conoscenza, impliciti ma evidenti giudizi. È consegnato alle chiese, ai palazzi, alle vecchie torri!
è un sunto del tema dell’elegia gaddiana, subito temperato, necessario correttivo, da un’inversione di registro, che culmina nell’immagine colorita della battuta conclusiva (rr. 57-59):
è combinato di deliziosi libroni, di tarme. Gli uni e le altre mi piacciono immensamente: quando il bacherozzo si mangia Aristotele, tutti mi prenderanno per un filòsafo.
* * *
Più fedele alla misura progettata, la realizzazione della sezione «Pioppi ― Aterno […] Galline ― mura Federiciane»: due pagine piene (incluso l’accenno ai «tre colli», questo davvero brevissimo), costellate di stratificati interventi correttori. Il tema gaddiano del «popolo degli alberi» appare già definito nella prima stesura («e i popoli commisti dei pioppi, dei salci, degli olmi hanno alle rive la loro sede serena»), ma acquista di intensità lirica dalle aggiunte successive, poco lontane dall’esito finale (rr. 71-75):
Per entro la stretta decede languido il fiume, corre il binario con argentati rimandi nel sole del mezzogiorno: tutte le imagini, con l’esalare dell’umido tremano nel tepore dell’autunno: e i popoli commisti dei pioppi […] sede serena,
a cui fa seguito, dopo la caduta di un riferimento di vago sapore petrarchesco, in un contrapposto bilanciarsi di scelte arcaicizzanti, l’aggiunta del passaggio:
lambiti ›dagli sbuffi di chiare acque‹ (6) da lucide acque alle piante, e da ›sbuffi‹ buffi, ›ai capegli‹ alle chiome, di fuggente vapore.
Intorno al tema «Galline», assunto a dignità d’argomento nello schema preparatorio, si compongono sottili variazioni che approdano infine al recupero di due immagini d’autore: di Catullo l’una, per il riferimento all’«acino ebbro», d’Ovidio l’altra, per il motivo delle «ombre divenute esigue» (rr. 84-87). (7)
è uno dei passaggi tormentatissimi in cui da una spoglia idea di base («meditano l’ovo di mezzogiorno e la infinita scaturigine dei coccodè») per aggregazioni via via più definite si completa l’immagine finale. L’acquisizione di una terminologia letteraria («si molcono/molcendo», «scaturigine») si accompagna al progressivo accumulo di verbi, sostantivi, aggettivi in raggruppamenti binari e ternari; è una tecnica costruttiva ricorrente nell’abbozzo gaddiano:
A
→ meditano l’ovo di mezzogiorno, *e si molcono il gozzo per la infinita scaturigine dei coccodè → molcendo la gola e predisponendola per l’improvvisa scaturigine dei coccodè → molcendo con qualche chioccolio sordo la gola e *disponendola alla disperazione per […] → atteggiandola alla disperazione e ›alla tragedia‹ ›al dramma‹ → atteggiandola e aggiustandola alla disperazione e alla gloria per […]
B
→ meditano l’ovo di mezzogiorno, molcendo con qualche acino ›ghiotto‹ ›più ebbro‹ ebbro la gola provandola e riprovandola e aggiustandola in un chioccolio sordo alla disperazione ›meridiana‹ e alla gloria, ›finchè diventi‹ *da essere poi la scaturigine improvvisa degli interminabili coccodè → ad un tratto esse irromperanno infinite dalla scaturigine meridiana dei coccodè, raccorciata ogni ombra → che, ›fatta esigua ogni ombra‹ divenute esigue le ombre, ad un tratto esse irromperanno infinite dalla scaturigine improvvisa dei coccodè.
* * *
La restante parte del manoscritto (sette pagine, dunque una parte preponderante nell’insieme del lavoro) è occupata dall’elaborazione del soggetto «Collemaggio ― Celestino 5°» con cui si chiude l’articolo.
L’ampia digressione lirica intorno alla chiesa romanica di Santa Maria di Collemaggio, fatta erigere da Pietro da Morrone (poi papa Celestino V) sul luogo dove si conservava una miracolosa immagine della Madonna, consente a Gadda di avviare il discorso intorno alla figura del papa del «gran rifiuto».
Una singolare attenzione sembra riservarla proprio al canovaccio storico: la trama degli eventi, nei suoi incisi grotteschi, si diffonde in ragguagli precisi, talora curiosi. La scelta finale, tuttavia, prevederà, anche questa volta, una rilevante riduzione, quando la composizione tipografica del pezzo era già avvenuta. Due ritagli di bozza della Gazzetta, del tutto simili all’altro di cui abbiamo fatto cenno, rendono palese l’intervento compendiario: un’operazione di sforbiciatura che appare evidente dal raffronto tra la lezione definitiva dell’articolo (rr. 104-10) e la soluzione provvisoria del primo stralcio di bozza:
Vacava, il Collegio, a sue cure, nelle mezze parole e ne’ silenzi interi, a Perugia: ed erano fra le maggiori pòrpore Latino Malabranca vescovo d’Ostia, Giovanni Boccamazza, Napoleone Orsino, Benedetto Caetani. Posava l’Angioino in bellurie e in un sollazzo grandissimo a Lucca con Carlo Martello suo figlio, a cui fulgèa già nella fronte la corona d’ogni terra d’Ungària. Era, per tutta Italia, un gran paventare lo scisma: e i due corni del detto scisma avevano paura e nome di Orsino, l’uno, e l’altro Colonna. Quando si mosse, propagata per mezzo l’Appennino, una voce, e la dicevan tutti che fosse venuta del «calavrese» l’abbate, di Giovacchino di Fiore, dotato di profetico spirito. «Dopo che la Sedia era due anni vacante sopra le dissensioni del Collegio e le macchinazioni de’ potentati, Papa sarebbe fatto […]».
Ma è soprattutto dalla sovrapposizione del penultimo paragrafo dell’articolo (rr. 118-23) col secondo ritaglio di bozza che si rivela più energica la potatura: l’operazione di forbici esclude dal resoconto ogni coloritura, cancellando i particolari gustosi dell’elaborazione originaria, a cui complice inclinava il compiacimento umoristico del narratore:
Così veniva la penitente beatitudine al sommo destino. Mossero il re Carlo Secondo e il re figlio ad incontrarlo al Morrone: «Gli fecero amendue una gran corte, con addestrarlo di poi, tenendo le redini di un’asina, su cui egli volle entrare nella città dell’Aquila». Dugentomila persone convennero qui da ogni terra d’Italia, e ciò ne attesta fra’ Ptolomeo di Lucca, autore della Historia Ecclesiae, che arrivò a presenziare la gloriosa vestizione in qualità d’inviato speciale. Ma è scritta, in Apocalisse, una terribile sentenza: «Praeterit figura mundi». Sicchè il cardinale Caetani, il qual forse la lesse, non costumava di perder suo tempo. Ai 18 settembre, in Napoli, il santo vegliardo, divenuto Papa e napolitano, impone con mano tremula il cappello e la porpora a dodici Principi nuovi: «Secondochè a lui piacque», leggiamo, come sopra, nel Muratori, «cioè sette franzesi, tre del regno di Napoli, il suo cancelliere ed appena un romano». E segue poi, il buon Proposto, ad attestarci negli Annali d’Italia che il vecchio «sì per la sua decrepita età come per la sua inesperienza era tutto dì ingannato da’ suoi uffiziali nel dispensar grazie e conferir le chiese». E Jacopo di Varagine, arcivescovo di Genova, soggiunge nuovo argomento a difesa: opinando che egli molte cose abbia fatte «de plenitudine potestatis» e molt’altre poi «de plenitudine simplicitatis».
«Puzza di favola», continua lo storico estense, «ciò che alcuni lasciarono scritto, avergli il suddetto cardinal Benedetto Caetani, che fu poi Papa Bonifazio ottavo, di notte, con una tromba, come se fosse venuta dal cielo (sic), insinuato d’abbandonare il pontificato». Certo è che tanto il Benedetto Caetani come re Carlo Angioino avevano tali mani in quella pasta, da poterla condurre a buon lièvito.
Levò la pasta. E levarono essi di quelle povere spalle quel manto che cinque mesi prima vi avevano gloriosamente imposto, fra il delirio di duecentomila fedeli. Addì 13 dicembre di quell’anno medesimo l’ottantaquattrenne Pietro del Morrone, in soglio Celestino V, fece quanto bastò per arrivare a guadagnarsi, davanti il secolo, l’oltraggioso motto di Dante. «Praeterit figura mundi!».
Oh! un altro motto ancora ebbe Dante (tale stok ne teneva in bottega) e licenziò col marchio migliore di sua fabbrica: e fu questo al Caetani: e suona, come ognun sa, per mezzo lo solfo d’Inferno:«Se’ tu già costì ritto, Bonifazio?»
Ritto, beninteso, ma coi piedi per aria.
Compressa in poche righe la cronaca della vicenda, ormai depurata di ogni traccia caricaturale, acquista maggiore rilievo, nella redazione finale, la «cornice» (rr. 90-103 e 124-32) in cui si inscrive la narrazione dell’episodio storico. La rappresentazione oscilla tra la percezione esteriore ed interiore delle cose: la bellezza di Santa Maria di Collemaggio, nel disegno decorativo della facciata, è assunta a segno di perfezione e di purezza, il luogo è teatro di un evento miracoloso che si estende nei secoli a superare le meschinità degli uomini.
La forma della prosa poetica raggiunge in questi paragrafi un alto grado di realizzazione. La scrittura gaddiana s’indirizza subito, di primo getto, a perseguire un registro aulico: forme come «musaico», «divota», «è vanita», «perlato», «cinereo», «abominazioni» sono già nella stesura di base. Ma sono riconoscibili i procedimenti consueti della tessitura gaddiana a impreziosire il dettato con progressive aggregazioni di soluzioni nobilitanti, con lo sviluppo di gruppi binari da un unico elemento linguistico originario (rr. 94-95): tacitamente percorre → tacitamente sfiora e percorre → sfiora, o tacitamente percorre; | nei gaudiosi mattini → nei fulgidi, gaudiosi mattini, sul cui esito prevarrà la predilezione per l’astratto (di solito accompagnato da complemento di specificazione) → nella speranza antelucana, nei fulgidi, gaudiosi mattini → nell’antelucano stupore, nel fulgore de’ gaudiosi mattini; da dove, rimossa la rima, discenderà → nella cènere antelucana, nel fulgore de’ gaudiosi mattini. Analogo stilema troviamo nel brano successivo (rr. 97-99) che in maniera esemplare dilata, per innesti graduali, la scarna asserzione metaforica di partenza: «La serpe è vanita tra i giacinti». Il passaggio perchè li cammini sulla terra diventerà → perchè li cammini *sulla bontà della terra ed infine → sulla chiarità della terra.
Le componenti liriche dominano il passo che si legge alle rr. 100-03. Fin dalla prima stesura è presente la felice similitudine tra il «cinereo mattino» e il «volo dei colombi» (ma inizialmente «volo» era «ala») e compare l’immagine della «rosea nube» involatrice di sogni. Questo l’abbozzo del brano: «Perlato e cinereo come l’ala dei colombi ecco mi si annuncia disceso dalle selve il mattino: donde la rosea nube fa vela, involando i miei sogni, e la misericorde preghiera». L’immagine lirica dell’alba si definisce per gradi: Perlato e rosa, o cinereo […] mattino: m’indugio *in quel cielo dove s’è smarrita la stella → in quel cielo ancor prossimo (ma l’aggettivo sarà poi sostituito da un corrispettivo trisillabo sdrucciolo → ancor così fievole) dove s’è smarrita la stella, donde la rosea nube discioglie sue vele contro l’oro e l’azzurro: portandosi docili sogni e la misericorde preghiera della notte. La mia vana preghiera. Ricorrente nella tecnica di elaborazione di Gadda l’aggiunta, in chiusura di un passo, di una frase nominale a rincalzo, che si spegne in una clausola ritmica.
Strettamente legato dall’intensa tonalità lirica l’ultimo paragrafo, in cui vengono ripresi elementi lessicali già impiegati o sperimentati (pur con qualche variazione ricorrono i sintagmi «fulgido mattino», «rupe stillante», «disegno purissimo»). La chiusa, solenne, si concentra sulla «salvata memoria del destituito» (prima «vecchio», poi «destituito») e sulla forza espressiva del predicativo «vindice», concordato con «voce», come si può comprendere dallo sviluppo delle lezioni: che la vindice voce della sua gente chiamò agli altari → che la voce del suo popolo rivendicò all’altare → che la voce del suo popolo vindice chiamò agli altari, superando l’oltraggio. Suggella il periodo ancora una cadenza ritmica (che richiama il modulo del cursus planus), a sottolineare, smorzandosi, la chiusa del paragrafo.
* * *
Nessuna traccia invece del progettato epilogo in chiave celebrativa «Edifici fascisti e finale». Chiamato a indossare i panni dell’ufficialità, Gadda se ne libera senza ripensamenti. La rinuncia non va letta tuttavia come l’arretrarsi prudente di fronte alla celebrazione dell’efficienza edilizia del regime ― altrove, e nella stessa serie di articoli sull’Abruzzo, ampiamente documentata ― ma di una precisa scelta stilistica in favore di una maggiore omogeneità tonale. Nel testo che viene a configurarsi, dopo le ultime riduzioni, sono infatti privilegiate componenti liriche e toni di interiorità sommessa.
Anche un titolo così enfatico e risoluto come Antico vigore del popolo d’Abruzzo trova poca rispondenza nel contenuto e nel tono dell’articolo, tanto da apparire, nella sua connotazione retorica, un tentativo di avvalorare il motivo della vitalità indipendentistica degli Aquilani, a cui si richiamava il «cenno storico» soppresso in bozze; senza voler escludere, del resto, che potesse essere stato imposto o quantomeno suggerito in ambito redazionale.
Più pertinente, certo più consono al carattere della prosa, il titolo che compare nel manoscritto, Immota manet, una scelta ascrivibile all’ultima fase del lavoro correttorio sul testo, quando il tema era stato completamente sviluppato. Nel sintagma di virgiliana reminiscenza (8) sembra intravedersi piuttosto l’allusione alla persistenza nel tempo della memoria e al valore di testimonianza del passato, di cui l’Aquila e i suoi monumenti, e in particolare Santa Maria di Collemaggio con la sua storia, sono segno.
La scelta del titolo Antico vigore del popolo d’Abruzzo resterà comunque esclusivamente legata alla pubblicazione sul quotidiano.
Nella riproposta in volume (Le meraviglie d’Italia prima, Verso la Certosa poi) (9) la prosa si chiamerà, in riferimento al particolare architettonico della facciata della chiesa, Le tre rose di Collemaggio; individuazione, per altro, dalla sfumatura sottilmente allusiva, indotta da un passaggio interno al testo (rr. 90-103): «Le tre rose od occhi, dal musaico del fronte, mi guardano con la limpidezza d’un giovenile pensiero. Una mano divota le ha colte […]».
Non è però la modifica del titolo l’unico intervento nel primo trasferimento della prosa in volume: se minimi sono i ritocchi apportati al testo, il grosso del lavoro riguarda l’aggiunta delle note, un procedimento che interessa parallelamente quasi tutti gli scritti delle Meraviglie, di provenienza giornalistica. Prevale un tipo di nota che potremmo definire esplicativa, anche se talvolta volutamente superflua in questa sua precipua funzione. Va colto invece, in tale aggiunta, l’intento del narratore di contrapporsi al testo con un commento sagace e pungente, dando spazio a toni di umorismo polemico appena sfiorati nella pagina a fronte. Si veda per esempio la nota a «circolo sanguigno» (r. 24):
Allusione evidente. La modellazione e la scultura dell’oggi (o dell’ieri?) esibiscono piedi e caviglie di smodata grossezza, mentreché l’osservazione diretta della natura sembra aver proposto all’autore esempii non pochi di caviglie sottili e di piedi regolari, e talora magri e vivi nella corsa e nel salto. (Bagni, palestre e simili osservatorii); (SGF I 161)
o quella relativa a «Castello» (r. 60):
Cioè «egli seppe disegnare, altri non sanno»: Seguita la polemica delle Belle Arti; (SGF I 162)
o il commento a «monocìpite» (r. 61):
Bicipite l’aquila imperiale ausburgica, del quale aggettivo gran consumo nell’ex-Lombardo Veneto e in tutta Italia. Questa è monocipite, ma pur sempre imperiale e straniera, e però invisa alla città dominata. (SGF I 162)
Ma sono soprattutto le note finali a modificare in maniera sostanziale la fisionomia della prosa, arricchendo di dettagli coloriti la vicenda dello sfortunato pontificato di Celestino V. Ad alimentare l’integrazione concorre il frammento del manoscritto sacrificato nella pubblicazione in giornale: è la riprova ― che non sorprende chi ha familiarità con le carte gaddiane ― di come nell’officina di Gadda i materiali di lavoro provvisoriamente accantonati vengano quasi sempre reimpiegati.
Nel caso in questione, il pezzo viene riutilizzato potenziando proprio le sue valenze umoristiche, amplificate attraverso l’osservatorio critico del narratore. Per cogliere solo qualche passaggio si veda il commento alla profezia di Gioacchino da Fiore («profetico spirito», r. 107 n. 2):
La diceria riguardante l’elezione di un papa povero e santo rientra perfettamente in quest’ordine di precognizioni del calabrese: anche se il guadagno, all’atto pratico, non fu tale da aver meritato il lusso d’un vaticinio. (SGF I 164)
O la laconica informazione su Benedetto Caetani («il Caetani», r. 118):
Per referenze su papa Bonifazio VIII non bisogna rivolgersi all’Alighieri: «Se’ tu già costì ritto Bonifazio?». (SGF I 165)
Di particolare efficacia espressiva risulta la nota conclusiva, aggiunta a rincalzo delle ultime battute del testo (rr. 129-30), che lievita soprattutto sul finale, nella valutazione della pertinenza della fonte storica primaria e nella riflessione sulla condanna dantesca di Celestino V:
Aggiunge poi il discriminante Ludovico, con quel suo modo di dire e non dire (ma, in fondo, finisce per dire: oh! Gli Annali d’Italia non sono un florilegio di storielle):
«…. Puzza di favola ciò che alcuni lasciarono scritto, di avergli il suddetto cardinal Benedetto Castani che fu poi papa Bonifazio VIII, di notte, con una tromba, come se fosse venuta dal cielo, insinuato di lasciare il pontificato….»
A un povero vecchio di 84 anni, già prigioniero, e non metaforicamente, di tutta quella politica angioina e gaetana, fargli sonare un trombone dal soffitto della camera da letto, di notte, al buio, con la minaccia del castigo di Dio…. C’era da morire di spavento.
Come spesso, Dante esagera: «per viltade»! a 84 anni! Vorrei vederlo lui. (SGF I 166)
Più articolata si offre la lettura delle varianti dello stesso scritto nel successivo segmento del percorso, dalle Meraviglie a Verso la Certosa; che comportano non solo un diverso assetto delle note, ma anche significativi ritocchi al testo, in sintonia con l’opera di rielaborazione stilistica condotta sulle altre prose che compongono la raccolta. (10) La tendenza di questo lavoro correttorio è la ricerca di maggiore fusione tonale: il che implica da un lato la nobilitazione del dettato attraverso scelte lessicali più preziose, dall’altro l’espunzione di elementi dissonanti dall’alta tonalità della prosa.
Nel primo caso ci troviamo di fronte, per limitarci ad alcuni esempi, all’assunzione di forme di tradizione letteraria, come «umidore» in luogo di «umido», «stanza» in luogo di «sede»; una diversa musicalità viene a definirsi nel contesto lirico del periodo (rr. 72-75): «Tutte le dolci imagini dell’autunno paiono tremare nell’umidore, di che la tepidità della terra viene esalando: e i popoli commisti dei salci, degli olmi, dei pioppi, hanno lungo le rive loro stanza serena». Degna di nota l’eliminazione di un vocabolo come «aves» (già assunto, pur nella sua accezione dialettale lombarda, con un sapore di scientificità ricercata) in favore di un’espressione di uguale connotazione tecnica, di registro elevato, come «falda acquifera» (rr. 46-47: «Da quella falda acquifera, molto probabilmente, la scelta del luogo»).
Altrove la preferenza accordata a una forma arcaicizzante (celere → ratta) non esclude il gioco allitterante delle dentali e delle liquide (rr. 7-8: «E più ratta ancora di quel gitto è la sua parlantina toscana sopra le donne torve, accigliate»); non diversamente da come la resa onomatopeica è perseguita nella sostituzione di «dolci colombi» (r. 12) con «beccuzzanti o ruculanti colombi».
Nella variante «chi si china per raccogliere un utensile caduto» (r. 45) → «chi si sporge di sella, nel torneo, e si sforza di raccorre un fiore dal suolo», si coglie lo spostamento da un’immagine disadorna, nella rude fisicità del gesto, a una ben diversa rappresentazione, dall’eleganza un po’ manierata, impreziosita dal letterario «raccorre».
Rientra invece nel criterio dell’attenuazione dei toni dissonanti, la rinuncia all’accostamento di contrastanti registri espressivi, come la riduzione del passaggio, di per sé felicemente compiuto nelle sue componenti autoironiche, «è combinato di deliziosi libroni, di tarme. Gli uni e le altre mi piacciono immensamente: quando il bacherozzo si mangia Aristotele, tutti mi prenderanno per un filòsofo» (rr. 57-59) in favore di «Ai vecchi libri, alle tarme», che è variante livellata al tono interiorizzato del periodo precedente.
Esigenza di maggiore distacco dall’esperienza autobiografica suggerisce l’attenuazione dell’enfatica perifrasi, dal sapore di cerimoniale alquanto desueto: «Il forte soldato mi fece anzi l’onore di accompagnarmi» (r. 65), ridotta all’essenziale «M’accompagnò», in concomitanza con la soppressione del riferimento onomastico preciso (rr. 64: «Umberto Dedini»).
Un sottile lavoro di aggiunta e sottrazione è condotto intorno alle note già esistenti, sette delle quali vengono soppresse. L’operazione appare dettata dal desiderio di attenuarne la funzione di contrappunto al testo, prima espressamente perseguita.
Per limitarci a un solo esempio, nell’eliminazione della nota a «succedànei» (il vocabolo è qui impiegato nel significato di successori, r. 53) si legge l’intento di far cadere sul tecnicismo tutta la portata della sua estensione impropria: «Succedanei è termine delle tecnologie, usato qui arbitrariamente, a dileggio» (SGF I 162).
D’altro canto, con inversa operazione, è affidata alle ultime quattro note la dilatazione del tema Celestino V già così ripetutamente implicato nelle diverse rielaborazioni. Il dispiegarsi comico-grottesco della rappresentazione investe soprattutto le due finali. In particolare la chiosa al dantesco «Se’ tu già costì ritto, Bonifazio?» si arricchisce della parafrasi caricaturale del corrispondente passo di Inf. XIX, 25-53:
ove per «costì» è da intendere, nel fondo della terza bolgia, l’orlo del pozzetto affocato nel quale papa Niccolò III è fitto a capo giù: e sventola di fuor dal pozzo le piante dei piedi, fiammeggianti e sfavillanti come carta unta che bruci. Niccolò III «piangeva con la zanca», cioè agitando le gambe nel brucio, in attesa che Bonifazio VIII discendesse ad Inferno e prendesse il suo posto: 13 ottobre 1303. Il predecessore (sul trono papale e nella simonia papale) sprofonderà più addentro e più giù nel meato o nella crepa della roccia, lasciando a sgambettare il successore. Piedi nel luogo della testa. (SGF I 322 n. 1)
Ma sarà specialmente la raffigurazione della destituzione di Celestino V a tingersi di toni grotteschi, in una scena di macabra teatralità, complicata da un gustoso amalgama di elementi linguistici arcaicizzanti e moduli del registro parlato:
A un povero vecchio di 85 anni, cupido solo di rosicchiare del radicchio o biasciar cacio e polenda nel montanino romitaggio! venerata la Madonna, dimessa, nonché la tiara, ma l’intera congrega camerlenga e il ceremoniale papàtico! impaurato da morire al sentir le grinfie del diavolo che lo tiran giù per i piedi! a un prigioniero di tutta quella politica e di tutto quel risucchio, angioino e gaetano, fargli mugghiare un trombone da un buco del soffitto, la notte, nel buio: «Celestì-noo! Celestì-noo! repéntete del tuo peccà-too! làa-scia la sòodia!» C’era da restarci secco.
Finché la caratterizzazione un poco macchiettistica, ma anche dolente, del personaggio verrà travolta in un crescendo di cupa comicità:
Quella testa di papa di montagna principiò vagellare, nulla più la fermò: aveva l’aria di dire «sì sì sì, la mollo» poi «no non no, non la voglio».
La parte conclusiva riconduce a un tono più distaccato dal tema, che si scioglie, nelle ultime battute, in una parafrasi di moduli danteschi; e il pungente giudizio finale, tra l’accigliato e l’arguto, nella sua formulazione scandita suona a sentenza che sembra andare ben oltre la contestualità dell’episodio:
Liceo cantonale, BellinzonaL’Alighieri ha travolto il Morrone fra gli «ignavi» (inerti nel scegliere) che danna a correre a cerchio nell’immenso vestibolo dello Inferno dietro una insegna che non posa, dacché al mondo non hanno seguitato parte o bandiera. A cose fatte, a eventi consunti, a grane faraonizzate nell’eternità, il poeta (e profeta a «à rebours») esigeva troppo da’ suoi morti, da’ suoi papi. (SGF I 323 n. 2, come i due brani precedenti).
Note
1. La pubblicazione esce in esigua tiratura a Firenze, presso la tipografia dei Fratelli Parenti, editori della rivista Solaria. È ora riproposta in SGF I 11-199.
2. L’articolo è qui riprodotto in appendice. Sono state conservate le particolarità dell’impaginazione giornalistica (occhiello, titoli interni, ecc.). Ad esso si rinvia per i riscontri puntuali sul testo.
3. Il materiale a cui si fa riferimento appartiene al fondo di Gian Carlo Roscioni che ne ha consentito la consultazione, tramite Dante Isella, in occasione di un ormai lontano lavoro universitario. Ringraziamo entrambi per l’opportunità offerta.
4. Si tratta di un gruppo di 16 fogli sciolti, vergati solo sul recto e numerati consecutivamente da 1 a 13; tre fogli autonomi, recanti porzioni di testo rielaborato, hanno numerazione 7, 13, 19. Sicuramente prima stesura, il manoscritto attesta ripetuti interventi correttori e ampi rifacimenti. L’esame delle varianti avvicina per gradi alla soluzione definitiva della pubblicazione sul quotidiano, ma fa supporre una fase successiva di rielaborazione consegnata a un altro testo mancante.
5. Si rendono noti, una volta per tutte, i criteri adottati nella riproduzione del testo: l’asterisco identifica la porzione implicata in variante, gli uncini rovesciati la cassatura in rigo, la freccia l’evoluzione della lezione. Si è resa necessaria, in un caso, la distinzione delle fasi correttorie con lettere dell’alfabeto.
6. L’eco del famoso incipit della canzone CXXVI di Petrarca tornerà, ancor meglio definita, in un passaggio successivo, per essere poi subito attenuata (r. 94: «Essi mi dicono chiare ›e dolci‹ acque dai monti»). Va rilevato che la coppia chiaro/dolce ricorreva già nella prima stesura del passo che stiamo esaminando (r. 70): «Erano ›dolci‹ chiari e ›dolci‹ sereni i mattini → Erano chiari i mattini. Scendono le vecchie mura […]». Nella redazione finale la lezione «Erano chiari i mattini», verrà soppressa: il sintagma «chiaro mattino» figurava già in apertura di un precedente paragrafo (r. 54): «Nel chiaro mattino si insinua, per suoi segni nobili, il tempo». Resosi disponibile, l’aggettivo «dolce» ricomparirà nell’ultima fase correttoria (r. 72): «Tutte le dolci imagini dell’autunno paiono tremare [...]».
7. La nota gaddiana aggiunta alla prosa pubblicata nelle Meraviglie (SGF I 163) attribuisce erroneamente a Orazio il verso catulliano «ebriosa acino ebriosior» (ma la lezione più attendibile sarebbe «ebriosa acino ebriosioris»: Carme XXVII, 4); l’immagine ovidiana è nelle Metamorfosi III, 50: «Fecerat exiguas iam sol altissimus umbras».
8. Tra le molte occorrenze virgiliane la fonte più prossima sembra essere quella di Georgiche II, 294-95: «immota manet multosque nepotes, | multa virum volvens durando saecula vincit», per l’immediato valore metaforico connesso all’immagine della quercia che solida sopravvive nei secoli alle generazioni umane. Ma si veda anche Eneide IV, 449: «Mens immota manet; lacrimae volvuntur inanes»; VII, 314: «Atque immota manet fatis Lavinia coniunx». Una variazione del sintagma ricorre ancora in Eneide I, 257-58: «manent inmota tuorum | fata tibi»; III, 447: «Illa manent immota locis neque ab ordine cedunt».
9. Verso la Certosa (Milano: Ricciardi, 1961) raccoglie, rielaborandole, prose tratte dagli Anni e dalle Meraviglie d’Italia, oltre alcuni inediti in volume. È ristampata ora in SGF I 273-397.
10. Sui criteri generali che hanno ispirato il lavoro correttorio gaddiano allestito per Verso la Certosa, si veda la mia Nota al testo in SGF I, in particolare alle pp. 1285-289. All’esame delle caratteristiche strutturali del volume, in rapporto ai precedenti (Le meraviglie d’Italia, Gli anni), era già stato dedicato un contributo di Giulio Ungarelli (Ungarelli 1980).
Published by The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS)
ISSN 1476-9859
ISBN 1-904371-16-7
© 2007-2025 by Liliana Orlando & EJGS Manzotti Archive. First archived in EJGS (EJGS 5/2007), Supplement no. 5. Previously published in E. Manzotti (ed.), Le ragioni del dolore. Carlo Emilio Gadda 1893-1993 (Lugano: Edizioni Cenobio, 1993), 73-90.
Artwork © 2007-2025 by G. & F. Pedriali. Framed image: A Cabinet of Curiosities (Wunderkammern) – detail from an illustration in V. Levinus, Wondertooneel der natuur, tome II (1715), Strasbourg University.
The digitisation and editing of EJGS Supplement no. 5 were made possible thanks to the generous financial support of the School of Languages, Literatures and Cultures, University of Edinburgh.
All EJGS hyperlinks are the responsibility of the Chair of the Board of Editors.
EJGS is a member of CELJ, The Council of Editors of Learned Journals. EJGS may not be printed, forwarded, or otherwise distributed for any reasons other than personal use.
Dynamically-generated word count for this file is 6593 words, the equivalent of 19 pages in print.


