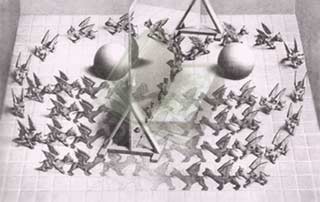 |
Gadda, la ciclicità, la «deformazione»
Niva Lorenzini
Il romanzo del XX secolo, nelle sue espressioni più intense, fa spesso ricorso alle strutture del ripetitivo e del ciclico per esprimere, attraverso un metodo, una maniera, uno stile che talvolta sembra approssimarsi al pensiero mitologico, non l’armonia o l’immanenza dell’originario, ma la sproporzione tra principi immutabili e flusso dell’empiricità. E dunque tra finito e infinito, eterno e temporaneo.
Capita così che la ripetizione dell’identico, o la serie delle fluttuazioni infinite, possano allo stesso modo schiacciare la temporalità (come avviene nell’Ulisse di Joyce o in Mann, particolarmente nella Montagna incantata o nel ciclo delle storie bibliche di Giuseppe) su un anonimo, dissacrato itinerario quotidiano: si riduce in tale modo la ciclicità mitica a una interiorizzata e diseroticizzata dimensione psichica, che coinvolge lo slittamento temporale tra presente e memoria, reminiscenza e sperimentazione, coscienza di superficie e profondità extrastorica dell’inconscio.
Tutto ciò può valere anche per Gadda. Ma occorre particolare cautela nel selezionare tra un materiale sistematicamente contraddittorio, cui concorrono ingredienti di segno diverso predisposti da un autore che sino dagli esordi narrativi avverte come traumatica una scelta tra le tante direzioni possibili, nel reticolo di relazioni infinite che avvolge la realtà: «Mi rincresce, – si legge nelle prime pagine del Racconto italiano di ignoto del novecento – mi è sempre rincresciuto rinunciare a qualcosa che mi fosse possibile. È questo il mio male. Bisognerà o fondere, (difficilissimo) o eleggere» (SVP 396).
Siamo avvertiti: nessun luogo della scrittura gaddiana può essere investigato secondo una prospettiva univoca. E tuttavia, pur nel rispetto della plurivocità e della discontinuità di questa prosa, è opportuno individuare, tra i molteplici livelli, una tipologia del ripetitivo che interessa una parte consistente della sua produzione, a cominciare da una vera e propria ossessione variantistica che modifica e disloca di continuo singoli passi o interi capitoli tra un’opera e l’altra, mettendo in contatto – un esempio tra i tanti – il Cahier con l’Adalgisa, o l’Adalgisa e le Novelle dal ducato in fiamme con la Cognizione del dolore. Proprio nella Cognizione la tendenza al ripetitivo e alla riscrittura approda a esiti intensissimi, non tanto e non solo per il recupero di luoghi testuali variamente disseminati, quanto per una diversa accezione che si discosta dal tradizionale ricorso alle varianti. (1)
è soprattutto Gonzalo a venirne interessato: l’antieroe nevrotico dalle ascendenze solidamente ancorate al cammino delle generazioni («di sangue barbaro, germanico e unno, oltreché longobardo» per parte materna). Il suo bisogno di astrarsi per individuare una logica nella catena degli eventi, la sua tesa ricerca di conoscenza (Cognizione) capace di trasferire l’esperienza e l’azione su un piano concettuale, finiscono per sconfinare ogni volta, veicolati magari dai modi del monologo interiore in bilico tra razionalità, fughe oniriche, affioramenti del rimosso, nella dimensione di un ordine universale e archetipico immediatamente negato:
Germanico era in certe manìe d’ordine e di silenzio, e nell’odio della carta unta, dei gusci d’ovo, e dell’indugiare sulla porta coi convenevoli. In certo rovello interno a voler risalire il deflusso delle signifìcazioni e delle cause, in certo disdegno della superficie-vernice, in certa lentezza e opacità del giudizio, che in lui appariva essere inalazione prima che sternuto, e torbida e tarda sintesi, e non mai lampo-raggio color oro-pappagallo. (2)
E non può essere diversamente per chi concepisce l’individuo come «groppo, o nodo, o groviglio, di rapporti fisici e metafisici» (Come lavoro, SGF I 428), e la realtà come flusso di possibilità infinite, la cui complessità «troppo poveramente si schematizza» (Meditazione, SVP 842).
La realtà è un processo autodeformatore di infinite relazioni reali in cui ad ogni attimo si differenzia un essere o io o pausa da un tendere o conglomerarsi o deformarsi. E permanere e divenire sono in ogni cosa e in ogni istante sebbene certe cose ci sembrino un assoluto permanere o maceria […] e altre un assoluto divenire o atto. (SVP 789)
La storia stessa esprime per Gadda un «continuo dibattito tra l’acquisito e l’acquisendo», tra il «permanere» e l’«euresi». Una storia, va ricordato, mai ristretta ai casi degli uomini, secondo una concezione asfitticamente antropocentrica, ma al contrario attratta da un modello organicistico del mondo, un sistema globale articolato geneticamente sul plasma, il seme, la matrice. Di fronte alla riduzione all’individualità, operata da chi si illude circa la sostanza semplice della persona-faro («il pensiero […] ha girato e rigirato intorno ad esso complesso di relazioni (da lui supposto individualità), come il pazzo farfallone di primavera intorno al faro voltaico, escogitando ogni sorta di miti. E non mai s’è dimandato, se per avventura il faro fosse non persona o individuo ma grumo o nucleo o groviglio di rapporti», SVP 661), si opta per un evoluzionismo in perpetua oscillazione tra determinismo genealogico e mutamento, logica ripetitiva e deformazione:
… forse realmente la storia del mondo universo è il simbolo d’una pulsazione logica, per cui tutto si integra e si manifesta in una infinità di nuovi (a noi paiono nuovi) rapporti che miticamente chiamiamo effetti distinguendoli da quelli appariti a noi come precedenti e che miticamente chiamiamo cause. (SVP 661)
Nel racconto genealogico ciò che si nega, di fatto, è l’Origine, Ursprung, forma immobile e anteriore, identità prima, luogo della verità che precede il tempo. L’appassionato cultore di storia e di genealogia (3) non si lascia suggestionare da derive metafisiche: per lui, in sintonia singolare, in questo caso, col pensiero di un genealogista d’eccezione come Nietzsche, dietro le cose stanno altre, diverse cose. Non l’identità dà infatti l’avvio alla storia, ma la diversità: «Ce qu’on trouve, au commencement historique des choses – chiosa un interprete appassionato come Foucault – ce n’est pas l’identité encore preservée de leur origine – c’est la discorde des autres choses, c’est le disparate»; e ancora: «la verité des choses se noue à une vérité du discours qui l’obscourcit aussitôt et la perd». (4)
Non esiste purezza originaria, non c’è, per Gadda, inizio assoluto, sottratto al divenire. La storia è un racconto di discontinuità, di interferenze che attraversano la parvenza del fenomenico, per un neopositivismo inquieto come il suo, che vive come traumatico quel motivo della continuità, (5) della traiettoria ininterrotta di stampo evoluzionistico (Spencer) e vitalistico (Bergson), mentre si spinge verso le zone in ombra dell’inconscio. E qui si entra in un territorio talmente intricato che non è davvero possibile darne un resoconto rappresentativo.
Si tratterà semmai di selezionare un itinerario percorribile attraverso lo sviluppo testuale, sul quale tentare una fra le possibili esemplificazioni. Il tessuto linguistico e strutturale gaddiano è infatti straordinariamente aperto alle interferenze e conflittualità, nel rispetto della complessità dei fenomeni e delle relazioni che li interessano.
Lo afferma senza possibilità di equivoco lo stesso scrittore in più luoghi, ma raramente con la perentorietà con cui, nei Viaggi la morte, esprime una Opinione sul neorealismo davvero istruttiva: «… io aborro dal personaggio-simbolo, come aborro dal personaggio-araldo […]. La virtù pura mi irrita […] sento tremendamente le ragioni del suo contrario» (SGF I 630). Ed è come dire, una volta di più, che per Gadda i fatti non valgono per sé, ma in relazione (per questo aborre «il tono asseverativo che non ammette replica», mentre predilige le «meravigliose ambiguità di ogni umana cognizione»). E del resto, commenta Gadda poco oltre nella stessa pagina, nessun conoscitore di Kant «può più credere in una realtà obbiettivata, isolata, sospesa nel vuoto; ma della realtà, o piuttosto del fenomeno, ha il senso come di una parvenza caleidoscopica dietro cui si nasconda un “quid” più vero, più sottilmente operante». Fuori di questa prospettiva – e qui il tono si fa sentenziale – il «fatto in sé, l’oggetto in sé, non è che il morto corpo della realtà, il residuo fecale della storia».
Trasferita all’universo del romanzo, quest’aspettazione di senso sempre rinviata, questa percezione della totalità mancante portano come conseguenze immediate la decostruzione della fabula, la commistione di registri e lessico, la rinuncia alla «verità» dello stile, la perdita di centro e di unità architettonica in favore dell’episodico, del frantumato, dell’asimmetrico, del polifonico. E del resto, senza conoscere Bachtin, già nel Racconto italiano di ignoto del novecento, intorno al 1924, Gadda, avviandosi alla scrittura narrativa, si poneva il problema non solo della impossibilità di rappresentare globalmente il reale, ma di come descrivere l’«istinto delle combinazioni» passando – sono parole sue – «dal semplice al complesso, dall’uno al molteplice» («e io – sottolinea in parentesi – ci dovrò passare essendo il mio un romanzo della pluralità», SVP 462).
La verità del testo si articolerà dunque, prevalentemente, sulla dialettica frammento-sistema. Il suo percorso non potrà essere lineare né seguire la prospettiva del processo, ma si limiterà a riprodurre, della realtà, l’aspetto cumulativo attraverso i modi della ripetizione e della circolarità: non perverrà dunque a una conclusione, così come l’euresi non si assesterà in un referto ultimo, finalmente sottratto alla catena ripetitiva dei nessi. Non può non stupire l’ampiezza con cui Gadda fa ricorso a modi ripetitivi, tropi e similitudini, temi, immagini, stilemi trasferiti da un’opera all’altra o ritornanti nello stesso testo sino all’ossessione, quasi che si celebri sulla pagina il bisogno di compensare, nella scrittura, il rischio della perdita (anche se prevale piuttosto in Gadda, nelle pur minime variazioni introdotte da un luogo all’altro, il bisogno di sperimentare tutte le modalità delle possibili combinazioni).
Si ha comunque sovente l’impressione che proprio i processi iterativi, producendo spostamenti minimi nel sistema, definiscano e individuino, rapportandola alla ripetitività, la struttura consapevole del narrare. Basterà accennare alla ripetitività insistita di stilemi con cui, nella Cognizione del dolore, si allude al personaggio Gonzalo che sta per essere introdotto nel testo dopo accorgimenti che ne ritardano l’entrata in scena. (6) Si tratta di stilemi riproposti con varianti davvero minime («gira per casa che pare un matto […]. Quando lui comincia a girar per casa come un’apparizione […] quando comincia a girar per casa con le mani nelle tasche […]. E quando lui comincia a girare», RR I 610-11).
Le citazioni potrebbero moltiplicarsi, estendendosi dall’attivazione di verbi e sostantivi caratterizzanti (apparire, apparizione connnotano sovente l’entrata in scena di Gonzalo: «nelle sue rapide apparizioni», « Le rade volte che apparisse […] quel solo che ancora le appariva, talvolta, all’incontro», RR I 599, 690), all’insistenza su particolari visivi e acustici che immobilizzano il tempo del romanzo in una circolarità ritornante al presente. Roscioni si è soffermato su questi tic dell’immaginazione, elencando una tipologia che comprende «tipi», «situazioni», «oggetti e animali simboli» o «movimenti psicologici e stilistici» riproposti insistentemente di opera in opera come «métaphores obsédantes«, richiami impliciti. (7)
Caos e cosmo convivono in questa circolarità, come convivono disordine e pulsione vitale, tenebra e luce: il continuo si misura così col discontinuo, il finito con l’incompiuto. Ma dal frammento non si tornerà all’intero, il solo esito che non può più in alcun modo venire postulato.
Il percorso iterativo consente semmai, proprio per il rallentarsi dell’azione che in esso si compie, di porre a confronto con l’immobilità le mutazioni minime, le varianti che incessantemente intervengono, nella struttura costituita dal frammento, a modifìcare la stasi: così, attraverso il riprodursi di coincidenze metonimiche, il tempo universale della storia sfiora, talora nelle forme di una anomala coazione a ripetere («Vagava, sola, nella casa […]. Vagava nella casa […]. Vagava, nella casa», RR I 673-74), il mondo senza storia del mito, costringendolo però ogni volta a impercettibili trasformazioni che sanzionano la polivalenza e l’inafferrabilità dell’esperienza.
Ma poi, in apparente contrasto con questo piétiner sur place, l’attivarsi nella Cognizione del dolore di strutture ripetitive funziona anche come segnale testuale che va oltre la fissazione del dettaglio. Il rallentarsi delle sequenze può infatti aprire a slittamenti spazio-temporali verso un orizzonte illimitato, fluido, privo di inizio e fine: si pensi solo al valore degli «al di là«, dell’«oltre», del «muovere verso le lontananze», a quegli squarci che si aprono in un paesaggio virtuale e indefinito, in cui si resta sospesi tra uniforme chiarore e cecità abissale (le tante vedute che spaziano «perdutamente fino alle lontane colline, e poi più lontano forse, nel sole…»).
In questi casi sono le cesure ritmiche che, scandendo l’intervallo, l’interstizio, sottolineano di fatto il conflitto del fenomenico, che scorre senza interruzione, col permanente, l’a-temporale. Si tratta di stacchi, variazioni tonali che sospendono l’azione invitando a un ascolto senza oggetto, che unifica spazio esterno e spazio intimo:
Per intervalli sospesi al di là di ogni clausola, due note venivano dai silenzî, quasi dallo spazio e dal tempo astratti, ritenute e profonde come la cognizione del dolore. (RR I 731-32)
Ad essi si accostano i Leit-motive ossessivamente riproposti: «Le cicale, risveglie, screziavano di fragore le inezie verdi sotto la dovizie di luce» – «E le cicale, popolo dell’immenso di fuori, padrone della luce» – «Le campane tacevano: le cicale gremivano l’immensità, la luce» (RR I 612, 622, 628). Ha certo ragione Roscioni ad avvertire un’ambiguità nell’atteggiamento di Gadda nei riguardi della totalità, con la simbologia astrale, la dimensione cosmica, geologica, astronomica che la corredano. E fa bene a mettere in guardia da letture parziali, troppo sbilanciate verso richiami assolutizzanti: gli al di là di Gadda indicano certo la «totalità delle cause postulatrici», il caos delle determinazioni infinite, il disordine dialettico (Roscioni 1975: 66). Ma non si nega con ciò l’incidenza del contrappunto tonale che occupa di sé, a partire dall’annuncio della visita del dottore a Gonzalo, uno spazio davvero rilevante del tessuto narrativo. Chi preme sul tasto del registro lirico, parlando di stile da poème en prose, tra suggestioni da clima ermetico che puntano a un simbolismo astratto, non rende piena giustizia al testo: anche perché Gadda è molto cauto e selettivo nei riguardi del simbolo qualora lo si intenda come vaghezza e astrazione. Quegli stacchi sono piuttosto «orchestrazioni metaforiche» che creano – già secondo un’intuizione di Citati (Citati 1963: 12-41) – un’architettura, rispondendo a una ragione strutturale incline semmai, verrebbe da aggiungere, alle sollecitazioni del metafisico barocco: si tratta poi, preso atto del rilievo, di comprenderne le ragioni profonde, senza arrestarsi al livello della registrazione.
Muoviamo allora da una constatazione semplice: esclusa ogni istanza metafisica, questo Spazio e questo Tempo vuoti, assoluti, segnalati da indici lessicali, ritmici, tematici che concorrono a determinare un contrasto stilistico all’interno del contesto narrativo – si è parlato al proposito di un Mitschwingen, risonanza con effetti di vibrazione e oscillazione (Gersbach 1969) – sono posti a precedere, in genere, non il recupero di un territorio simbolico ormai svuotato di senso e funzionalità, ma piuttosto il processo di anamnesi del protagonista. Attraverso quel ricorrere ossessivo di combinazioni, associazioni tematiche fisse o appena variate, ogni volta si apre nel testo lo spazio psichico, la voragine dell’interiorità («… sognare è fiume profondo, che precipita a una lontana sorgiva, ripullula nel mattino di verità», RR I 632), che consente alla stessa vita organica di ritornare alla sua base inorganica, al grembo della natura.
Dalla memoria testuale alla anamnesi: il mito può sorgere in questa sospensione del tempo, coincidendo con l’immersione nelle profondità extrastoriche dell’inconscio, o magari con l’«ombra nera, muta, altissima» di una madre irraggiungibile e solenne come la Veturia dei Latini, spettrale come il Re Lear shakespeariano:
Capegli effusi le vaporavano dalla fronte, come fiato d’orrore. Il volto, a stento, emergeva dalla fascia tenebrosa, le gote erano alveo alla impossibilità delle lacrime. Le dita incavatrici di vecchiezza parevano stirar giù, giù, nel plasma del buio, le fattezze di chi approda alla solitudine. (RR I 677)
è quella madre che Gonzalo vede scaturire dal proprio interno («Ed era sorta in me, da me!», RR I 633): ma siamo qui nel terreno freudiano della regressione o degli affioramenti del rimosso, della pulsione di morte, ove il mito fa i conti non solo con il proto-tempo primordiale delle origini e con gli archetipi, le visioni, i sogni che gli si collegano, ma poi anche con il tempo vissuto dell’esperienza, dell’iniziazione al dolore. L’abisso della morte individuale si confronta in tale modo con la permanenza del cosmo, e la continuità frana (il verbo è segnatamente gaddiano) sul discontinuo, coinvolgendo nel processo l’io bergsoniano insieme con l’ansia narcisistica della ricerca di sé («… l’io, l’io!… Il più lurido di tutti i pronomi!…», con la sfuriata verbale che segue, RR I 635).
Pathos della distanza e parodia, costanza iconica e senso del relativo, attrazione verso la struttura di una totalità intesa in senso tutt’altro che metafisico come organismo, sistema dei sistemi e sua immediata negazione nel continuo dissolversi e divenire delle relazioni, diventano per Gadda altrettante tecniche per accostarsi a una realtà che non cessa di scriversi e autodeformarsi.
è il momento di un’ulteriore verifica.
Uscirono sul terrazzo da cui si guardava l’estate, a mezzogiorno e a ponente. Le campane tacevano: le cicale gremivano l’immensità, la luce. (RR I 628)
Al termine di un lentissimo percorso discenditivo, misurato secondo un millimetrico, quasi rituale procedere che pare forzare una contrapposta valenza di fissità, o ritardarne lo scioglimento («I due uscivano dalla camera. […] Presero a discendere le scale, adagio, il dottore avanti. Sostava ad ogni gradino […]. Giunti al ripiano delle scale, che fungeva da anticamera, presero a stropicciare le scarpe sull’ammattonato, tutti e due, come volessero saggiare il mattone», RR I 625-28), Gonzalo e il dottore escono dalla casa. Il fuori è costituito da un terrazzo situato «a livello del piccolo giardino dietro la casa», con il quale comunica direttamente «dopo il solo ostacolo d’un gradino di serizzo».
Resta, di quel terrazzo della villa di Brianza venduta da Gadda dopo la morte della madre, qualche foto, che lascia intravedere la porta-finestra per cui si accede all’interno, e la balaustra coi pilastri, che non protegge e non circoscrive perché è interrotta prima di congiungersi col muro della casa. Certo le fotografie, riprodotte ora dalla Terzoli in un prezioso volumetto sulla Casa della «Cognizione», sono per uno scrittore come Gadda «frammenti memoriali privilegiati: mediazione mnemonica per oggetti e persone perdute e insieme supporto materiale alla descrizione». E certo il ritornare ossessivo dell’immagine della terrazza nella Cognizione vale come sintomo di una «pericolosa e vana transizione tra l’esterno e l’interno, tra il mondo degli “altri” e l’intimità della famiglia» (Terzoli 1993a: 7).
Ma si ha l’impressione che quel ritornare insistente sull’immagine del terrazzo celi qualcos’altro, obblighi ad altre considerazioni, sia a livello di struttura narrativa che a livello di simbologia del profondo.
Il contrapporsi del fuori al dentro è la decodifica immediata, non v’ha dubbio: il motivo è davvero ossessivo per il narratore, al punto che se ne potrebbero seguire gli sviluppi testuali attraverso precisi segnali indicatori. Tra questi la frequenza dei riferimenti al muro di cinta e ai muri della casa, al cancello di ferro che funge «da normale introduttore nel silenzio e nella luce della villa», alle «barre in legno», ai vetri, alle porte finestre, alle finestre «aperte» alla luce della campagna, cui si accompagnano le locuzioni avverbiali – «di fuori», «fuori di finestra», «al di là», o all’opposto «dentro», «dietro»… Ed è proprio il contrapporsi del fuori al dentro a sottolineare, più che la reclusione, l’esclusione dell’io dal possesso del mondo e di sé, una separatezza totale, incolmabile.
Ma il terrazzo, cui si accede attraverso un percorso iniziatico caratterizzato dal rallentarsi e quasi interrompersi del ritmo testuale, assume subito un significato più ampio: quella superficie esposta, perimetrata, descritta molte pagine più avanti dall’ingegnere scrittore con millimetrica precisione («Il terrazzo, di piastrelle di cemento, consunte e perciò porose, era asciutto e caldo…», RR I 731) non è solo – lo si avverte – appendice contrapposta al dentro. È un luogo sospeso, epifanico, ove si attiva una dimensione virtuale che mentre proietta nello spazio e nel tempo senza confìni consente insieme il concentrarsi in immagine dello psichismo.
Dal terrazzo la veduta spaziava perdutamente fino alle lontane colline, e poi più lontano forse, nel sole. Si spegneva ai tardi orizzonti: e agli ultimi fumi delle fabbriche, appena distinguibili nella foschia: posava alle ville e ai parchi, cespi verdissimi, antichi, tutt’attorno la mite e famigliare accomàndita di quei piccoli laghi. (RR I 628)
La liricità interviene improvvisa a spezzare il ritmo narrativo: ma non si tratta di cedimento al gusto elegiaco del frammento contemplativo o lirico, appunto. Pare piuttosto che lo «spostamento metonimico» dello sguardo narrativo consenta di avvertire, come qualcuno ha rilevato, insieme con la vastità del «sublime naturale», la percezione «di un mondo incorrotto, pieno e positivo» (Patrizi 1975b: 173).
L’interpretazione si conferma se si lascia proseguire la citazione gaddiana:
Eran livelli celesti, opachi, future torbiere, tra l’insorgere dei mille piacevoli incidenti d’una orografia serena, che aveva conosciuto il cammino delle Grazie. Terra vestita d’agosto, v’erano sparsi i nomi, i paesi. Ed era terra di gente e di popolo, vestita di lavoro. (RR I 629)
Di fronte alla suggestione di un simbolico scorporante (la veduta che spazia «perdutamente»), carico di tensione e valenze affettive, si accampa il richiamo delle cose, la rassicurante certezza della loro oggettiva diversità. Il momento contemplativo muove da una accezione impersonale («la veduta spaziava») sottratta all’identità e alla situazione: lo comprovano l’avverbio «perdutamente», che implica una temporalità continuata, un tempo come indeterminata astrazione che avvolge uno spazio potenzialmente illimitato e atopico, e l’aggettivazione indefinita, non caratterizzante («lontane colline», «tardi orizzonti»). È, questo infinito gaddiano, una spazialità ricondotta ai propri fondamenti, non misurabile in quanto quiddità eccedente ogni strumentazione. Come tale comporta una notazione di angoscia. In chiave heideggeriana si potrebbe pensare sia all’angoscia dell’essere richiamati a sé (lo spazio vuoto non come mancanza, secondo l’Heidegger di Die Kunst und der Raum, ma come bisogno di «portare allo scoperto»), sia alla paura del confronto con l’originario: «dietro lo spazio» – constata Heidegger – «non vi è più nulla cui esso possa essere ricondotto. Di fronte ad esso non è possibile distrarre la propria attenzione verso altra cosa. Ciò-che-è-proprio dello spazio deve mostrarsi da se stesso. Ma ciò-che-è-proprio dello spazio si può ancora dire?» (8)
Di fronte a una fuga verso l’Ur-zeit sta comunque il tempo empirico: così come, in altro luogo molto più avanzato del testo, visualizzato sempre dall’osservatorio privilegiato della terrazza ma in quel caso dallo sguardo della madre (da qui la trasformazione del genere dal maschile abituale – «il terrazzo» – al femminile, quasi ad accogliere in sé anche la suggestione del semema «terra»), si contrapporrà alla «visione cosmica», inquietante nel suo «risolversi» e « disparire», la «geografia umana», positiva e rassicurante. E si potrà parlare anche in quel caso – è del Manzotti il rilievo (Manzotti 1987b: 135 e sgg.) – di non scelta di Gadda, di una «giustapposizione», piuttosto, «delle visioni umana e cosmica» secondo un «coesistere ed interagire di soluzioni divergenti» su cui pare influire non poco, di nuovo, certa suggestione leopardiana. Il percorso redazionale, con le varianti che lo costellano, ne è piena conferma:
Dalla terrazza, nelle sere d’estate, ella scorgeva all’orizzonte lontano i fumi delle ville, che immaginava popolate, ognuna, della reggiora, col marito alla stalla, e dei figli […]. Bagliori lontanissimi, canti, le arrivavano dal di fuori della casa… (RR I 679)
E ancora:
Di nuovo le sembrò, dal terrazzo, di scorgere la curva del mondo: la spera dei lumi, a risolversi; tra brume color pervinca disparivano incontro al sopore della notte. Sul mondo portatore di frumenti, e d’un canto, le quiete luminarie di mezza estate. Le sembrò di assistervi ancora, dalla terrazza di sua vita, oh! ancora, per un attimo, di far parte della calma sera. Una levità dolce. (RR I 680-81)
Il proto-tempo, il tempo mitico delle origini così come quello cosmico, non ha, lo sappiamo, in Gadda valore di rinvio astrattivo, semmai postula un rapporto strettissimo con la rete delle connessioni che avvolge il reale. E non c’è forse migliore spiegazione per queste aperture verso l’«al di là» che la postazione del terrazzo attiva, ma di cui non risolve la dicotomia, di quella fornita dallo stesso Gadda in una recensione del ’32 alla Poesia di Montale (SGF I 765). Vi si parla, in questo caso senza l’urgere della contrapposizione tra aspetto cosmico e aspetto umano, ma con una diversa percezione della separatezza e della solitudine, di un paesaggio che esprime non vaghezza ma «necessità» lirica, e di una «stupefatta anestesia» che sospende il dolore. Quell’anestesia va indagata. A cosa pensa il recensore quando scrive:
Oh! di «commozione» è il caso di parlare. Dacché lo spasimo tragico non è indotto in noi dall’urlo solo, sì anche se affiorino alla ribalta i nomi e le parvenze del tedio, della indifferenza, del muto e secco dolore, o d’una sopravvivenza spettrale, di là dal dolore. (SGF I 766)
Il nucleo narrativo della Cognizione è già tutto espresso, nella sua più intensa sostanza: ed è il paesaggio, la vastità spinoziana del paesaggio ligure, (9) con la sua fissità tragica, a consentire l’anamnesi, una volta che il soggetto contemplante si ponga in posizione, per così dire, favorevole al processo ermeneutico interiorizzato. Si attesti, cioè, su una sorta di ferma, fisica immobilità, aprendosi insieme all’introspezione e all’affondo retrospettivo:
… l’anima, ad un tempo, prende e perde, pensa e rievoca. Talora si direbbe annullata in lui la distinzione fra vita attuale e reminiscenza. La parola «memoria» ritorna insistente come nessuna altra nella sua lirica: il passato si dissolve talora in un tempo che è presente grammaticale ma che è un indistinto, un eterno, un non-tempo teoretico. (SGF I 766)
E con l’anamnesi si richiama la conoscenza, resa possibile dalle pause, le cesure, che implicano «silenzio» e «distacco» e favoriscono i «sottofondi logici» in cui la conoscenza, per l’appunto, «si organizza»:
Il poeta anela a un momento risolvente che cancelli o almeno interrompa la consecuzione dei termini finiti, che dalla ineluttabile concatenazione delle cause esali ed esorbiti verso la novità libera dell’inventato, o verso un dono improvviso dell’«al di fuori». (SGF I 767)
Ecco la spiegazione profonda di quelle aperture liriche, anzi di tutto il lirismo implicito nella Cognizione, che muove sempre, o sempre si riconduce, a «concretissimi dati»: «Dal terrazzo la veduta spaziava». Una cesura, una pausa: con straordinaria lucidità Gadda si commenta mentre commenta Montale. Si è nel ’32, ma è già della Cognizione del dolore che si parla qui, di Gonzalo, il dissociato noetico per cui il guardare senza oggetto né direzione attiva un processo di anamnesi che è insieme percorso conoscitivo lungo il continuum spazio-temporale che congiunge passato e presente:
Tanto il dottore che il figlio sostarono, si fecero al parapetto, chiamati da quella significazione di vita […]. Insaccato nelle spalle, intento a guardare, il figlio aveva le due mani alla balaustra di legno, le braccia divaricare ed aperte, come stanche ali. Guardava dolorosamente. «… Mia madre è invecchiata…», disse. Poi con violenza: «… Sono anni… sono disperato…». Pronunciò queste ultime parole come in un sogno. (RR I 629)
Con la stessa intensità di Stephen Dedalus, la stessa sofferenza, lo sguardo di Gonzalo si interiorizza consentendo il riaffiorare del rimosso, secondo un percorso mentale davvero affine a quello esposto nelle prime pagine joyciane:
Stephen si alzò e si accostò al parapetto […] con un gomito sul granito scabro, appoggiò la fronte a una mano […]. Una sofferenza […] gli rodeva il cuore. Silenziosamente, in un sogno [la madre] era venuta a lui dopo la morte, il corpo consunto nello sciolto sudario scuro… (10)
Dalla torre in riva al mare lo sguardo di Stephen si perde sulla baia di Dublino come un obiettivo aperto su una panoramica in dissolvenza. È l’immobilità, anche in questo caso, a prevalere, a consentire lo slittamento metonimico dal fuori al dentro e viceversa. Analizzando la Poétique de l’espace, Bachelard ha toccato indirettamente queste tematiche parlando di possibile rapporto tra immobilità e spazio psichico:
Dès que nous sommes immobiles, nous sommes ailleurs; nous rêvons dans un monde immense. L’immensité est le mouvement de l’homme immobile. (11)
Immobilità, vastità: per l’interprete francese della fenomenologia dell’immaginazione la vastità riunisce i contrari, è sintesi suprema che rende possibile congiungersi con l’intensità e l’intimità dell’essere. Sul terrazzo Gonzalo sperimenterebbe allora un sospendersi della fuga del tempo e un fissarsi e localizzarsi della memoria, resi possibili proprio da quello spazio virtuale in cui si condensa e conserva il passato:
On croit parfois se connaître dans le temps, alors qu’on ne connait qu’une suite de fixations dans des espaces de la stabilité de l’être, d’un être qui ne veut pas s’écouler, qui, dans le passé même quand il s’en va à la recherche du temps perdu, veut «suspendre» le vol du temps. Dans ses milles alvéoles, l’espace tient du temps comprimé. L’espace sert à ça. (Bachelard 1967: 27)
E non può essere questo un modo di «interrompere la consecuzione dei termini finiti», come interpretava il Gadda recensore di Montale, e di sottrarsi almeno temporaneamente alla «ineluttabile concatenazione delle cause»?
D’altro canto il terrazzo, cui si accede attraverso un percorso significativamente «tortuoso e stretto», luogo dell’inconscio (se l’inconscio, come sostiene Bachelard, «est logé») si contrappone, in una ideale topo-analisi a sviluppo verticale della casa della Cognizione che corrisponde poi alla topografia dell’essere intimo, (12) allo spazio di tenebra della cantina, la «cave», luogo della follia interrata, del dramma murato: è infatti il terrazzo che consente l’uscita da sé, dai vincoli di una costrizione sclerotizzante, proprio in quanto spazio vuoto che porta «allo scoperto» (ci si sovviene ancora di Bachelard, con la sua riflessione sulla poétique de la maison, luogo di archetipi che si esplicano nella dialettica aperto/chiuso: «La maison bien enracinée aime avoir une branche sensible au vent […]. La maison conquiert sa part de ciel. Elle a tout le ciel comme terrasse», Bachelard 1967: 62). Tra psicanalisi e fenomenologia, pare prendere corpo, nell’immagine del terrazzo, quel luogo psichico e virtuale in cui un Binswanger ben prossimo a Bachelard rinverrebbe agevolmente gli estremi per un’analisi spaziale dell’esistenza «in situazione»: proprio nelle polarità – davanti/dietro, vicino/lontano, largo/stretto, chiaro/scuro, alto/basso – essa troverebbe il modo di esprimere un convergere della spazialità verso la temporalità del vissuto. (13)
Il terrazzo si precisa sempre più come quel punto limitrofo aperto a tutti gli orizzonti e insieme circoscritto che consente al personaggio, colto in posizione immobile, di fuggire da se stesso nella rêverie, e cioè in una sorta di divagare estatico, o nella proiezione dell’inconscio: chi ha indagato un simile tipo di prospettiva e i suoi rapporti con la scrittura del narrare (è il caso del Rousset di Forme et signification e della sua affascinante lettura della «vista dalla finestra» in Madame Bovary) può parlare di punto nevralgico del racconto, nodo «in cui il corso narrativo si ferma», e il tempo si vuota e si ripete, tra ristagno e attesa. Si creano così «effetti notevoli di prospettiva lontana» che corrispondono a fasi «di massima soggettività ed intensità estrema». (14)
Comunque stiano le cose, è innegabile che il terrazzo della Cognizione partecipi ogni volta di un climax ascendente annunciato da una pausa, una cesura, un arpeggio ritmico e lessicale che segnala il mutamento di registro. Ed è anche indiscutibile che uno dei vertici del climax coincida proprio con l’affacciarsi di Gonzalo al parapetto. Non a caso quell’atto si replicherà più avanti con le stesse modalità descrittive, quasi con valenza citazionale, sospendendo il pendolare ritrarsi e riaffacciarsi del protagonista sul terrazzo («Si ritrasse […]. Si portò fino all’angolo della casa […]. Rivenne sul terrazzo» e poi di nuovo, nel tratto VIII della Parte Seconda: «si fece ad uscire sul terrazzo», RR I 629-30, 731).
Sarà, quello, un momento di massima intensità narrativa e introspettiva:
Il figlio si appoggiò, chinandosi, (data l’altezza della persona), al parapetto di legno. E guardava; forse, ascoltava. […]. Il figlio guardava, guardava, come per sempre. Di certo anche, ascoltava. Per intervalli sospesi al di là di ogni clàusola, due note venivano dai silenzî, quasi dallo spazio e dal tempo astratti, ritenute e profonde, come la cognizione del dolore… (RR I 731-32)
La pausa, la cesura si incidono sulla geometria della contingenza, sul «guazzabuglio del consueto, in cui viviamo e sentiamo» (L’ultimo libro di Gianna Manzini, SGF I 779): e il confronto con lo spazio dilatato consente di avvertire l’intensità della frizione tra la mobilità del fenomenico e il rovello che spinge a risalire alla causa, alla sintesi. È lo stesso Gadda a inviarci una spia interpretativa quando propone una diversa redazione del passo, giocata interamente sul rapporto ritmicamente ciclico tra il «ristare» e il «fluire» del tempo. Scrive:
Il flusso del tempo, sotto il migrare d’ogni ombra, ristava: una interruzione, una sospensione nel persistere e nel divenire delle cose e in quella pausa il cuculo suggeriva allo spazio senza ragioni, venutegli da una metafisica, le brevi note del dolore. (15)
Come interpretare quell’appello intermittente che proviene dalla dimensione di una eternità distante e perduta, quella tonalità acustica che altre volte si propone con lo «stridere» delle cicale, con una frequenza che non può passare inosservata? Essa consente il precipitare verso un percorso interiorizzato: è un richiamo che appartiene all’astratto e indefinito spazio dell’invisibile.
Pochi anni prima, recensendo in modo così penetrante Montale, Gadda aveva già toccato questi temi: si trattava in quel caso di confrontarsi con una poetica della fissità e della stasi che, da «concretissimi dati», precipita verso la dissoluzione dei confini del tempo. Le modalità dell’analisi, davvero per noi rivelatrici, interessavano già allora più la sfera della psicologia che quella della metafisica, perlomeno se ci si attiene alla considerazione che abbiamo richiamato poche pagine addietro: «si direbbe annullata – osservava il recensore riferendosi al paesaggio ligure centrale negli Ossi di seppia – la distinzione fra vita attuale e reminiscenza» (SGF I 766).
Se torniamo alla Cognizione e ci interroghiamo sul guardare di Gonzalo, la nostra domanda diventerà allora più mirata. Cosa guarda infatti Gonzalo se non il processo della memoria, di ciò che è stato rimosso? Cosa ascolta, se non l’eco di una omissione, percepibile proprio mentre ci si accosta a una realtà celata, su cui si tramano rinvii analogici a motivi interiori? (16)
Il lessico è talmente indiziato da non richiedere commento. Basta esibirlo in elenco lineare: «flusso» – «ristava» – «interruzione» – «sospensione» – «persistere» – «divenire» – «pausa». E sembra di rileggere ancora una volta il Gadda recensore di Montale, quando parla di vita che pare «incrinarsi» ed «esitare», sospesa a una modulazione ritmica:
Ed esitare sembra ancora il ritmo, spezzato, crudo, tagliente, scheggiato, e ad ora ad ora […] sciolto e musicalmente liberato […]. Dove è vivissimo il senso della pausa e della cesura, del silenzio e del distacco, della chiusa e della ripresa. (SGF I 769)
L’uscita sul terrazzo, promuovendo una analoga sospensione del tempo e rallentando i vincoli che legano alla dimensione «logico-sperimentale» della realtà, lascia accedere insieme alla dimensione dell’onirico e al recupero memoriale: il motivo del sogno diventa infatti ben presto dominante (il sogno «spaventoso» della fine del tempo e degli anni, cui si associano figurazioni di lutto, o il sogno regressivo verso i luoghi del rimosso infantile). Il terrazzo si identifica così sempre più con un fuoco prospettico che consente all’io di aprirsi virtualmente verso l’esterno e verso l’interno, verso lo spazio dilatato e verso i luoghi profondi della psiche.
Gadda non è certo nuovo a questi percorsi, specie se ad avviarli sta una rete di segnali affidati a simboli variamente affini (la torre, il muro di cinta, la casa, la proprietà) della cui decodifica si incarica lo stesso autore in un luogo delle Meraviglie d’Italia:
è l’amore delle torri, dei fossati, delle chiuse ed alte mura, il sogno dei castelli, e tutte in genere le immaginative, per me così veementi, di casa, di protezione, di chiusura, di porta sbarrata […] di esclusione degli sconosciuti dalla città e dalla casa, son riferibili, dicono, ad un lontano richiamo, ai battiti superstiti della prima vita, memoria di quella fase del divenire che ancora s’implicava in una vita potente e provvida: e la bellezza materna si consumava nell’adempimento. L’ipotesi di questa ricapitolazione e valorizzazione operata dall’inconscio non mi sgomenta per nulla. (17)
Una simbologia da fase «intra-uterina» che è materia di analisi freudiana: fenomeno per altro non nuovo nella letteratura, se solo si pensa – con diversa simbologia – al Rilke delle Elegie duinesi per il tema della torre, e a certi scrittori della Praga fin de siècle per cui diviene motivo dominante lo sguardo dal «di fuori» o «dall’alto». (18)
Ma nel Gadda della Cognizione del dolore, o perlomeno della sezione cui ci stiamo ora dedicando, il simbolo di regressione è insieme archetipo mitico che insorge e si impone nella memoria, unificando i temi del lutto e della perdita (si ricordi: «… Mia madre è invecchiata… […] Sono anni… sono disperato…») con quelli complessi della nevrosi e della dissociazione noetica.
Si va dal sogno-allucinazione che profetizza la morte della madre al sogno regressivo dell’infanzia. Sia il primo che il secondo parrebbero riconducibili, accogliendo la diagnosi freudiana, a nevrosi di traslazione: sarebbe cioè l’incapacità di rapportarsi all’oggetto che si è sovraccaricato di libido (la madre, la casa) e che si è invece perduto o è stato sottratto (la madre sottratta al figlio dal peone, dal fratello, dal ragazzino delle lezioni private…) a provocare una sorta di paranoia, un disturbo psichico narcisistico analogo al lutto, che distrugge l’oggetto d’amore. (19)
A noi interessa sottolineare che anche il sogno si sviluppa nel testo attraverso una catena mnestica che trova nel terrazzo il suo fulcro, il centro da cui si diparte il percorso a ritroso attraverso frammenti di ricordi. Una «ricostruzione indiziaria» alla ricerca di un senso, un pezzo mancante che possa forse consentire di spiegare, capire, conoscere:
«Ma ho avuto un sogno spaventoso… […] Un sogno… strisciatomi verso il cuore… come insidia di serpe. Nero. Era notte, forse tarda sera: ma una sera spaventosa, eterna, in cui non era più possibile ricostituire il tempo degli atti possibili, né cancellare la disperazione… né il rimorso […]! Gli anni erano finiti! […] Tutte le anime erano lontane come frantumi di mondi; perse all’amore…» (20)
Il sogno a questo punto si localizza, prendendo corpo nelle forme consuete della coazione a ripetere:
E io ero come ora, qui. Sul terrazzo. Qui, vede?… nella nostra casa deserta, vuotata dalle anime… e nella casa rimaneva qualche cosa di mio, di mio, di serbato… ma era vergogna indicibile alle anime […]. Il tempo era stato consumato! Tutto, nel buio, era impietrata memoria… (RR I 633)
è dal terrazzo, nella concentrazione assorta di un tempo e uno spazio immobili, che si tenta di rimuovere la rimozione, fino a che il sogno stesso si fa rivelatore, coagulandosi, «riprendendosi» nella figura del lutto. La madre «nera, muta, altissima», la cui immagine scaturisce dall’intimo («Ed era sorta in me, da me!») si identifica così con la «significazione» di morte («figura di tenebra…»): negato ogni transfert sostitutivo («Veturia, forse, la madre immobile di Coriolano, velata… Ma non era la madre di Coriolano!») resta una icona mortuaria misteriosa e irraggiungibile («altissima, immobile, velata, nera…»), immagine chiusa e sopraffatta da «una forza orribile e sopraumana», ineluttabile come il pensiero matricida da cui pare scaturire: qualcosa che opprime e grava allo stesso modo dell’«oltraggio che non ha ricostituzione nelle cose», nel tempo dissolto, non più recuperabile all’affetto.
Non stupisce allora che il sogno successivo, introdotto molto più avanti nel testo, a un passo dall’uscita di scena di Gonzalo, si misuri con la ricostruzione per frammenti della «infanzia malata», visualizzata naturalmente dal terrazzo, luogo – ormai lo sappiamo – che riproposto come motivo seriale all’interno di una strategia ciclica consente il racconto, la trama indiziaria, verso l’investigazione di sé: «Il figlio, dal terrazzo, rivide quegli anni…» (RR I 733). Segue un percorso diversamente allucinato, in cui si esibiscono le figurazioni mostruose e deformi di un carnevale «triviale», rievocate oniricamente dal bimbo – Gonzalo precocemente «oltraggiato» dalle cose.
La resa figurativa tocca qui le tonalità della saga infernale e insieme dello scoronamento parodico, tra «rimbambiti cavalli» e cavalcatrici oscene, pagliacci che non fanno ridere e giganti sbracati: è il trionfo di una materia fecale, graveolente, sdrucita, linguisticamente degradata (non una festa di gente, ma «il berciare d’una muta di diavoli, pazzi, sozzi…»). Da quel sogno può allora derivare a catena un nuovo sogno, sognato ancora «all’impiedi, nel sole» del terrazzo: un sogno di vendetta portata a termine da un Gonzalo-Telemaco pistolero-giustiziere, ritto all’impiedi come il ritratto parodico del suo mitico genitore, un Capitano Ulisse di memoria dechirichiana, scoronato cowboy di un mito disattivato: «Si piazzava allora sul terrazzo, ritto, a gambe larghe sul terrazzo di casa sua, con la pistola a mitraglia, come tenesse un bel mandolino, da grattarlo! da grattarlo ben bene, quel mandolino. Tatràc…» (21)
La memoria non si può annullare. Al termine della scena tragica, Gonzalo partirà, dopo aver attraversato «la terrazza e la sala». Quel terrazzo da cui era apparso all’improvviso alla madre, unico figlio superstite, spenta la luce del fratello:
L’alta figura di lui si disegnò nera nel vano della porta-finestra, di sul terrazzo, come l’ombra d’uno sconosciuto: e, dietro a lui, nel cielo, due stelle parevano averlo assistito fin là. Diòscuri splendidi […] fraternità salva! La madre lo scorse, ma non poté vederne il viso contro il rettangolo di luce. (RR I 685)
Dallo stesso terrazzo la madre lo vedrà scomparire per sempre, eclissarsi anzitempo dal romanzo incompiuto, e lo accompagnerà con lo sguardo che indugia dolente, come per ritardare il distacco:
La madre, dal terrazzo, lo vide allontanarsi e discendere lungo il sentiero dei campi, dal terrazzo dove era rimasta. (RR I 737)
è questa, per i due protagonisti della Cognizione, la fine del tempo, da intendersi come fine delle possibilità di un processo ripetitivo nelle sue trasformazioni incessanti: sin qui lo spazio protetto e sospeso del terrazzo ha reso possibile l’interazione tra l’attuale (l’ora, il qui), e il recupero di un passato reso leggibile a partire dal presente.
Il confronto potrebbe interrompersi su quel presente divenuto ormai assoluto, spazio pietrificato come il fotogramma della figura in nero che resta sul terrazzo immobile e sola. Non sarà così. Sulla fissità atemporale, che non prevede il replicarsi di coincidenze metonimiche o di combinazioni possibili, prevarranno le ragioni dell’incompiutezza e della mutabilità. Il sistema del romanzo rimarrà dunque aperto, a dispetto di qualsiasi riduzione, procedendo verso il proprio destino di «deformazione» infinita.
Università di BolognaNote
1. Sulla tendenza alla ripetizione in Gadda è d’obbligo consultare Roscioni 1975: 42 e sgg.: «[…] chi lo abbia frequentato un po’ assiduamente sa che la sua materia tende a rapprendersi intorno a pochi temi fondamentali, a pochi nuclei di immagini, e conosce i vistosi fenomeni di isteresi che caratterizzano la sua scrittura, per i quali le situazioni, i motivi, i personaggi, le metafore di ogni nuovo libro sono spesso rielaborazioni di modelli e moduli stilistici delle opere precedenti […] Una volta certo di aver colto nel segno, di aver raggiunto l’espressione adeguata, Gadda non esita infatti a ripetersi e ripetersi, con un’insistenza che non sarebbe perdonata ad uno scrittore di minor estro e respiro». Per una ricostruzione accurata delle interferenze tra la Cognizione e il resto della produzione gaddiana si rinvia all’Introduzione e alla Nota biobibliografica di E. Manzotti, Gadda 1987a: vii-li, liii-lxi.
2. RRI 606-07. Va notato il ricorso a un lessico dispregiativo della intuizione, del momento irriflesso, sino a una caustica ripresa di una terminologia da analisi clinica (il «color oro-pappagallo» suggerisce ibridi accostamenti con la denotazione dell’urina, richiamata anche, subdolamente, dalla metafora del «lampo-raggio»).
3. Una testimonianza diretta dell’interesse di Gadda per gli studi storici è in Arbasino 1971: 197. Quanto al Gadda genealogista, uno studio informato e attento si deve a Di Meo 1995: 23-56.
4. Si cita da M. Foucault, Nietzsche, la génealogie, l’histoire, in Dits et écrits 1954-1988 (Paris: Gallimard, 1994), II, 138-39. Il critico vi analizza i diversi impieghi del termine origine in Nietzsche, oltre che il rapporto polemico tra il filosofo tedesco e la storia degli storici.
5. Sul concetto di discontinuità come elemento caratterizzante la mutazione in atto nel XX secolo, cfr. in particolare H. Lefebvre, Introduction à la modernité (Paris: Minuit, 1962), 179 e sgg.
6. Nella Cognizione, precisa Roscioni, la comparsa di Gonzalo «è ritardata dalle deposizioni del medico, del peone, della Battistina, della Peppa, nonché dal conquesto degli avventori dell’osteria dell’Alegre Corazòn, degli abitanti di Lukones e perfino quelli di Pastrufazio» (Roscioni 1975: 46).
7. Roscioni 1975: 43: «Quello che stupisce, ripetiamo, non è che vi siano impliciti richiami da un libro all’altro, ma solo l’inconsueta ampiezza del fenomeno».
8. Cfr. M. Heidegger, L’arte e lo spazio (Genova: Il Melangolo, 1979), 15.
9. SGF I 767: «L’attimo iridato di dolore sfocia spinozianamente nell’Uno universo […]. Ma allora il suo “cupio dissolvi” è ricondotto a una fissità tragica, il rombo del mare disparisce in un’afa stagnante, di che danno imagine le cose riarse nella calura del meriggio, il vacillar dell’ore bige, il filo della bonaccia. E da quest’afa, nuovamente, erompe l’anelito della liberazione».
10. Citiamo dalla edizione italiana di J. Joyce, Ulisse, trad. e commento di G. de Angelis, intr. di G. Melchiori, (Milano: Mondadori, 1978), 8.
11. G. Bachelard, La poétique de l’espace (Paris: PUF, 1967), 169.
12. è lo stesso Bachelard a rinviare, per la poétique de la maison collegata alle immagini della intimità, allo Jung dell’Essais de psychologie analytique, suo diretto ispiratore per queste riflessioni (Bachelard 1967: 18). Trasferita in «incubo discenditivo» (la definizione è di Arbasino, cui devo il suggerimento), la topologia della casa basata sulla popolarità chiusura-apertura, alto-basso, buio luce è al centro anche del percorso narrativo e claustrofobico di Racconto d’autunno (1947) di Landolfi, con analogie sorprendenti rispetto al testo gaddiano, anche se piegate a una tonalità accentuatamente surreale e metafisica (il motivo del vento che ulula sulle imposte sconnesse e poi dell’uragano, la cena parca e il fumo della minestra in un ambiente spoglio, la discesa per «una ripida e lunga scaletta di pietra, tanto angusta che pareva ricavata nello spessore del muro», il doppio terrazzo, i vetri chiusi, le finestre, il motivo della «violazione di domicilio», il muro scavalcato, la cantina…).
13. Ci si riferisce in particolare a L. Binswanger, Introduction à l’analyse existentielle (Paris: Minuit, 1971), passim. Sulla stessa linea si pone il Minkowski, fondatore assieme a Binswanger dell’analisi esistenziale: «… il disorientamento nel tempo va, in patologia, di pari passo con un disorientamento nello spazio»; «… in ogni studio che cerchi di penetrare la natura intima del tempo, si vede apparire sullo sfondo, comparsa muta ma indispensabile, l’idea dello spazio» – Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia (Torino: Einaudi, 1971), 13 e 23.
14. J. Rousset, Forme et signification. Essais sur les structures littéraires de Corneille à Claudel (Paris: José Corti, 1962), trad. it. Forma e significato (Torino: Einaudi, 1976). Il capitolo cui si fa riferimento è «Madame Bovary» o il libro sul nulla, ove si legge al par. 3, Le finestre e la veduta dall’alto: «La finestra unisce la chiusura e l’apertura, l’intralcio e l’involo, la prigionia nella stanza e la fuga al di fuori, l’illimitato nel circoscritto» (134).
15. La diversa redazione è riportata in nota da E. Manzotti, Gadda 1987a: 422. Circa le «brevi note» del cuculo, cfr. SGF I 768: «… la incombenza opaca dell’ora, la stasi: e il termine che risolve questo groppo è una nota, un baleno finale».
16. Su certa analogia col percorso dell’ascolto pascoliano, su cui si sofferma il Manzotti nella nota sopraccitata, è utile riferirsi a un’osservazione di M.A. Bazzocchi, Circe e il fanciullino (Firenze: La Nuova Italia, 1993), 12: «[…] un fenomeno di incantamento sensoriale, soprattutto uditivo, accompagna il processo di regressione della memoria, fìno al recupero del luogo perduto che risorge con caratteri onirici di estraneità». Ma poi, sulla distanza che separa i «simbolisti puri» e «spaziali» (alla Pascoli) dai simbolisti «sedenti» (Gadda?), che riconducono il «motivo estetico» al «motivo etico», è bene consultare lo stesso Gadda del saggio I viaggi, la morte, specie ove afferma, in contrasto col «migrare» indifferenziato verso sensazioni astratte: «Filosoficamente questo anelito verso il caos adirezionale rappresenta un regresso alla potenza primigenia dell’inizio, ancora privo di determinazioni etiche: una ricaduta nell’infanzia dell’essere, così sia lecito dire» (SGF I 581).
17. Una tigre nel parco (SGF I 77). Sul tema della torre in Gadda, si veda Muzzioli 1987: 189-99. Gadda tornerà più tardi sul tema della casa e sui suoi rapporti con l’inconscio in Il difetto e la stravaganza che amiamo, SGF I 1058: «Gli psicoanalisti, nelle loro frondose e prolifere onirologie, ci garantiscono che il pensare o il sognare una casa […] equivale sognare o magari desiderare la madre. L’immagine “casa” è simbolo scaturito dall’inconscio […] manifesta in enigmate il “rapporto affettivo alla madre”, il desiderio di “rientrare nella cavità materna, nella materna locanda”».
18. Sull’argomento cfr. AA.VV., Praga. Mito e letteratura (1900-1939), a cura di A. Pasinato (Milano: Shakespeare and Company, 1993), in particolare 48 e sgg.
19. Il rinvio è a S. Freud, Introduzione al narcisismo e Metapsicologia (in particolare Lutto e melanconia), in La teoria psicanalitica (1911-1938) (Torino: Boringhieri, 1984). La biblioteca gaddiana conserva sette volumi di Freud, tra cui Introduction à la psychanalise e Essai de psychanalyse nella traduzione francese di S. Jankélévitch (Paris: Payot, rispettivamente 1926 e 1927).
20. RR I 632-33. Circa la «ricostruzione indiziaria» e i possibili raffronti con il Freud dell’Interpretazione dei sogni si rinvia a M. Lavagetto, Freud la letteratura e altro (Torino: Einaudi, 1985), specie ai capitoli Lavorare con piccoli indizi; Costruire e distruggere; Ricostruzione archeologica e costruzione preliminare.
21. RR I 736. Il Capitano Ulisse di Giorgio De Chirico è del 1934, anno della pubblicazione del Capitan Ulisse del fratello A. Savinio.
Published by The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS)
ISSN 1476-9859
© 2000-2026 by Niva Lorenzini & EJGS. Previously published in Le maschere di Felicita. Pratiche di riscrittura e travestimento da Leopardi a Gadda (Lecce: Piero Manni, 1999), 129-57.
artwork © 2000-2026 by G. & F. Pedriali
framed image: after M.C. Escher, Magic Mirror (1946) and detail from Reptiles (1943)
All EJGS hyperlinks are the responsibility of the Chair of the Board of Editors.
EJGS is a member of CELJ, The Council of Editors of Learned Journals. EJGS may not be printed, forwarded, or otherwise distributed for any reasons other than personal use.
Dynamically-generated word count for this file is 9290 words, the equivalent of 27 pages in print.


