EJGS Supplement no. 5, EJGS 5/2007
Archivio Manzotti
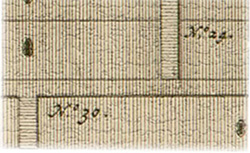 |
Astrazione e dettaglio:
lettura di un passo della Cognizione
Emilio Manzotti
per destino intenderei il complesso gioco delle relazioni di fatto tra l’apparente unità della nostra persona e i richiami o gli ordini trasmessi dal passato e le dure negazioni opposteci (parlo del caso mio) dalla cosiddetta realtà, di giorno in giorno, di momento in momento. Taluni traumi discendenti da negazioni lontane, forse taluni statuti della crudele media o norma hanno irreparabilmente distrutto, con la loro certezza, l’esile insicurezza del mio vivere.
«Nessuno conobbe il lento pallore della negazione»: è l’incipit memorabile, e cifrato, di una pagina in certa misura autosufficiente di cui si può affermare senza esagerazione alcuna la posizione centrale entro la Cognizione del dolore e ad un tempo entro tutta l’opera di Carlo Emilio Gadda. Una pagina fondamentale, il cui valore, nello stato attuale degli studi gaddiani, può tuttavia essere intuito piuttosto che razionalmente colto: mancando sino ad oggi di essa, così come di tante altre pagine dell’autore, non dico una analisi critica esaustiva ma anche solo una lettura che ne chiarisca con la lettera le grandi linee dell’organizzazione complessiva. Le note che qui si propongono non valgono che come una prima approssimazione, come una ricostruzione irrimediabilmente schematica dei fattori strutturalmente preminenti. Più precisamente, cercherò di mostrare come alla pagina sia sottesa una ferrea struttura argomentativa che dà coerenza ad una successione di segmenti ad elevato grado di dettaglio alternati, secondo una caratteristica tecnica descrittiva, a segmenti a grado di informatività radicalmente differente. Inoltre, come la pagina, pur possedendo un’indubbia autonomia, intrattenga legami formali e tematici con tutta una serie di altri testi gaddiani: legami che sono decisivi nella ricostruzione del livello più elementare di significato.
1. Si legga anzitutto la pagina in questione, la iniziale, nella Cognizione, dell’ottavo «tratto», il terzo della parte II:
Nessuno conobbe il lento pallore della negazione. Balie torquate di filigrana o d’ambra, scarlatte chiocce tra i bimbi: occhi e riccioli di bimbi nei sereni giardini. E clamorosi fredoni dentro i loro stalli, dove a disegno dello Scamozzi o del Panigarola s’è fatta rara la tarsìa, l’immagine s’è articolata nel racconto, è divenuta poema. E Santi d’argento, vescovi mitrati sul pulvinare, bevono la nube ricca, l’ebbro crassume della gloria. Ma i momenti del negare anche questi il tempo li adduce verso chiuse anime, suggeritore tenebroso d’una legge di tenebra.
Lo hidalgo era nella sala, davanti lume e scodella. Si era lavate le mani, aveva risposto alcuni indumenti, o una spazzola, in un tiretto, di sopra.
La sua secreta perplessità e l’orgoglio secreto affioravano dentro la trama degli atti in una negazione di parvenze non valide. Le figurazioni non valide erano da negare e da respingere, come specie falsa di denaro. Così l’agricoltore, il giardiniere sagace móndano la bella pianta dalle sue foglie intristite, o ne spiccano acerbamente il frutto, quello che sia venuto mencio o vizzo al dispregio della circostante natura.
Cogliere il bacio bugiardo della Parvenza, coricarsi con lei sullo strame, respirare il suo fiato, bevere giù dentro l’anima il suo rutto e il suo lezzo di meretrice. O invece attuffarla nella rancura e nello spregio come in una pozza di scrementi, negare, negare: chi sia Signore e Principe nel giardino della propria anima. Chiuse torri si levano contro il vento. Ma l’andare nella rancura è sterile passo, negare vane immagini, le più volte, significa negare se medesimo. Rivendicare la facoltà santa del giudizio, a certi momenti, è lacerare la possibilità: come si lacera un foglio inturpato leggendovi scrittura di bugìe.
Lo hidalgo, forse, era a negare se stesso: rivendicando a sé le ragioni del dolore, la conoscenza e la verità del dolore, nulla rimaneva alla possibilità. Tutto andava esaurito dalla rapina del dolore. Lo scherno solo dei disegni e delle parvenze era salvo, quasi maschera tragica sulla metope del teatro. (Gadda 1987a: 351-56)
I cinque paragrafi che precedono sono estratti dalla più estesa unità temporale della Cognizione (117 pp. dell’edizione critica einaudiana – Gadda 1987a: 255-372), dal pomeriggio alla tarda sera di un giorno sul finire dell’estate – quando il protagonista, Gonzalo, si fa sul terrazzo della casa di campagna: «Con le mani alle tasche della giacca, levò il viso, quasi a rimirare alcune stelle». Qualche cenno di riassunto e commento non sarà forse superfluo. Nella solitaria casa di campagna la madre vaga senza più scopo, viva oramai solo per i ricordi dolorosi che abitano la sua persona hantée dalla morte. A fare colma la misura della sua angoscia si scatena un violento temporale estivo, da cui ella cerca scampo con una simbolica discesa verso i luoghi più protetti della casa: ivi, nel buio, la manifestazione finale del male, nel nero dello scorpione. Si placa la tempesta, la sera ridiviene serenità estiva; la madre è rincuorata dalla presenza del contadino e pensieri di anni lontani, pensieri più dolci, guadagnano la sua mente. Torna il figlio Gonzalo, dalla città in cui si reca per lavoro: «Il figlio la salutò appena, come ogni volta, stanco. Neppure le sorrise. Ella non insisté a cercarne lo sguardo, non chiese del viaggio, né dell’uragano. Il cuore le martellava nell’incertezza» (Gadda 1987a: 300). Rade si fanno a questo punto le azioni materiali: banali e pur minutamente rinominate a intervalli regolari (distinguendosi a volte una menzione dalla precedente solo per una infinitesima progressione temporale); e subentra, in loro luogo, la straordinaria ricchezza delle escursioni mentali di Gonzalo, quasi il caleidoscopio fantastico di chi non vive che in sé, non concedendosi al mondo se non per tratti di trita quotidianità. Sarà in particolare la visione del ristorante di lusso, indotta per contrasto dalla francescana cena improvvisata dalla madre. L’unità temporale termina col riscuotersi di Gonzalo, con una sua manifestazione di tenerezza per la madre; e, quindi, col litigio col contadino ed il conseguente licenziamento: nessun ostacolo, così, si opporrà più all’aggressione notturna che incombe. Infine, con l’uscire di Gonzalo, conclusa la cena, sul terrazzo, come s’è detto, «a rimirar le stelle».
Il passo riportato sopra si inserisce, con tutto il rilievo attribuitogli dalla soluzione grafica di continuità (l’inizio di un nuovo capitolo), subito dopo la complessa evocazione del ristorante, e si riallaccia grazie al suo secondo paragrafo (ed al paragrafo che segue) alla esile filigrana di azioni materiali che innerva la sezione centrale dell’unità temporale. Esso («Lo hidalgo era nella sala, davanti lume e scodella. Si era lavate le mani, aveva riposto alcuni indumenti, o una spazzola, in un tiretto, di sopra») è l’esito di altro paragrafo, lontano ben cinquantadue pagine (Gadda 1987a: 301), all’inizio del capitolo precedente:
Il figlio, di sopra, stava a lavarsi: a riporre una spazzola in un tiretto. Ella ne udiva il passo, ammorzato, sopra la soffittatura
(non sfuggirà che la ripresa, oltre a mutare l’aspetto verbale, introduce incertezze descrittive che la prima versione ignorava: si confronti «a riporre una spazzola» con «aveva riposto alcuni indumenti, o una spazzola»). Ma il nostro paragrafo va riportato anche a precedenti passi omologhi, alle pp. 318, 326, 337 e 348 rispettivamente:
Quando discese, con un libro, la zuppa sembrò attenderlo in tavola, al suo posto, nel cerchio della lucernetta a petrolio
Il figlio, all’impiedi, presso la tavola, guardava senza vedere il modesto apparecchio, il poco fumo che ne veniva esalando ecc.
Gonzalo seguitava a fissare come un sonnambulo, senza vederli, il servito, la tovaglia, il cerchio della lucernetta sulla tavola. Poco più fumo, oramai, dalla scodella, verso i fastigi della tenebra.
Il figlio, all’impiedi, con gli occhi sbarrati sopra il paralume, ricordò ecc.
E più avanti (Gadda 1987a: 370), al passo risolutore della protratta sospensione:
Gonzalo, allora, sedette a tavola: e cominciò a recare il cucchiaio alla bocca, senza che l’introito del liquido sfigurasse la gentile figura del silenzio.
è il millimetrico progredire della descrizione degli eventi cui già si era accennato: il solido necessario supporto, anche nella pagina che analizziamo, del delirio interpretativo, del sogno gratuito del personaggio.
2. Una lettura minuziosamente attenta della pagina deve in primo luogo registrare, ad apertura di capitolo, la perentorietà di una asserzione temporalmente delimitata dal perfetto verbale (conobbe) e generalizzata da un quantificatore (Nessuno) privo di ogni indicazione di dominio: «Nessuno conobbe il lento pallore della negazione». La difficoltà a reperire un referente potenziale per Nessuno si addoppia dell’indeterminatezza di un oggetto diretto che malgrado l’evidentia di pallore sembra indubitabilmente astratto: un astratto che apre una lunga serie di sostantivi parimenti astratti (1) (bilanciata in parte dalla violenza di scrementi (r. 20), di rutto (r. 18), ecc., o dalla concretezza evocativa delle «balie […] scarlatte» di rr. 1-2) entro la quale insorgono particelle argomentative come i ma di rr. 6 e 21, o l’o alternativo di r. 19 a suggerire il progredire di un mal percepibile ragionamento. Ci fermeremo, per cominciare, sul primo paragrafo, per cogliere successivamente il o i valori dei quattro periodi che lo compongono, ed il disegno unitario che li sottende. Per ciò che è del primo periodo, anzitutto, è certo che esso può essere inteso solo se lo si riporta, superando la barriera del capitolo, alle anafore: Tutti + PREDICAZIONE A VALUTAZIONE POSITIVA che fioriscono là dove Gonzalo evoca la pienezza vitale – illusoria, certo, e debitamente irrisa, ma vita ad ogni modo – degli ALTRI:
Tutti, tutti entravano nella luce: li avvolgeva la luce della vita […]. Tutti, tutti! Turchi, frittellari, circassi, mendicanti ghitarroni d’Andalusia, polacchi, armeni, mongoli, santoni arabi in bombetta, labbroni senegalesi dai piedi caprigni, e perfino i Langobardòi di Cormanno […]. Tutti, tutti.
Tutti avevano la loro vita: e si erano lasciati varare ecc. (Gadda 1987a: 330-31)Tutti, tutti: e più che mai quei signori attavolati. Tutti erano consideratissimi! A nessuno, mai, era venuto in mente di sospettare che potessero anche essere dei bischeri, putacaso, dei bambini di tre anni. (Gadda 1987a: 343; appare qui, accostata alla positiva, la quantificazione negativa, operante tuttavia solo su ipotetici osservatori)
Ma il primo periodo trova rispondenza in quantificazioni positive anche fuori della Cognizione; ad es. in VlC SGF I 299:
Tutto vaniva. Tutte queste immagini erano vere nella vita degli altri. Tutti erano agiati, laboriosi, e da senno. Dietro ai bozzoli e alle bacinelle delle filande non avevano perduto denari, ma anzi raggiunto buona facoltà,
o in AG RR II 826:
Tutti, pensò l’avvocato, tutti, tutti! a vestirsi delle penne dell’arcangelo, a brandire la sua spada fiammeggiante, che scaccia di paradiso l’Adamo: tutti: con la protervia e col pallore crudele d’un sedicenne corrigendo, quando ha la legge per sé. […] Per lui, per lui solo, i polverosi chilometri, i paracarri infiniti,
o in Villa in Brianza:
Ebbe ognuno di quelli il sorriso di sua madre e la favella della sua gente accarezzò l’infanzia: di Lapo e di Guido, e di Michele, più che mortale, angel divino, e dell’Urbinate che udì la bella fornarina parlare e la vide spogliarsi. Ma per Carlo Emiliuccio la brianzola pisciò.– E i brianzoli parlarono brianzolo, e i lombardi lombardo. (Gadda 2001a: 31)
Di tutte queste quantificazioni compare nel primo periodo del nostro passo la controparte negativa: Nessuno + PREDICAZIONE A VALUTAZIONE NEGATIVA, con una quantificazione estesa dunque esattamente allo stesso ambito delle precedenti: gli ALTRI, i destinati ad «entrare nella luce» (Gadda 1987a: 330): ad es. i ragazzi con «un’adolescenza alla flanellina, e al rosbiffe» (ivi), pur se «idioti dentro la capa più che se la fosse fatta di un tubero» (Gadda 1987a: 326), o le femmine «come barchi di cabotaggio rimessi a nuovo, stradipinte, col riso delle bassaridi aperto su trentadue denti fino agli orecchi» (Gadda 1987a: 322); o i salumai, i macellai, i sensali, i bozzolieri, gli elettrotecnici, i droghieri, gli ingegneri cornuti, ecc. dell’elenco di pp. 322-23. Lo schema, con altra predicazione, applicata ad un ambito più ristretto (ragazze, donne), appare ad es. anche in Accoppiamenti giudiziosi, «Ma a lui nessuna gli aveva mai scritto» (RR II 689), o in una nota costruttiva inedita della Cognizione (riportata per esteso più oltre): «Nessuna vacca aveva mai nitrito per lui a un miglio di distanza» (Gadda 1987a: 547).
A nessuno degli altri, a nessuno di coloro che si abbandonano fiduciosi o ignari al fluire della vita, premiati dalla cieca fortuna e coscienti dei propri meriti, fu dato in sorte di sperimentare nel proprio animo, e letteralmente nel proprio corpo, una esiziale attitudine: quella espressa dal primo astratto del passo – negazione – in concisione epigrafica che i paragrafi 3-5 si incaricano in piccola parte di sciogliere. La negazione è «negazione di parvenze non valide» (r. 12), è «negare vane immagini» (r. 22), è cioè respingere quegli aspetti del «reale», specie del reale sociale, che sono privi di ragione profonda, che paiono, alla acredine giudicante di Gonzalo, manifestazione di ragioni deteriori – spesso proprio della miseria dell’io «pimpante…. Eretto…. […] paonazzo, e pennuto, e teso, e turgido…» (Gadda 1987a: 183) – e non della verità, non delle magnanime virtù (la «elaborante speranza», la «astratta fede», la «pertinace carità» di Gadda 1987a: 98), che da sempre hanno guidato, e devono continuare a reggere, il dolorante «cammino delle generazioni» (p. 97). È una negazione apparentata all’evasione dalle costrizioni del reale che è il proprio del sogno, e come esso, nella interpretazione gaddiana, è quête di verità (cfr. Gadda 1987a: 167-68 – «[sognare] forse è dimenticare, è risolversi! è rifiutare le scleròtiche figurazioni della dialettica, le cose vedute secondo forza […] è fiume profondo, che precipita a una lontana sorgiva, ripùllula nel mattino di verità»). (2)
Il periodo iniziale del paragrafo introduce così astrattamente, privato delle sue determinazioni funzionalmente necessarie (negazione di che? negazione ad opera di chi?) il tema del passo nella sua globalità. Ciò, anzi, con una anticipazione dei successivi scarti tra astrazione e dettaglio: non la negazione stessa è oggetto grammaticale del (dantesco?) perfetto conobbe, ma la sua somatizzazione, quel pallore che la manifesta, modificato in ipallage da lento a qualificarne il protrarsi immedicabile negli anni. Frequente procedimento del Gadda lirico, si dirà, certo (così come in Gadda 1987a: 112-15: «il fuggitivo pavore delle Driadi», «l’antico sognare dei faggi», e «la turchese livellazione del fondovalle»); ma applicato qui a materiale lessicale di estrema pregnanza: pallidi dell’intimo travaglio del pensiero sono i Latini, i lontani antenati di un frammento inedito della Cognizione (Cui non risere parentes, in Gadda 1987a: 531; ivi, p. 532, anche la «perizia d’anni lenti»), «pallidissimo e scarno» il tenente di CdU RR I 172 (dal «pallore alto sopra la statura comune degli uomini») e «sfigurata dal pallore», per fermarci qui, è la madre di Gadda 1987a: 375.
3. Intesa dunque la negazione del primo periodo come un’«attività dell’io giudicante», come il rifiuto di trattare come cosa salda mere parvenze, «muffe della storia» (L’Editore chiede venia, in Gadda 1987a: 480), è necessario soffermarsi, per non vedervi la banale riedizione di un demonismo alla Mefistofele, a ragionare la genesi di un simile atteggiamento, a collocarlo in un suo campo di forze, ed a valutarne in astratto gli esiti, anticipando così alcune movenze argomentative che troveremo più tardi nel passo in esame.
La negazione da parte di Gonzalo, o in generale dei personaggi gaddiani, non è tanto reazione umorale, quanto piuttosto un atteggiamento biologicamente e psichicamente necessitato, tanto da proiettare la sua ombra, a volte, sul singolo rifiuto (di parola o di azione), come suggerisce QP RR II 234-35: «La ragazza taceva, assorta, con gli occhi nel vuoto […]. Taceva, al tacere, fuori, della campagna, di tutta la solitaria campagna: nella sembianza d’un irreparabile diniego». La negazione è in effetti in rapporto dialettico con altro speculare diniego, di cui Gonzalo è l’impotente oggetto-paziente (per usare un termine della grammatica funzionale): il rifiuto da parte del destino, o meno astrattamente, della società, (3) di accogliere ed aver cura della creatura. Si rilegga un ben noto frammento di VlC SGF I 300-01:
Ero solo: con misere vesti. E al ristare d’ogni folata gli aspetti della mia terra. Avrebbe dovuto riescir madre anche a me, se non era vano il comandamento di Dio, come riescì a tutti, al più povero, al più sprovveduto, e financo al deforme, o a chi resultò inetto a discernere. Ma il dolce declino di quei colli non arrivò a mitigare la straordinaria severità, il diniego oltraggioso, con cui ogni parvenza del mondo soleva rimirarmi.
Il «diniego oltraggioso» (ipostatizzato geograficamente nel «totem orografico della manzoneria lombarda», nello «sguardo iettatore» del sauro Talché, il Resegone incombente sulla infanzia di Gonzalo-Gadda) non solo viene sùbito pseudoargomentativamente ricondotto ad una colpa, nella conclusione del passo appena citato («Ero dunque in colpa, se pure contro mia scienza»), ma di più si rafforza di altro diniego, che del primo è forse la matrice: il rifiuto di affetto da parte dei parentes(4) (il tema è notoriamente pervasivo nell’opera di Gadda). I parentes negarono il sorriso al loro nato; ad esso, di conseguenza, secondo la legge che suggella la quarta ecloga virgiliana, (5) saranno precluse le gioie della vita: la mensa del Dio, il talamo della Dea (cfr. ad es. VM SGF I 469: «i versi di Virgilio ci sono richiamati con ripetizione ossessiva dalla sventura di Giacomo [Leopardi]: le verità dolorose ch’essi enunciano per tutti quelli “a cui i genitori non hanno potuto sorridere”, divengono, a lui, oroscopo tragico: || “Nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est”» – ma si veda anche MM SVP 885, VlC e VM SGF I 301 e 459-60).
Diniego operato dai parentes, diniego del destino, diniego-vendetta esercitato da Gonzalo sul mondo (e sui parentes stessi): il nesso causale che lega le due prime denegazioni si completa con un altro nesso causale – tra la prima coppia e la terza denegazione – suggerito indirettamente, ma con evidenza palmare, dalla successione temporale in un altro passo del già citato Cui non risere parentes («Dopo […] tutto […] era stato demolizione ecc.»):
Dopo la timidità e la purezza del bimbo, che aveva continuamente dovuto tremare davanti alla libido sadica degli educatori, (con senno reso nel dolore precocemente adulto, con nervi spezzati dai lunghi anni di terrore e di umiliatrice disciplina) – tutto il restante della sua vita era stata feroce demolizione dello sporco e presuntuoso credo altrui, […] stanchezza e torpore di vendicativo peccato, bestemmia, ecc. (Gadda 1987a: 527)
Ma la negazione da parte del destino e la contro negazione da parte di Gonzalo comportano, abbinate, la distruzione delle possibilità vitali del personaggio: l’assenza, per lui, di stagioni, quelle che gli altri, a tempo biblicamente debito, conoscono: la stagione dei giochi ai giardini, la stagione dei sospiri, quella dello «sguardo autorevole», ecc.: cfr. (sempre da Cui non risere parentes):
La sua vita non aveva conosciuto stagione: non primavera, sotto la ferula della miseria e del sadismo materno: non estate, né dolce autunno, né carità di figli, né nulla [si riconoscerà qui lo schema sintattico di Inf.XXVI, 94 sgg. «né dolcezza di figlio, né la pièta | del vecchio padre, né ’l debito amore | lo qual ecc.»]. Sciocca e priva di significato, le buone azioni vi erano rade, come radi e solitari alberi nel bruciare della steppa andalusa. […] | Senza stagione la vita, e senza gioia. (Gadda 1987a: 527-28)
Discendono da quanto si è visto due conseguenze. La prima è che la modalità di vita che sola è concessa a Gonzalo – la «inutile e stupida sopravvivenza» – non può non contaminare il carattere del suo negare; di esso, nella pagina che analizziamo è certo tematizzato il versante prometeico, ma non gli sono estranei dei tratti che potremmo definire dostoevskijani (nei Dèmoni, un romanzo particolarmente caro a Gadda, Stavrogin dice di sé: «Non sono capace che di negazione, senza la minima grandezza d’animo, senza forza; in me persino la negazione è meschina»). Così la negazione di Gonzalo potrà essere meschina e scialba, analogamente al disprezzo – una variante della negazione – di Gadda per la società in GGP SGF II853: «una società verso cui ho solo del disprezzo, (disprezzo scialbo e senza ira perché non sono più nemmeno capace di questa forza che è la rabbia)».
La seconda conseguenza è che Gonzalo non può essere qualificato che negativamente. Di lui, uomo miserevolmente senza qualità, nulla può essere predicato: né le virtù né i vizi, grandi vizi, dei favolosi antenati. A differenza di Rimbaud, che in una prosa di Une saison en enfer (Mauvais sang) poteva affermare «J’ai de mes ancêtres gaulois l’oeil blanc, la cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte […]. D’eux, j’ai: l’idolâtrie et l’amour du sacrilège;– oh! tous les vices, colère, luxure, – magnifique, la luxure; – sourtout mensonge et paresse», nel sangue di Gonzalo l’eredità delle generazioni è nulla:
«J’ai de mes ancêtres gaulois!…» oh! nemmen questo avrebbe potuto dire di sé, «…. la maladresse dans la lutte!», dal giorno che gli era stata fatta conoscere l’impossibilità di lottare e di aver integro lo scheletrino tremante […]. Nulla dai lontani celti […]: dai Germani nulla […]: nulla dai Magiari e Tartari […]: nulla dai Latini […]. Nulla, nulla! di ciò che era stato lotta, fatica, ricerca, creazione, nobile furto, glorioso scannamento, perizia d’anni lenti, firma a rubrica e volta di cielo sopra la dignità bizantina del sepolcro, vela solitaria verso le Indie, d’attorno la salamoia dell’oceano. Nulla.
La sua anima-bestia, di ibrido, non era che un vuoto crocicchio, dove le strade del dolore e della conoscenza si intersecavano senza tensione vitale, lontanando nel tempo, verso deserti di stupidità. (Cui non risere parentes, Gadda 1987a: 529-32)
Il non vivere, il vegetare di Gonzalo ripiegato su se stesso, è del resto predetto a norma di teoria in un passo de Meditazione milanese, che varrà la pena di citare per esteso:
Quando […] tutto non per nostra colpa rovina in una negazione atroce; allora, ultimo baluardo di realtà, come tavola al naufrago, non ci rimane che il nostro misero significato, il nostro io consolidato negli evi; e su quello esercitiamo la nostra lugubre ora, come chi ha le gambe paralizzate ecc. Il povero bimbo su cui insevisce la rabbia del padre ubriacone (quel tal padre che Mosé raccomanda severamente di onorare, non meno della madre ecc.) altro non potrà che crescere abbattuto e vile, cioè altro non potrà che non crescere. – Ma le negazioni da cui è stata deteriorata la sua realtà fanno che egli regredisca per un processo dissolutore dal suo senso umano n + 1 al senso fisiologico n, ed anche più giù […:] al non essere neppur cosa fisiologica. All’esser malato, stanco, abulico, deforme. All’n – 1. (SVP 770-71)
E poco più avanti:
Ognuno di noi è un povero e in parte separato e differenziato tendere, come un’ala di rondine verso cieli lontani: e se essi gli sono negati da contrastanti realtà, e l’onda tempestosa ha raggiunto e appesantito quell’ala, ciò viene a negare la sua propria realtà. (SVP 774)
La negazione è dunque il proprio del personaggio Gonzalo, ne determina gli atti, ne condiziona le possibilità vitali. Ma oltre a valere da entità narrativa (a base autobiografica), come schema di interazione del personaggio col suo mondo fittivo, la negazione viene utilizzata, o per lo meno teorizzata da Gadda a circa un quarto di secolo di distanza dalla Cognizione, come metodo rappresentativo generale della propria scrittura, come frame in termini del quale trascrivere, categorizzare – e condannare – il mondo reale: si leggano le affermazioni de L’Editore chiede venia:
La sceverazione degli accadimenti del mondo e della società in parvenze o simboli spettacolari, muffe della storia biologica e della relativa componente estetica, e in moventi e sentimenti profondi, veridici, della realtà spirituale, questa cèrnita è metodo caratterizzante la rappresentazione che l’autore ama dare della società. (Gadda 1987a: 480)
4. L’estesa digressione che precede ci è servita, oltre che a chiarire ragioni e conseguenze della negazione, a rilevare nel nomen actionis del primo periodo anche una traccia di una seconda relazione funzionale: in primo luogo negazione di cui agente è il protagonista (così come nell’Adalgisa, RR I 520 «l’oscura negazione e ripudio delle cose abominevoli»), ma anche negazione di cui il protagonista è paziente. Si venga ora (si tornerà ancora più avanti sul primo periodo) ai tre periodi che seguono, collegati sindeticamente. La scansione ternaria indotta dal punto fermo non inganni sulla reale articolazione referenziale: il secondo punto fermo, tra poema ed E Santi (r. 5) è in realtà l’omologo dei due punti tra bimbi ed occhi (r. 2): entrambi marcano dei momenti di una progressione per contiguità (sineddochica nel primo caso, metonimica nel secondo – cioé: per incremento di dettaglio e per prossimità spaziale) entro descrizioni schematiche di due ambiti distinti, condotte con strumenti sintattici di complessità crescente – donde appunto la necessità di maggior forza nella delimitazione interna. La sintassi, in effetti, si metamorfosa progressivamente da nominale a verbale, attraverso la tappa intermedia della relativa triplice apposta alla postmodificazione del sintagma nominale clamorosi fredoni. Due ambiti, dunque, o come diremo due momenti di una argomentazione unitaria, ai quali luoghi paralleli in altri testi gaddiani forniscono un agevole accesso. Il primo momento è quello autobiograficamente evocato in Una tigre nel parco (nell’Ambrosiano del ’36 e quindi in MdI): bimbi e balie nei milanesi Giardini attigui al Castello Sforzesco; cfr. SGF I 75 «Trascorsi i giorni sereni giuocando nel Parco coi primi amici, ammirando i riccioli delle bambine, i loro grandi occhi senza lacrime, estasiati» (mio il rilievo grafico). Esso compare qui, tuttavia, deprivato del rapporto biografico col personaggio, o con l’autore, e viene piuttosto assunto a paradigma di una immutabile stagione della vita (cfr. per questo Gadda 1987a: 286 «Generazioni, stridi delle primavere, gioco della perenne vita sotto il guardare delle torri»); ed in quanto paradigma con un sospetto di maniera, forse, nella perfettissima esecuzione. Le balie, diffratte coloristicamente dall’apposizione («scarlatte chiocce»), sono quelle descritte in L’A (RR I 468), e nella relativa lunga nota (in cui è dichiarata la lontana origine manzoniana delle immagini: il portrait di Lucia nelle ultime pagine del cap. II dei Promessi Sposi), con lo stesso latinismo torquate («torquatus», ornato di collana) cui Gadda ricorre anche altrove: (6)
le balie, ampie e costose, venute di Belluno o di Clusone, torquate d’ambra o di filigrana, d’argento o d’oro: insignite d’armille di corallo, d’argento. Gocce di sanguinei coralli ai due lobi e festante addobbo di merletti e di gale sopra il velluto color pavone del corsetto, sopra lo scarlatto grido delle lor gonne [e nella n. 54: «Rituale il corsetto bleu-pavone, o rosso-scarlatto: e la gonna scarlatta, nel primo caso, o di velluto nero nell’altro […]. Monili di filigrana d’oro, o d’argento, o bei vezzi di ambra o di corallo, e orecchini di corallo, fino al 1938-40, le insignivano»].
Il secondo momento, coordinato da E alla enunciazione del primo (quasi a dire: si evoca questo e questo), è en raccourci l’avvenire sognato ne La fidanzata di Elio (L’Ambrosiano del ’32, poi in CdU) in opposizione al virtuoso matrimonio ed ai prevedibili asettici amplessi con la promessa Luisa («una gran forza d’animo, […] una luce fredda negli occhi»): è la calda opulenza di una solenne cerimonia di matrimonio, secondo il più fastoso rituale cattolico, nel Duomo cittadino, o nella roccaforte artistica del Duomo d’Orvieto. Si veda RR I 230:
Egli sentì, spoletano, che preferiva il vino d’Orvieto [alle limonate «senza il più piccolo seme, con pochissimo zucchero» della fidanzata]. Voleva dei canonici roboanti per le sue nozze, seduti comodi negli stalli d’un vecchio coro di noce intarsiato; voleva il vescovo mitrato ed aurato, con una luce di ametista dalla benedicente mano. Voleva, nell’abside, dei diavoli nerastri dalle ali di pipistrello, che svolazzassero verso l’inferno sulfùreo; con zanne di cinghiale nel sinistro ghigno, con i corni a cavatappi. E in groppa al più cane, con funeste mammelle, la peccatrice nuda, angosciata, bianca [l’allusione è ovviamente agli affreschi di Luca Signorelli].
Di tutta la cerimonia due tratti: i «canonici roboanti» negli stalli del coro ligneo (forse, vien fatto di pensare, proprio il «grandioso Coro ligneo goticizzato intagliato e intarsiato, a tre ordini di stalli» – così nel volume Itàlia Centrale del TCI, Milano, 1923, p. 327 – del Duomo di Orvieto), e le nubi d’incenso che salgono alle statue dei santi, o al vescovo nella sua cattedra (pulvinare). (7) I coristi sono metonimicamente fredoni, cioè, «canti, gorgheggi» (a rigore il francese fredon vale ornamento ad libitum improvvisato sopra un’aria), con un appellativo non dimentico della libera giovialità dei rabelaisiani frères Fredons (v, 26), assidui sì ed eternamente fredonnants alle funzioni, ma dalla dieta mostruosamente nutriente, e disperditori del calor naturale così generato in modi canonicamente eterodossi. Per la relativa che segue si intenderà: dove l’opera dei maestri lignari, attuando mirabilmente disegni di grandi artisti, ha articolato le singole immagini in un ciclo narrativo; «rara» varrebbe così preziosa, ed «a disegno» su disegno (ma i traduttori francesi comprendono «rara» consumata, rendendo «le dessin […] s’est raréfié»). Non è illusorio, credo, vedere qui, ed in particolare nella menzione dello Scamozzi (Vincenzo: il cinquecentesco architetto e teorico dell’architettura vicentino, ideatore tra l’altro di molti interni veneziani), una traccia della molto ammirata (da Gadda) Officina ferrarese, là dove Longhi si ferma sull’«arte stupefacente degli intarsiatori di Lendinara, i fratelli Canozi; amici personali di Piero» (p. 512 dell’antologia curata da G. Contini per i Meridiani Mondadori). (8) Per il Panigarola – pura macchia onomastica? – non soccorron gran che le altre menzioni gaddiane in PLF, favola 183: «la marchesa Maria Carolina Ghiniverti […], nata dei duchi di Panigaròla, principi di Torreberretti», ed in AG RR II 639: «l’asino, che non si vede, zitto come il segretario di Panigarolo»; (9) del resto, poco importa che il nome sia stato suggerito dalla toponomastica milanese (Via dei Panigarolo), o dalla omonima casa in Piazza dei Mercanti, o che esso ci riporti all’oscuro architetto milanese Octavio Panigarola.
I due momenti – visione di infanzia serena, e compimento della maturità affettiva – sono condotti con una tecnica descrittiva fortemente marcata dalle due forze che reggono tanta parte della prosa lirica gaddiana: la variazione e la riduzione (l’élagage degli stereotipi descrittivi); ma, di più, essi sono accomunati prospetticamente per il fatto di rappresentare quanto è concesso agli altri, a tutti gli altri, anche «al più povero, al più sprovveduto, e a chi risultò inetto al discernere» (cfr. sopra): esemplificazioni quasi di due asserzioni contenute in passi già citati di Gadda 1987a: 330-31: «Tutti, tutti entravano nella luce: li avvolgeva la luce della vita», e «Tutti avevano la loro vita, la loro donna». Argomentativamente, dunque, i due momenti valgono come esempi-prova della proposizione iniziale («Nessuno conobbe ecc.»): esempi che sono tipizzanti, secondo la tendenza gaddiana alla descrizione dell’iterato e del consueto, e possono così appartenere ad un tempo al passato degli «altri» e ad un passato inesistito, impossibile, del personaggio Gonzalo. In questo, forse, nella scelta cioè di un punto di vista identico al presente del personaggio rispetto al quale valutare un passato definitivamente sfumato, sta il valore dell’aspetto perfettivo di conobbe del primo periodo (non è tuttavia fuori luogo vedervi una sfumatura gnomica ed una quasi filologica ricostruzione del significato del latino «novi», aver conosciuto nel passato e quindi aver presente, sapere).
I due momenti evocati sono tanto più probanti nel movimento argomentativo della pagina quanto più essi approssimano due nodi della biografia dell’autore: da una parte la inesistita giovinezza (così Gadda stesso, nella favola 26 di PLF); dall’altra la repulsa femminile, tema anch’esso frequentemente riproposto se pure per allusioni (si pensi comunque alla figura del commissario Ingravallo in QP). Di esso, tuttavia, recano chiare registrazioni le note costruttive della Cognizione: Gonzalo vi è un «eunuco flaccido», un castone disponibile ma perpetuamente vuoto, cui persino gli amori ancillari sono interdetti («con scarpe sbilenche e fetide [si legge in Cui non risere parentes] le più fetenti serve lo avevano sdegnosamente respinto, avevano allontanato con ribrezzo la sua cupidità di predone inadempiente, precoce e tardivo, ributtante», Gadda 1987a: 532). Si tratterà ancora una volta di ripulsa patita e di ripulsa preventiva o esercitata quasi a vendetta della prima: bastino le due note costruttive che si allegano (sono di Gadda i rilievi grafici):
Repulsa femminile: […]
Si dice che le vacche in una stalla percepiscono a distanza d’un miglio circa l’arrivo del toro, p.e. quando sbarca dal piano inclinato alla stazione capolinea di Cabeza, ricevuto coi debiti onori dal berretto del capostazione, e tirato per la debita corda dal gaucho, alto e cupo, e pieno di amore dentro alla sua casacca [di] velluto dai bottoni di filigrana d’argento. A un miglio percepiscono il toro, le vacche e fanno muh! muh! E il vento le [parola illeggibile] Oh! nessuna vacca aveva mai nitrito per lui a un miglio di distanza. (Gadda 1987a: 547)Sviluppare il tema delle donne, delle fidanzate, delle supposte fidanzate. Claque non ingenua, ma interessata. Svilupparlo tra il mito, la caricatura e la verità: ma tenendo il tono serio, sorvegliato (Dostoiewski, non Gogol). Egli pensa con orrore: «Ma se maltratteranno le creature» (1° tema allusivo per spiegare la repulsa).
2° motivo per spiegare la repulsa. Timore dei figli deboli, malsani, sensibili.
3° Motivo dialettico: l’eredità fisiologica non ha grande importanza: altri farà: importa il lavoro morale e l’eredità morale (e tecnica). (Gadda 1987a: 542)
5. Chiarita l’articolazione del primo blocco argomentativo (una affermazione + una coppia di esempi-prova), si venga ora al periodo conclusivo di paragrafo:
Ma i momenti del negare anche questi il tempo li adduce verso chiuse anime, suggeritore tenebroso d’una legge di tenebra,
col quale si è subito confrontati da due ordini di problemi, complicati ulteriormente dalla rarefazione semantica complessiva (si pensi ad es. alla referenza del sintagma «una legge di tenebra»): la relazione del periodo col o coi precedenti (l’avversativa Ma va rapportata a tutto il precedente blocco argomentativo, o solo ad una proposizione che lo costituisce? o ancora ad altra inducibile da esso?), e la struttura comunicativa stessa del periodo, che una punteggiatura insolitamente parca non stabilisce in maniera univoca.
Dubbi, a rigore, possono sussistere persino sulla sintassi del periodo: anche questi è oggetto di negare, coreferente a Santi e Vescovi, o ripresa appositiva di tutto il precedente sintagma (i momenti del negare)? Ma la prima analisi sintattica, improbabile semanticamente e ritmicamente, viene esclusa dalla più ricca punteggiatura di una precedente redazione del passo: «Ma i momenti del negare, anche questi il tempo li adduce ecc.». Se dunque anche questi è ripresa appositiva de i momenti del negare, si è dinanzi ad una frase almeno ad una prima analisi comunicativamente contraddittoria. Da una parte essa, dislocata a sinistra, (10) assume come dato il costituente in posizione iniziale; il che implica, a rigore, l’impossibilità di focalizzare tale costituente mediante una particella di grado come anche, solo, ecc: (cfr. la stranezza, ad esempio, di: Anche i momenti del negare, li adduce verso chiuse anime il tempo). D’altra parte la frase focalizza mediante anche la ripresa anteposta al verbo del costituente dato, il soggetto il tempo rimanendo davanti al verbo: proprio come nella struttura frastica della anteposizione enfatica (si veda «Anche QUESTI il tempo adduce verso chiuse anime», con le maiuscole ad indicare l’enfasi intonazionale ed accentuativa), con la quale essa è tuttavia incompatibile per la presenza della ripresa pronominale li di anche questi. Non è certo ragionevole entrare qui in una dettagliata discussione grammaticale; (11) ci si contenterà di suggerire una linea interpretativa, anche se essa non renderà conto di tutti i fatti linguistici.
Il periodo, ci sembra, è costruito attorno a due concetti che sono tematizzati, se pure in maniera parzialmente implicita, nel segmento di testo che precede: i momenti del negare, immediatamente derivabile dal lento pallore della negazione del primo periodo, e il tempo, immanente, come si è detto, in lento, ma anche nella seriazione dei due momenti dell’infanzia e della maturità affettiva (il tempo ne è il motore, o, altrimenti, essi ne sono aspetti successivi). Ora, entrambi i concetti sono presentati come tematici, come dati cioè, da una parte almeno della struttura sintattica del periodo (la dislocazione de i momenti del negare, la posizione preverbale del soggetto il tempo), il quale costruisce su di essi la nuova informazione: essenzialmente, la controparte positiva del periodo iniziale, arricchita dell’affermazione della responsabilità del tempo nell’estendersi del dominio della negazione in anime predestinate. Alcuni, dunque, hanno veracemente sperimentato il «pallore della negazione». Il tempo s’è incaricato di diffonderne, di vivificarne, il germe esiziale. Ma il tempo è già di per sé «suasore d’ogni rinuncia» (Gadda 1987a: 282), suasore quasi di morte, e la sua azione generalmente negativa si completa e si perfeziona del suo influsso sulla negazione: onde l’avverbio anche che modifica la ripresa de i momenti del negare (un inciso di dolorosa esclamazione-constatazione, forse). Il periodo, così inteso (l’interpretazione, si noti, è vicina a quella dei traduttori francesi, che introducono un bien di notorietà sulla scissione c’est le temps: «Pourtant, les moments où nier s’accomplit, c’est bien le temps qui les conduit jusqu’en des âmes closes: ténébreux inspirateur d’une loi de ténèbres»), viene ad opporsi in primo luogo al periodo iniziale, ma anche, per il ruolo del tempo, a tutto il primo blocco argomentativo: è la transizione avversativa espressa dalla congiunzione Ma.
Quanto all’apposizione che chiude il periodo e reinterpreta metaforicamente, col nome d’azione suggeritore, l’operato del tempo, la lettura meno riflessa è quella che vede nella legge di tenebra lo stesso referente dei sintagmi «l’orrore della notte» (Gadda 1987a: 296), «il plasma del buio» (p. 270), «il catalogo buio dell’eternità» (p. 171): e cioè l’«incredibile approdo» (p. 98) della morte. Il tempo che instilla e propaga i germi del negare è dunque, in quanto tale, di nuovo «suasore di morte», come si è appena detto. Ma la legge di tenebra è forse ancora una volta non direttamente la morte, quanto la coazione al negare, che ha conseguenze di morte. Questa seconda interpretazione è parzialmente accreditata dalle correzioni della già menzionata redazione anteriore. In essa sono infatti isolabili – con una certa semplificazione – le fasi seguenti:
… il tempo li adduce verso chiuse anime, cane pastore tenebroso vers[o la cerchia delle torri] → … cane pastore tenebroso la sua gregge di tenebra, quando le torri si levano n[?] → … cane pastore tenebroso la sua gregge di tenebra verso la cerchia delle torri
(d’una legge sostituisce poi la sua gregge). Ciò sembra porre la proporzionalità tempo/pastore = chiuse anime/torri = momenti del negare/gregge-legge di tenebra (l’apposizione di tempo appare così conformata semanticamente proprio come la frase che la precede, con un agente, un destinatario o destinazione, ed un oggetto addotto o condotto).
6. Dopo la pausa di esibita obbiettività del secondo paragrafo, il terzo, che ne riprende il soggetto logico, segna la transizione da leggi o situazioni di carattere generale ad una loro applicazione individuale, e da una contrapposizione binaria (gli altri – le anime chiuse) ad una alternativa pratica che della prima è il riflesso: il che fare? di Gonzalo – se comportarsi secondo la legge dei più, o seguire la propria via (è la «secreta perplessità» iniziale, ripresa ed esplicitata nella disgiunzione «Cogliere […]. O invece attuffarla […]» all’inizio del quarto paragrafo. Narrativamente, non sfuggirà che l’alternativa dibattuta e le ragioni addotte a giustificare la scelta pertengono piuttosto al passato del personaggio che al suo presente, anche se ripropongono stati d’animo che la fisionomia di Gonzalo suggerisce tutt’ora persistenti (cfr. Gadda 1987a: 137 «Un lieve prognatismo facciale […] veniva conferendo al suo dire, ma non sempre, quel tono sgradevole di perplessità e d’incertezza»). Questa attualizzazione di esitazioni (forse) definitivamente risolte risponde alla esigenza di sottrarre il personaggio ad un eccessivo monolitismo psicologico, presentando per un istante come aperta – aperta a soluzioni contrastanti – la sua attitudine.
Ma si segua da vicino la complessa linea di pensiero nelle sue cerniere formali: l’anadiplosi attenuata (dalla sinonimia) «parvenze non valide. Le figurazioni non valide» e la comparazione agronomica «Così l’agricoltore ecc.» che rafforza e proietta in un più vasto ambito il breve paragone economico «come specie falsa di denaro». In Gonzalo la negazione delle «parvenze non valide» del mondo è un epifenomeno che risolve o ricopre una esitazione profonda; rispetto ad un dilemma di indubbia matrice amletica (cfr. sotto), essa è la soluzione imposta dalla orgogliosa fede nel proprio giudizio, e dall’orgoglioso senso dell’onore e del dovere (qualità che gli vengono – malgrado le contrastanti affermazioni di § 3 – dall’avo Pirobutirro: «Circa l’onore e il dovere, quali fossero, come adempirvi […], non aveva mai esitato, mai tremato, mai disperato: dacché alto sul flutto, nel piegare la ruota del timone, soltanto e sempre aveva affisato sua stella», Gadda 1987a: 102). L’orgoglio, una qualità propria ad «anime chiuse», non consente compromessi, non consente peccati contro la verità. Il partito della negazione è dunque una scelta necessitata, come assicura del resto la modalità deontica di «Le figurazioni non valide erano da negare e da respingere», espressa parafrasticamente dalla costruzione essere da. Le immagini che seguono, ristabilendo l’equilibrio tra i due poli della astrazione e del dettaglio, non sono a questo punto una mera duplicazione analogica dell’obbligo (il dover agire) e dei contenuti a cui si applica (la negazione). Se la prima immagine, infatti, sembra limitarsi ad equiparare le figurazioni da respingere alla più paradigmatica specie di falsità (la moneta falsa), la seconda include nella sua più complessa struttura semantica anche una chiara indicazione dell’imperativo morale di cui si nutre l’orgoglio di Gonzalo: si veda in una prima redazione del passo (Gadda 1987 a: 556-57):
La sua intima e più secreta perplessità, il più secreto orgoglio affioravano nella negazione d’una vita non valida: come l’agricoltore e il bravo giardiniere strappano le foglie incompiute dalla bella pianta: riserbano al seme eletto la poca, la circoscritta, la limitata terra. Davanti al limes del nulla, davanti allo spinoziano limite che separa l’essere dal buio nulla, il poco terreno è riguardato per il buon seme: da semine in semen. […] Il senso etico e quasi economistico del limite di possibilità, gli suggeriva l’idea infernale, disumana, che solo alcuni avessero ragione di usufruire della possibilità. Questi alcuni erano i veramente degni. […] Quest’idea, che la poca, limitata possibilità sia serbata ai più degni, pensò, glie la aveva di fatto suggerita la contemplazione della storia [mio il rilievo grafico].
Il negare appare così come un atteggiamento finalisticamente motivato ed eticamente doveroso, analogo alla cèrnita del giardiniere, o, con l’altra immagine agronomica di QP RR II 120, alla «diritta scesa del pennato [che] consacra al frutto l’ulivo, e ne sfronda menzogna»; è meritoria pulizia sociale nella quale non vi è luogo alla pietà (non sfuggirà l’ambivalenza dell’avverbio acerbamente di r. 15, che qualifica ad un tempo una modalità dell’oggetto – quando il frutto è ancora acerbo – e una attitudine del soggetto: crudamente, senza timore di far male). Si ricordino anche i tardi suggerimenti di lettura contenuti ne L’Editore chiede venia, in Gadda 1987a: 487 (la «sicurezza mentale» è una ulteriore accezione dell’orgoglio):
In questa sorta di scoppi d’odio verso i deficienti, gli ebeti, gli opinanti cretini, i calcolatori beccuzzanti sullo strame un lor miserrimo e già risecchito vantaggio […] potrebbesi discernere, oltreché la sicurezza mentale del reazionario e dello hijo-de-algo in buona fede, un calcolo economico e sociologico non privo di una certa lucidità-razionalità […]: un giudizio che potrebbe dar luogo a motivata e probante consecuzione di ulteriori giudizî economico-sociali.
La negazione, al limite, può configurarsi come un intervento correttivo di patenti (per l’Autore) distorsioni sociali – si veda ancora L’Editore chiede venia, ivi:
Voici: il deficiente, o il delinquente nato, o l’ospite di alcuni mirabili istituti caritativi (come la Piccola Casa della Divina Provvidenza creata dal sublime Cottolengo) e d’altra parte il cretino, e magari financo il furbo-cretino e carrierista d’ogni maniera di fraudi, ottengono per sé cure e provvidenze alberganti e tutelanti che il ragazzo vivo e normale non ha conosciuto, quando si vedeva negare [mio il rilievo grafico] dal silenzio stesso di una tutela avara e inconsulta alimento bastevole, adeguata veste contro gelo e rovaio, soccorso pronto ecc.
7. Una esplicita formulazione della perplessità intima di Gonzalo è rimandata, sempre all’interno del secondo blocco argomentativo della pagina, all’inizio del quarto paragrafo, dopo che già la scelta della negazione si è rivelata moralmente imperativa. La perplessità – una perplessità forse solo teoretica: cfr. VM SGF I 539: «In lui [= Amleto] non si contorce il dubbio, chi mai ha inventato questa scemenza?» – è tra i due poli di una alternativa fondamentale, come si è anticipato in § 6: sostanzialmente quella shakespeariana dell’Amleto nella interpretazione gaddiana di VM SGF I 542:
nel monologo famoso, atto III, scena I, […] il non essere è adattarsi alla vita e alla turpe contingenza del mondo, l’essere è agire, adempiere al proprio incarico (alla propria missione) andando, sia pure, incontro alla morte,
o di VM SGF I 539-40:
un dibattito: il ritardante, lacerante contrasto fra le promissioni della vita consueta, del mondo com’è, degli usi civili […], della menzogna acquiescente, del patto ignominioso datore di salute fisica e di pace fisica, e il senso invece dell’incarico e del conseguente adempimento cui siamo astretti dalle ragioni profonde del «cuore», cioè dall’imperio etico d’una ragione sopraindividuale: la coscienza etica dell’eternità.
L’alternativa (sulla quale Gadda tornerà di nuovo molti anni dopo) (12) è del resto espressamente qualificata di tema amletico in un frammento di redazione anteriore riportato in Gadda 1987a: 556:
o si rinuncia a quanto fu (distrarsi, dimenticare) e allora si ripudia il proprio essere: si rinuncia alla vendetta. O si accetta il passato e allora bisogna vivere. Ma il vivere nelle rancure è cosa sterile (Cristo) e bisogna distruggere di sé, l’inutile. Allora il solo bene è la propagazione, la generazione (Cristo, Mussolini), l’aumento, l’incremento. Ma che cosa si aumenta, si sviluppa? Anche alle carote si può dire: «crescite et multiplicàmini».
Come Amleto, Gonzalo si trova, suo malgrado, ad essere investito di una missione, che è «missione fortemente negativa: punisce e cancella il male e l’obbrobrio» (VM SGF I 540).
Formalmente, l’alternativa è drammatizzata, sopra il traliccio sintattico di un parallelismo attenuato, da una incalzante successione di infiniti verbali: da prima cogliere coricarsi respirare bevere, che disegnano momenti successivi di un lubrico amplesso con la realtà (la meretrice Parvenza) sino all’abiezione suprema, la contaminazione dell’anima («bevere giù dentro l’anima»); poi, attuffarla negare negare, con lo straordinario effetto prodotto dalla geminatio dell’infinito semanticamente povero «negare», contrapposto ai precedenti infiniti parossisticamente carichi e, di più, separato, mediante l’interpunzione, da un oggetto («chi sia Signore e principe ecc.») che ad ogni modo grammaticalmente esso non può reggere. (13) Lessico e immagini sono latamente consonanti col sogno di Purg. XIX, 7 sgg., e certo influenzati da Inf. XVIII, 112-14: «giù nel fosso | vidi gente attuffata in uno sterco | che da li uman privadi parea mosso»; ma concordano con altre rappresentazioni crudamente realistiche dello stesso Gadda – ad esempio con Gadda 1987a: 243: «Un rutto enorme, inutilità gli parvero gli anni, dopo le scempiaggini di cui s’erano infarciti i suoi maggiori», e con QP RR II 119: «Col suo sdentato ghigno, e con quel fiato da pozzo nero che lo distingue, il senso comune si sbeffava già del racconto, voleva ridergli una maialata sulla faccia, a don Ciccio, scaracchiargli il no rotondo dei furbi sul suo parruccone ecc.». (14) Il rifiuto di un qualunque principio-guida («chi sia Signore e Principe» – a ben guardare un pastiche dantesco-cervantino in cui il giardin di Purg. VI, 105 si incrocia con Don Quijote I, 43: «la hizo señora absoluta de su alma» e luoghi analoghi), cioè la più estrema variante della negazione, introduce il corposo simbolismo del periodo immediatamente giustapposto: l’anima chiusa che tutto respinge è dantescamente torre salda inaccessibile al vento degli idola tribus, o all’imperio di un Principe estraneo; è monade leibnizianamente catafratta ad ogni influenza esterna (per il valore nel sistema gaddiano di simboli della torre opposta al vento si ricorderà almeno, tra i molti luoghi pertinenti, MdI SGF I 77: «l’amore delle torri, dei fossati, delle chiuse ed alte mura, il sogno dei castelli, e tutte in genere le immaginative, per me così veementi, di casa, di protezione, di chiusura, ecc.»).
Posta icasticamente l’alternativa, rafforzatone il secondo membro con una immagine-correlato dell’attitudine dell’anima chiusa, è proprio ed unicamente questo secondo membro che riceve uno sviluppo logico: si dà così come un fatto acquisito che la scelta si sia portata sull’essere, cioè sul negare, e se ne dettagliano le conseguenze di insostenibilità esistenziale. La congiunzione Ma, oltre al suo corrente valore argomentativo, serba quasi una traccia di certi usi logici, dove essa introduce la premessa minore del sillogismo: qui, di un sillogismo che concluda alla necessaria distruzione dell’individuo negante. Comunque sia, le conseguenze del negare sono espresse mediante una triplice struttura di copulativa identificativa (x è y, cioè x = y), variata nel membro centrale dalla sostituzione ad «essere» dell’equivalente «significare»; elenchiamo per comodità le tre coppie di azioni o atteggiamenti equati:
| andare nella rancura | sterile passo |
| negare vane immagini | negare se medesimo |
| rivendicare la facoltà santa del giudizio | lacerare la possibilità |
(nelle prime due coppie la predicazione riprende il soggetto: andare/passo; negare/negare; e nella terza essa anticipa la comparazione che segue: lacerare come si lacera). Le tre copulative sono tra di loro equivalenti, parafrasi, per quanto non evidenti, l’una dell’altra: vediamo in che modo. L’andare nella rancura, che riformula parte del secondo membro della alternativa («attuffarla nella rancura e nello spregio») e che vale quindi vivere negando [= negare vane immagini, il soggetto della seconda copulativa], è tale da escludere l’individuo dalla partecipazione-contaminazione al fluire della vita, per guidarlo, quasi di regola (cfr. r. 22 «le più volte» e, r. 25, forse), alla distruzione di sé quale vana immagine tra le altre. Ma anche Rivendicare la facoltà santa del giudizio (il verbo ritorna a r. 25), vale a dire porsi a giudice dei «vitali compossibili» (QP RR II 151), equivale, nel caso di Gonzalo, ad arrogarsi il diritto di rifiutare ciò che è impari alla severità del giudizio, e cioè ancora a negare. E giudicare [= negare] significa «porre vincoli al flusso antico della possibilità» (Gadda 1987a: 285). Possibilità, però, nel sistema gaddiano, è sinonimo, o per lo meno caratteristica essenziale, della vita. (15) Giudicare è così un lacerare la fragile trama del reale sulla scorta di una motivazione tutto sommato insufficiente: la manchevolezza locale del reale, con lo stesso atto irriflesso del lacerare in uno scatto d’ira una pagina dove verità e menzogna convivono. Si ritrova così di nuovo l’equivalenza tra negazione e morte o autodistruzione. È interessante osservare che al punto di vista opposto, l’abbandono alla combinatoria e alla differenziazione del possibile nella fiducia di una superiore unità, di una «remota giustificazione» (Roscioni 1995a: 109), Gonzalo sembra accedere per un istante in un frammento della Cognizione (significativamente espunto dalla redazione finale):
Egli [= Gonzalo] per altro ritrovò nella carità del suo spirito, per quanto inturpito dalle comuni voci, l’idea di conoscenza che sola poteva salvarlo da questa «uccisione degli altri col pensiero». Egli si disse che noi non conosciamo se non i meriti effettuali e attuali, non quelli in potenza, occlusi nelle anime e nel futuro splendido come la pianta nel germe. (Gadda 1987a: 257-58)
La coscienza di una limitatezza intrinseca del nostro conoscere comporta la sospensione del giudizio: per quanto apparentemente deformi siano le parvenze e gli individui, «forse la realtà totale ne beneficierà: forse il sacrificio del singolo è necessario alla “madre comune”» (Roscioni 1995a: 110; ma cfr. anche qualche riga sotto: «Queste riflessioni sembrano però formulate astrattamente, quasi per deferenza al principio, tante volte ribadito, della poliedricità e plurisignificazione delle cose; senza che l’ipotesi incrini o allevii la sempre latente disperazione»). L’idea che «la stessa imperfezione del particolare serve alla perfezione dell’universale» (è una affermazione di E. Zeller nel Compendio di storia della filosofia greca, fatta propria da Gadda: cfr. Gadda 1974a: 349-50) è del resto sviluppata teoricamente in MM – essa è o potrebbe essere portatrice di pace:
Così è data pace all’animo di quello che giudica sé prigioniero d’una gente, o d’una occasione, o d’uno stato, o d’un attimo: e di quello anche (a cui è allusione ne’ meravigliosi poemi) alla di cui puerizia e tenero intendere i genitori non han saputo sorridere: «cui non risēre parentes». (SVP 884-85)
8. Entro l’unità argomentativa (la seconda) costituita dai paragrafi 3 e 4 il discorso è declinato rapidamente dal particolare di Gonzalo ad una astratta contrapposizione di scelte, ed alla deduzione delle conseguenze di una di esse. La conclusione – nell’ultimo paragrafo – per Gonzalo e per ogni altro cui «non risere parentes» è, se di conclusione si può parlare, in paradossale reazione alla vis negativa esercitata dal mondo: è l’autodistruzione, nel pensiero almeno, quasi che l’individuo s’incaricasse, proprio reagendo ad esso, di sancire in maniera definitiva il decreto del destino:
Egli, col pensiero, si negava, si uccideva: e uccideva tutti i cretini. (Gadda 1987a: 557)
(è ancora la redazione anteriore della pagina in esame – già citata in § 6). Così, nell’apertura del quinto paragrafo, Gonzalo è prossimo alla negazione di sé; più che prossimo, anzi, poiché il costrutto essere a («era a negare») esprime il culmine della imminenza: il passaggio all’atto. L’affermazione iniziale è seguita da due parafrasi esplicative – la prima dopo i due punti:
i) nulla rimaneva alla possibilità,
(dove «possibilità», come ora sappiamo, equivale a vita), la seconda dopo il punto fermo:
ii) Tutto andava esaurito dalla rapina del dolore
(ritroviamo le opposizioni di quantificazioni universali positive e negative del primo paragrafo). Le due parafrasi reggono un costrutto gerundiale di valore, si intuisce, circostanziale e modale e strumentale ad un tempo:
iii) rivendicando a sé le ragioni del dolore, la conoscenza e la verità del dolore,
la cui importanza è se non altro suggerita dalla citazione, pur nella veste ammodernata di conoscenza in luogo di cognizione, del titolo e chiave di lettura del romanzo. È indispensabile indugiare sopra ii) almeno un momento: perché la menzione del dolore a questo punto? come può il dolore avere manifestazioni e conseguenze identiche a quelle della negazione?
Si è visto che Gonzalo, il quale si ritiene «prova difettiva di natura» e «fallito sperimento delle viscere» (Gadda 1987a: 271-72)e ciò per «l’orribile incaritevole suggerimento del senso di colpa scatenato nella sua disperata infanzia dalla ferocia dei suoi assassini», (16) deve «escludersi dai meritevoli con uno spietato coraggio» e quindi, in rigorosa applicazione del principio «economistico» o della «limitata possibilità», negare a sé il diritto alla vita, ad occupare il terreno destinato al «buon seme». (17) Ma la partecipazione alla vita, anche a quei suoi aspetti che possono superare indenni lo spietato vaglio della negazione, viene resa impossibile dalla presenza del dolore – un dolore che, come in GGP SGF II 855:
prostra, vuota, abbrutisce, distrugge, come dell’acido solforico versato sull’anima. Non resta più niente, se non la faccia della morte.
Si ricordino anche altri passi (strettamente autobiografici, certo, ma che l’autobiografismo diffuso della Cognizione ci permetterà di applicare a Gonzalo):
– il dolore presente cacciava ogni cosa (GGP SGF II 851)
– La tragica sorte […] ha lasciato me a soffrire […] in un mondo che mi è scialbo oramai nell’anima (GGP SGF II 853); è tuttavia un Leitmotiv di tutta la conclusione di GGP: cfr. pp. 850-51: «Orribile senso di miseria e di solitudine nella vita»; «tristezza orrore sulle mura deserte»; «Vento freddo, desolazione. Orrore nelle ore di sera e di notte, nel sole, e sempre. Nessuna sosta al dolore. Nessuna emozione per l’Italia e le cose.– Nessun sogno per il futuro»]
– gli atroci ricordi della mia giovinezza mi sono ormai un dolore insopportabile, che a volte mi fa temere di impazzire, e a desiderare di crepare una buona volta. (Gadda 1984b: 139)
A scalfire lo spessore del dolore non giungono più né la «ragione profonda, antica» della campagna, né la «dirittura delle opere» degli uomini (SGF I 290), cui è intimamente legata la «maniera lirica» di Gadda – si veda ancora GGP SGF II 850:
La patria vuota; (18) paralisi assoluta di ogni emotività per il paesaggio, i luoghi nuovi, ecc. di solito in me così viva. Non ho nemmeno guardato Firenze.
Il dolore di Gonzalo-Gadda (uno «spaventoso groviglio» – Gadda 1983d: 60) ha così le stesse manifestazioni della negazione: di sé Gadda potrà dire: «La mia vita è stata veramente spezzata: essa mi è indifferente, mi appare inutile» (GGP SGF II 859), e: «Questo tutto che mi circonda è una inutile e stupida sopravvivenza»; o soprattutto: «Io non sono più un uomo» (entrambe le citazioni da GGP SGF II 864). Tanto più che «ognigiorno porta una sua nuova ferita, oltre la piaga orrenda che c’è già [= la morte del fratello]». Siamo dunque in grado di comprendere in cosa consista la «rapina del dolore», e come essa si aggiunga agli effetti della negazione per privare la vita di ogni residua attrazione. Ma Gonzalo non solo subisce il dolore (dolore per i lutti familiari, e dolore supremo di vedere le circostanze incaricarsi di realizzare il pensiero segreto, la violenza alla madre) ma lo rivendica a sé come unico vero possesso personale, come l’acquisto più vero del cammino di conoscenza della vita. Insomma, parafrasando un passo della giovanile Passeggiata autunnale (ora RR II 951), (19) «non v’è lume nel mondo ad assisterci, se non la ragione del nostro stesso dolore». È vero, tuttavia, che la cognizione del dolore è la più cruda delle cognizioni, (20) se già ogni conoscenza o cognizione, come afferma Gadda in MM SVP 736-37, è sì una «signoria e quasi dominazione dell’universo», certo, ma una «povera signoria», e piuttosto una «truculenta regina [che] non deterge lacrime atroci e non salva chi deve soccombere e non redime chi deve essere perso o straziato». La conoscenza infatti non può far altro che constatare il male, senza poterlo, il più delle volte, correggere, ed è quindi fonte essa stessa di suppletiva sofferenza. Si ricordino del resto le qualificazioni che quasi di regola – vi sono però eccezioni (21) – accompagnano le occorrenze della parola cognizione e dei suoi sinonimi:
– la mia cognizione insopportabile (MdI SGF II 146)
– la sua conoscenza umiliata (Gadda 1987a: 337)
– la mia disperata conoscenza (EP SGF II 230)
– la luce d’un desolato conoscere (QP RR II 235)
– il male del ridestarsi a conoscere (QP RR II 265)
– lo sgomento […] del conoscere (VM SGF I 461).
A volte lo stesso trascorrere del tempo appare a Gonzalo scandito da suoni che sono o segnano gradi nella conoscenza del dolore: così in Gadda 1987a: 384, dove il rimando d’un battere «dal tempo vuoto deduce il nome del dolore», e in Gadda 1987a: 421-22: «Per intervalli sospesi al di là di ogni clausola, due note venivano dai silenzi, quasi dallo spazio e dal tempo astratti, ritenute e profonde, come la cognizione del dolore». Il tempo accresce conoscenza, ed accresce dunque dolore, secondo la legge di Eccl. 1. 18:
Qui addit scientiam, addit et laborem
trascritta in MM SVP 893: «il saggio, che è più vasta coscienza è per ciò stesso confessione e dolore».
Nella generale perdita di senso del reale provocata dalla negazione e dalla esperienza del dolore, il percepibile si riduce proprio a ciò contro di cui si appuntava inizialmente la negazione: le parvenze di una realtà priva di contenuto. Di esse la comparazione
quasi maschera tragica sulla metope del teatro
ipostatizza la teatralità vuota, il loro «cerebrum non habet». Essa è largamente sviluppata altrove (VM SGF I 593), in un passo che dichiara la natura di rito senza vita delle maschere-parvenze:
Maschere tragiche, ricordàtelo, decorano le mètopi dei templi dorici, i timpani dei teatri neoclassici. Spoglie di ogni attrattiva carnale […], esse ci denunciano in una iperbole fisiognomica la passione enfatizzata, teatrata, dialettizzata in un rito senza il palpitare degli accompagnamenti carnali.
Così della vita non rimangono che i segni più evidenti della finzione, tangibile simbolo, nella rispondenza di astrazione e concretezza sottesa ai successivi blocchi argomentativi, dello scacco a cui è votato il donchisciottismo ideale di Gonzalo. Disegni e parvenze, o maschere, irridono la loro vittima: lo scherno è nozione fondamentale, che ci riconduce ad uno dei punti di partenza, la denegazione alla quale il personaggio è sottoposto da parte del mondo. Lo scherno, infatti, ribadisce la situazione di Gonzalo immerso in un «campo oltraggioso di non forme» (Gadda 1987a: 157), oggetto di oltraggi plurimi, reali o immaginari:
– il signor don Gonzalo tacque, avvertita la insolenza del medicastro (Gadda 1987a: 207)
– la sua figura inutile si riprendeva da un oltraggio non motivato nelle cose (Gadda 1987a: 143),
e testimone e agente egli stesso di altri oltraggi (cfr. «lo scherno dei negoziatori sagaci e dei mercanti» e «le anime erano lontane come frantumi di mondi; perse all’amore…. […] conscie del nostro antico dileggio….» – Gadda 1987a: 272 e 169, rispettivamente). Con lo scherno la pagina fa sotterraneamente risuonare in conclusione la «parola terribile della morte» (Gadda 1987a: 472): poiché, secondo una equazione centrale della Cognizione, fondata sul passo di MM SVP 770-71 citato in § 3,
ogni oltraggio è morte. (Gadda 1987a: 79)
Salvo, di tutto, è, paradossalmente, lo scherno: la morte.
Université de GenèveNote
1. Cfr. ad esempio legge (r. 8), perplessità e orgoglio (r. 11), atti, parvenze e figurazioni (r. 12), ecc.
2. Cfr. anche QP RR II 119, dove «favola» vale una volta, quando qualifica il reale, irrealtà, parvenza bugiarda, e un’altra volta verità, quando qualifica l’evasione del sogno: «Il mondo delle cosiddette verità, filosofò, non è che un contesto di favole: di brutti sogni. Talché soltanto la fumea dei sogni e delle favole può aver nome verità. Ed è su delle povere foglie, la carezza di luce».
3. Cfr. Gadda 1983d: 164-65: «sussistono atroci denegazioni: quella economica […], una causa col Commissariato degli Alloggi per la mia abitazione […]. Inoltre, e soprattutto, il tiranno Bonsanti, vero negriero, faccia di capitano che esercita la tratta dei bianchi, con dosature di freddezze, ire, guardate in traverso, ecc. attende con l’arma al piede ch’io finisca e gli consegni la 4.a puntata di un racconto lungo uscito già con 3 puntate in Letteratura. | Questa è l’angoscia principale, la denegazione proibitiva».
4. I parentes (e i familiari, e gli altri tutti) possono farsi strumento spietato del destino o degli «obblighi» del mondo: cfr: VM SGF I 467 (a proposito del romanzo autobiografico di S. Butler, The way of all flesh): «Il padre è il Veto, il Teobaldo, in quanto reprime senz’avvedersene le insorgenze affettive del figliolo. È la Proibizione divenuta persona. Egli ritoglie ad Ernesto, il figlio, la vita che gli ha dato: perché ne annichila, col terrore del castigo, il sentimento naturale». Si ricordi anche la lettura gaddiana del personaggio di Gertrude nei Promessi Sposi (che mostra una sorprendente identificazione da parte del critico): «Né pace ebbe mai, in nessuno dei tristi giorni del suo vivere, il più drammatico, forse il più vero e splendido personaggio del grande romanzo. Proteso l’animo verso la speranza di vivere e il desiderio di amare, avviata e costretta dal padre a inesplicabile clausura, consegnata, dopo la rovina voluta e a lei procurata dagli “altri”, dal padre, il primo degli “altri”, consegnata ai castighi senza remissione in ottemperanza alle leggi del mondo, il mondo le recò a colpa e a disdoro l’esser caduta, vittima fin dai teneri anni del padre disumano, del fratello primogenito avido e ignaro di amor fraterno, solo riguardoso del proprio creduto “diritto”. Era il secolo, era l’usanza, era il costume, erano gli “obblighi del mondo”» (così nella recensione, del 1965, a G. Berto, Il male oscuro, ora in SGF I 1207). Ma già nel ’27, con Apologia manzoniana, ora in SGF I 682: «dietro grate ingiuste e irremovibili, pallidi visi, occhi cerchiati di rinunzie distruggitrici scrutano la sana vita degli altri e la luce, la perduta luce del mondo polveroso e rivoltolato».
5. Almeno nella lezione nota a Gadda: «cui non risere parentes |nec deus hunc mensa, dea nec dignata, cubili est». Altri restituiscono: «qui non risere parentes [o: parenti] ecc.», vale a dire: «chi non ha (sor)riso ai genitori…», con un valore che ben giustificherebbe d’altronde il senso di colpa di Gonzalo. Si veda sulla questione ad esempio H.J. Rose, Vergil and Plautus, in The Classical Review, 40 (1926): 62; E.M. Steuart, Qui non risere parenti, ibid.: 56; H.J. Rose, Vergil, Eclogue IV. 62-3, again, ibid., 41 (1927): 60; ed infine il commento a.l. di J. Perret (Les Bucoliques, Paris: puf, 1970).
6. Si veda L’A RR I 293 «cani e mastini […] catenati e torquati», ed il participio torquente di QP RR II 193.
7. Analogamente, in CdU RR I 168: «Nuvoli d’incenso rotondo si moruleranno verso i profeti e i pontefici grassi, occhialuti e benefici sopra la cattedra di un qualche Reichstag».
8. Dall’Officina viene del resto alla Cognizione l’idea dello straordinario ircocervo stilistico di Gadda 1987a: 45 («Poiché tutto, tutto! era passato pel capo degli architetti pastrufaziani, ecc.»), scandito sintatticamente come il manzoniano (Promessi Sposi, cap. XXX) passaggio devastatore degli eserciti per le campagne lombarde. Cfr. anche L’A RR I 504-05, dove il passo di Longhi è ampiamente citato.
9. Per cui sarà forse pertinente la citazione di Giovanni Villani, Cronica XI, 70 riportata dal Tommaseo-Bellini: «di ciò era caporale Marcello de’ conti di Panigo segretale e parente del detto Capitano».
10. Intuitivamente, si dà il nome di dislocazione a sinistra ad una operazione che estrae dal quadro frastico un costituente (spostandolo appunto verso sinistra); in suo luogo deve o può comparire nella frase una copia pronominale. Ad esempio, da Il tempo adduce i momenti del negare verso chiuse anime si otterrà: I momenti del negare, il tempo li adduce verso chiuse anime.
11. Entrerebbero allora in gioco, assieme alla dislocazione ed alla anteposizione enfatica, anche le strutture ad argomento sospeso, per cui cfr. G. Cinque, The Movement Nature of Left Dislocation, in Linguistic Inquiry, 8 (1977): 397-412, e ad anteposizione semplice, come in: (Anche) i libri li prendo io.
12. Nella già citata recensione a Il male oscuro (cfr. n. 4): «il monologo centrale della sublime tragedia, dove essere equivale a morire e punire, adempiere il dovere sacro ed esecrando verso il padre assassinato e la di lui discendenza, la di lui consecuzione biologica annullata dal delitto: non essere significa esimersi dal dovere della riparazione verso la richiedente vita».
13. Dire chi sia, ma non negare chi sia.
14. Si ricordi anche la «notte, bagascia disfatta» di CdU RR I153, sdraiata «nella pozza fradicia dell’Altipiano».
15. Si ricordino per la identificazione di possibilità e vita almeno i passi seguenti: Gadda 1987a: 109-10 n.: «[la morte] la è una disgiuntura o spegnimento d’ogni accozzo di possibilità compatite»; QP RR II 70: «la morte gli apparve, a don Ciccio, una decomposizione estrema dei possibili»; Gadda 1987a: 168: «una sera spaventosa, eterna [= la morte], in cui non era più possibile ricostruire il tempo degli atti possibili», e p. 296: «nel silenzio, discendendo il tramonto, vanite le tempeste della possibilità».
16. Cioè, gli «educatori»; è sempre il frammento di redazione anteriore citato sopra.
17. Cfr. sempre la redazione anteriore: «Questo concetto che gli Inferi e le Corone Unite applicano così benignamente alle proprie disponibilità di paese e di gente [l’allusione è alla dottrina del presidente americano Monroe: cfr. PLF, favola 85], egli lo applicava con negazione spietata a se stesso, alla sua [parola illeggibile] intellettuale e agli altri».
18. è un altro Leitmotiv – cfr. GGP SGF II 849 («Direi che presentissi! La patria vuota»), 860-61 («Le Alpi; sole; campagna; animo deserto; la stazione idrometrica. Patria vuota. Tristezza, caldo»), 862 («vuoto nel mondo, polvere, disgusto», ecc.).
19. Cfr. anche, ivi, una ennesima dichiarazione degli effetti distruttivi del dolore: «Stefano lasciò il dolore prorompere alle devastazioni cacciandosi avanti, come il torrente fa d’una preda, la sua fanciullezza e la vita, divelte dalle terre del sogno».
20. Cognizione, per Gadda, è oltre che lo stato (il possesso della conoscenza), «anche il procedimento di graduale avvicinamento ad una nozione» (così in una intervista televisiva: Gadda 1993b: 87), vale a dire l’acquisto della conoscenza.
21. Cfr. Gadda 1983d: 55: «Loro sono stati i miei iniziatori alla Liguria, e di molte luci e ombre di ulivi, di pini e di uomini mi hanno facilitato e anticipato la cognizione».
Published by The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS)
ISSN 1476-9859
ISBN 1-904371-16-7
© 2007-2025 by Emilio Manzotti & EJGS Manzotti Archive. First archived in EJGS (EJGS 5/2007), Supplement no. 5. Previously published in Cenobio 32, no. 4 (1984): 332-56.
Artwork © 2007-2025 by G. & F. Pedriali. Framed image: A Cabinet of Curiosities (Wunderkammern) – detail from an illustration in V. Levinus, Wondertooneel der natuur, tome II (1715), Strasbourg University.
The digitisation and editing of EJGS Supplement no. 5 were made possible thanks to the generous financial support of the School of Languages, Literatures and Cultures, University of Edinburgh.
All EJGS hyperlinks are the responsibility of the Chair of the Board of Editors.
EJGS is a member of CELJ, The Council of Editors of Learned Journals. EJGS may not be printed, forwarded, or otherwise distributed for any reasons other than personal use.
Dynamically-generated word count for this file is 12455 words, the equivalent of 36 pages in print.


