EJGS Supplement no. 5, EJGS 5/2007
Archivio Manzotti – Le ragioni del dolore
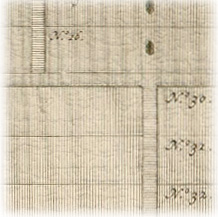 |
Carlo Emilio Gadda: un profilo
Emilio Manzotti
1. Carlo Emilio Gadda virtuoso della parola per pochi lettori-filologi: calligrafo di raffinati e a volte manierati frammenti di prosa, barocco animatore di ircocervi sintattici e rappresentativi. Gadda scrittore etico: il moralista che schernisce senza pietà le manifestazioni aberranti della vita (negatore, a momenti, della vita stessa); o che interpreta commosso il «dolorante respiro delle generazioni, de semine in semen». Gadda, ancora, profondo osservatore del reale, e limpido costruttore di descrizioni referenziali e di argomentazioni oggettive. La sommatoria critica degli aspetti molteplici – e divergenti – di una personalità straordinaria di scrittore appare fissarsi stabilmente nell’ultimo decennio del secolo in un valore, e in una certezza: che Carlo Emilio Gadda sia il maggior prosatore del Novecento italiano, e uno dei maggiori del Novecento europeo accanto ai nomi (Benn, Joyce, Kafka, Musil, ecc.) di un canone ormai consolidato. Questo non tanto forse per novità di temi (la problematica gaddiana, per quanto esoterica rispetto alla provincia letteraria italiana, è quella della grande cultura europea degli inizi del secolo), o per forza di sperimentazioni (gradi superiori di innovazione sono stati toccati da altri); e nemmeno per la virtuosità linguistica o la pervasiva eticità – quanto per la rara concentrazione espressiva di un prosa al calor bianco che nei momenti più alti si scolpisce nella memoria con stringenza aforistica («dietro sbarre del tempo finito», «memento innecessario, crudele», «lento pallore della negazione») degna dei classici della parola pesante, (1) e del molto amato e citato Orazio (2) in particolare.
Stringere in formule ciò che singolarizza uno scrittore – specie uno scrittore di contraddittorie motivazioni – è possibile solo a patto di schematismi e semplificazioni. Rinunciando dunque a priori a sfumare il quadro, e ricordato preliminarmente che la formazione del nostro autore è saldamente classica, e filosofica (in particolare Leibniz, Kant e Spinoza) e tecnico-scientifica grazie agli studi di ingegneria, si cercherà qui in primo luogo di tratteggiare il campo di forze, di natura espressiva e ideologica, che può dar ragione della sostanziale polytropìa gaddiana, narrativa e linguistica in senso stretto. Si individueranno poi due atteggiamenti, il lirico-patetico e il comico, che colorano in modo distintivo la rappresentazione, e interagiscono con la scelta narrativa di temi e personaggi. Quindi, ci si fermerà su due esempi concreti di come nasce e si conforma la pagina di Gadda, studiando il costituirsi di un tema caratteristico attraverso successive riscritture, e più tecnicamente il trattamento, in un paragrafo di un racconto celebre, della simultaneità tra azioni e dell’opposizione tra puntuale e abitudinario. Si concluderà infine con una rapida guida ragionata alla lettura del Gadda maggiore.
2. Nel «groviglio del reale»: «una infinità di rapporti» (3)
2.1. Storia e prassi nelle cose. Nel convocare sulla pagina cose e situazioni, la scrittura tende in Gadda a sovrapporre al presente del rappresentato il suo passato, vero o possibile, ed un suo ipotetico o già riconoscibile futuro. Cose e situazioni non sono in maniera assoluta, non vengono isolate nella loro contingenza temporale. Esse sono piuttosto in quanto momenti di un divenire, «pause di una deformazione in atto». (4) Alberi a marzo, ai bordi d’una via cittadina, ad esempio, sono colti in un momento climaterico, di transizione tra il passato dell’inverno, che non è più, e il futuro del risveglio della primavera, che non è ancora:
I platani e i rami della Merulana furon selva, allo svoltare, intrico, per lo sguardo, sul discendere parallelo dei fili, di cui si alimentavano i tramme: ancora scheletriti nel marzo [qui il segno nel presente del passato], con di già [ora l’anticipazione del futuro ]un languore in pelle in pelle, tuttavia, na specie de prurito per entro la chiarità lieta e stradale della lor còrtica, fatta di scaglie e di pezze ecc. (QP RR II 264)
Gadda stesso, del resto, in un passo sovente citato (5) de I viaggi la morte (SGF I 629), asserisce che «cose, oggetti, eventi, non mi valgono per sé, chiusi nell’involucro di una loro pelle individua […]: mi valgono in una aspettazione, in un’attesa di ciò che seguirà, o in un richiamo di quanto li ha preceduti e determinati». Tra gli esempi di questa costante gaddiana il più impressionante è forse il catalogo dei preziosi (la refurtiva celata nell’antitetico volume di un pitale, (6) sotto «noci» forse goethiane), affidato a pagine giustamente celebrate (7) del Pasticciaccio, che arricchiscono la contingenza di geologia e mitologia e storia immaginaria. Ma esempi dello stesso fenomeno emergono nella lettura ad ogni momento: così le «probabili lattughe», lattughe, insciallah, future, cui fingono di accudire «con un rugginoso coltello dal defunto [= appartenente al passato, scomparso] manico» le donne del primo racconto degli Accoppiamenti (Cugino barbiere, RR II 599). (8) Ancora, un paesaggio centroitaliano è definito programmaticamente da un alter ego di Gadda – che ne possiede la «cognizione del profondo» – come «affiorante parvenza della ragione e della causa geologica» (MdI SGF I 147). Secondo il principio di rappresentazione storica che si sta illustrando, la presentazione del dato si fa a volte in itinere, seguendo le tappe del percorso, ed anticipando le future, e il volere che le determina. Ciò accade ad esempio in un passo de Gli anni (SGF I 205) che ripercorre il cammino delle acque: «L’acque, dopo aver lavato la silice e alcuni dicono anche la gemma opale che si nasconde nel buio, rampollavano in questo loro bacile dai cammini di sotterra, come fa la talpa, minatore paziente, cieco: ed esse per voler riconoscere in sé il cielo e forse la nuvola, simile a quella d’altro giorno e tempo ecc.».
Ma una simile tendenza rappresentativa non si manifesta solo nella dimensione temporale della storia e delle consecuzioni di effetto e di causa. Se il dato evoca passato e futuro, esso è strettamente associato anche ad un potenziale presente alternativo di impieghi o situazioni tipiche o esemplari. Le cose del reale sono percepite cioè anche attraverso la prassi in cui esse sono o possono essere coinvolte. È in nuce qui la tendenza (di cui si parlerà in § 2.4) alle serie di accostamenti fattuali e analogici che producono nella pagina gaddiana un caratteristico continuo rampollare di minidigressioni. Ma ci si limiti per ora a qualche esempi0 (9) di oggetti collocati entro un loro mondo possibile: un orizzonte mentale che non è (solo) dettato da una volontà di mimesi del pensiero di un personaggio. Lo sguardo che si posa sui preziosi del Pasticciaccio non è unicamente quello del mineralogista e del gioielliere:
due bùccole […] per i lobi di una popputa ridanciana vestita di celeste [mio, anche negli esempi seguenti, il rilievo grafico]
un anellino di fil d’oro, con un chicco rosso di melagrana da beccarlo un pollo
un dondolino ultimo, un gingilluccio, quasi una palletta di blu di metilene da cavare il giallo al bucato, tenuto da una calottina d’oro e da un pippolo [= grano, chicco]: e tramite questo appendibile, per maglia d’oro, ad altro e altrettanto essenziale organo del finimento, vuoi della ricolma bellezza d’un seno, come anche del maschio risvolto del bavero o della panciatica e orologiata autorità del tutore di codesto seno, amministratore, morigeratore e in definitiva consorte, «e babbeo del diavolo!» ideò il Pestalozzi a denti stretti; (RR II 230-31)
non è nemmeno lo sguardo di una ragazza della campagna romana, o di una contadina. È, diremmo, uno sguardo cognito, che riassume in sé tutti i possibili, e a cui nessuna manifestazione del reale riesce a sottrarsi.
2.2. Storia e prassi nelle parole. Oltre alla natura ed alle situazioni, la parola stessa è per Gadda carica di storia e di usi, e generatrice (in parte per memoria di precedenti contesti, in parte per altre ragioni) di associazioni molteplici. Il suo impiego è raramente neutro. Anzi, coi termini di VM SGF I 436: «La parola convocata sotto penna non è vergine mai […]. Le parole nostre, pazienterete, ma le son parole di tutti, pubblicatissime: che popoli e dottrine ci rimandano». (10) Per l’ipersensibile orecchio linguistico dello scrittore, cioè, la parola non è disgiungibile dagli impieghi in cui essa è stata precedentemente colta. Tra essi Gadda sceglie di far risuonare le armoniche più utili, o, a volte, di rinunciare ad ogni contrappunto per una parola nudamente referenziale (così accade per la rappresentazione degli atti quotidiani in una pagina della Cognizione: (11) «Il figlio, di sopra, stava a lavarsi: a riporre una spazzola in un tiretto. Ella ne udiva il passo, ammorzato, sopra la soffittatura. | Andò in cucina a preparargli qualcosa da cenare»). Ma vediamo, degli impieghi non neutri, una coppia relativamente elementare di esempi di genere diverso.
Si consideri in primo luogo il termine vaporare di un passo del Pasticciaccio di alta concentrazione formale e simbolica:
quando vapora su su, lieto e turpe, il riso, dalle genti e dall’anima […]. Quando gli tremola un poco, alle case e a tutti li tetti degli uomini, un àere azzurrino sopra il colmo. Quando il caldo letamaio fuma, sopra il gelo, risorgenti speranze: le speranze favolose della verità! (RR II 120)
Vaporare, verbo raro, e quindi difficilmente casuale, possiede una tradizione letteraria delle più rispettabili, dal Convivio dantesco sino a Pascoli e a d’Annunzio. Ma in Gadda il termine rimanda specificamente ad una sensibilità simbolista. Da una parte per la sua occorrenza, in un romanzo dannunziano che ha lasciato molti segni nel Gadda lirico, il Trionfo della morte, entro il tema del concorde respiro degli alberi (si pensi ai paragrafi iniziali della sinfonia dell’Adalgisa): «Le varie forme vegetali, distinte da presso, perdevano a mano a mano nella digradazione i loro contorni come se vaporassero per il sommo, tendendo a comunicare in una sola immensa forma confusa e respirante d’un solo ritmico respiro». Dall’altra, per il suo ritornare, in accezione solo apparentemente realista, nel Pascoli dei Primi Poemetti (La calandra II, 6): «Fuma il letame e grave oggi vapora», proprio cioè in una immagine che è usata da Gadda come corrispettivo naturale del salire infrenabile dagli animi – quasi il prorompere di una forza primitiva – del riso dissacratore. Ma il potenziale associativo di vaporare non è per questo esaurito. Ad esempio, a volerlo esplorare in una nuova direzione, il parallelismo sintattico e semantico tra «quando vapora» e «Quando gli tremola ecc.» ci conduce ad uno dei temi topici della latinità classica, un prototipo della poeticità occidentale: il tema virgiliano dei culmina che quetamente fumant nella chiusa della prima egloga.
Il secondo esempio, di una traccia ancora più esigua, illustra tuttavia bene il genere di lettura e di complicità che richiede la pagina gaddiana. Si tratta di un participio passato della Cognizione: il «pervenuti» di Gadda 1987a: 9. Gli Indios di un paese sudamericano (che traspone l’Italia degli anni venti) sono, per quanto decimati dalle malattie e dai Conquistadores, «pervenuti fino al secolo e ai clamori della radio». Come mai, si chiede il lettore, questo pervenire di registro alto – e che senso avrà tutta l’immagine d’un faticoso approdare alla prosaicità di un porto di sciocchezze (i «clamori della radio»)? Questo verbo pervenire mi sembra conservare, in molte se non in tutte le sue occorrenze in Gadda, la traccia di un impiego memorabile, un impiego a dire il vero che la memoria ha surrogato alla lettera della fonte: il pervenere tacitiano (in realtà venimus)di Agricola, 3, un passo caricatosi per Gadda di valore esemplare: quello della vita sprecata, di sofferenza, di inutilità, di stagioni buie, e del precipitare per esse della vita alla vecchiezza e al nulla: «exemptis e media vita tot annis, quibus iuvenes ad senectutem, senes prope ad ipsos exactae aetatis terminos per silentium venimus». Il passo viene condensato, a memoria, in VM SGF I 508 con una vera e propria formula in cui la dominante è il solenne perfetto pervenere: (12) «Vale per me, come per altri più generosi di me, la battuta di Tacito: “per silentium ad senectutem pervenere”». E analogamente in EP SGF II 225, dove il perfetto latino è tradotto con una forma composta (dunque con un participio passato, come qui): «Ventun anno: il tempo migliore d’una generazione, che è pervenuta a vecchiezza a traverso il silenzio. Per silentium ad senectutem». Due pagine dopo (SGF II 227), della mussoliniana conquista del potere si dice: «pervenne infine […]. | Pervenne, pervenne. | Pervenne a far correre ecc.». Anche qui, come nel passo degli Indios da cui si è partiti, un approdo di demenza è l’esito di anni di strenuo obdurare.
2.3. Mimesi, parodia e innovazione: uso «spastico» della lingua. In queste condizioni di lingua contrappuntata dall’eco di voci infinite, due vie si aprono all’autore. La prima è quella della mimesi o della parodia; l’altra è quella dell’innovazione semantica, del distorcere la parola dai valori e dai contesti usuali conferendole nuove armoniche, rifiutando in certa misura, e tuttavia presupponendolo, l’automatismo del sistema langue. Gadda è certo scrittore mimetico, camaleontico anzi – il che non vuol dire bassamente naturalista o realista, anche se la realtà è dotata nella sua pagina di una evidenza unica – capace come pochi altri di far risuonare accenti, intonazioni, giri di frase con perfetta verità ed economia di mezzi. Il parlato dialettale dei personaggi può ad esempio essere reso, rinunciando alla semplicistica trascrizione letterale nei modi seguenti: i) con un inserto dialettale minimo in un dettato perfettamente italiano («desoravia» nella citazione a), più sotto); ii) con una italianizzazione forzosa, fonetica o sintattica; la veste linguistica è apparentemente italiana ma tradisce l’originale (si veda ancora in a) «cifone», vale a dire il lombardo «cifòn», comodino, e «son già dietro a», la forma progressiva, equivalente a stare + gerundio verbale, dei dialetti gallo-italici); iii) una glossa metalinguistica, come nella citazione b):
a) e teneva anche qualche libro desoravìa del cifone, per leggere di tanto in tanto anche quello […]. Mentre i contadini, alle otto, son già dietro da tre ore a sudare ecc. (Gadda 1987a: 75)
b) «Ho fatto tardi quest’oggi, a momenti è già qui mezzogiorno». «Qui» moto a luogo si dice «scià» nei dialetti della Keltiké. (Gadda 1987a: 117-18)
Gadda si spinge a volte sino ad evocare la voce parallela d’una o più traduzioni simultanee, come accade in VM SGF I 519: «l’interiezione “ciosca!” […] intercorre talvolta a significare meraviglia, equivale tal’altra un “beninteso!” (bien entendu, selbstverständlich)», o in Gadda 1987a: 484: «deliberata elettività ghiandolare-umorale di chi scrive (des Verfassers)», o, ancora in Gadda 1987a, appena sotto (pp. 485-86), in un passo di alto virtuosismo polifonico, su cui vale la pena di soffermarsi un istante:
storiografi «moraloni» che raddrizzano le gambe a’ cani, che riformano il passato a cose fatte (après coup) raccontando giusto giusto il contrario di quel che accadde, perché a riferire l’accaduto vero si perde il posto di storiografo: o si lascia la capa nel cestello: dans le panier.
La locuzione italiana e la corrispondente francese, una anòdina, l’altra carica di storia e di sangue, sono a due riprese accostate (ma in precedenti redazioni la seconda, ad accertare il carattere astratto della polifonia gaddiana, non ancorata ad una verosimiglianza storica, era in inglese: «in the basket»), (13) e ad esse si affianca la nota genericamente napoletana di «la capa», preceduta, a far colma la misura, da una locuzione idiomatica di sapore manzoniano (Promessi Sposi, cap. I: «Questo [il soggetto è don Abbondio] chiamava un comprarsi gl’impicci a contanti, un voler raddrizzar le gambe ai cani»), che però il fatto minimo del troncamento («a’ cani») (14) innalza ad un livello cruschevole (del resto anche il superlativo avverbiale di «giusto giusto», esattamente, è di lingua) o comunque idiomatico toscano: quello, si noti, della citazione nella Crusca e nel Tommaseo-Bellini – dizionari utilizzati da Gadda – s.v. raddirizzare: «questo è altro che lavare il capo all’asino, o raddrizzare le gambe a’ cani». Citazione oltretutto di una autorità in fatto di lingua, il notomista secentesco toscano Lorenzo Bellini, gaddiano incrocio di barocco e razionalità.
Ma Gadda, oltre che l’agile adesione mimetica al reale (linguistico ed extralinguistico), e quella mimesi di secondo grado che è la parodia, (15) persegue anche l’innovazione linguistica e rappresentativa, la disarticolazione degli stereotipi che sono l’usuale comodo veicolo del pensiero, o del non pensiero. I modi di questo rifiuto della parola trita (rifiuto che è anche di altri autori novecenteschi: si pensi alla concezione dei binari deviati in Céline; un precursore ottocentesco italiano è il Dossi di cui Gadda tesse in uno scritto un elogio prevaricante) – questi modi sono di vario genere, raggruppabili comunque per la maggior parte (se si prescinde dalla realizzazione parodica, che rinnova gli stereotipi letterari) sotto il denominatore comune della risemantizzazione, del conferire cioè alla parola che l’uso aveva smussato un nuovo peso, una verginità espressiva. Ciò avviene, con una certa frequenza, grazie al procedimento che Gadda descrive come un
conferire un significato nuovo al vocabolo, per un arbitrio inventivo che resulterà poi, alla pagina, più o meno saggio e felice […]. | (16) La frase e il vocabolo […] si spogliano delle tonalità loro parodistiche: (17) venute in carta al cri-cri lieve della penna, si libera, ognuna, a un tono novo, a un timbro perverso. Si demanda loro novo incarico. La nova utilizzazione le strazia: la lor figura si deforma, comparativamente all’usato, come d’un elastico teso. (VM SGF I 437)
L’applicazione più pervasiva di questa poetica della diversità, di un uso della lingua spastico [= sforzato, tirato] – come Gadda lo chiama elaborando l’idea oraziana della callida junctura nell’epistola ad Pisones – è senza dubbio nella sintassi, sottoposta ad una triturazione molto più spinta della pascoliana, con esiti che la pongono agli antipodi del legato dannunziano così come di molta prosa d’arte novecentesca.
Noi ci limiteremo qui ad un esempio di innovazione lessicale: la quasi-invenzione di un termine e la condensazione in esso di una costellazione di significati. Il termine è il qualificativo matronimico liriopesco. In uno dei saggi raccolti ne I viaggi la morte, Emilio e Narcisso, Gadda, che volentieri ricorre nell’opera della maturità agli strumenti dell’indagine del profondo, riscrive in chiave psicoanalitica la metamorfosi ovidiana di Eco e Narciso. Il
cefisio Narcisso, come lo chiama don Gabriele, (18) era […] il figlio incredibilmente bello di Cefiso e della ninfa Lirìope. Li-ri-o-pe. Annotatelo da non dimenticarlo. […]
Nel primo essor dei quattordici, nel pieno éclat de’ suoi ligustri-rose (a noler citare garofani) con quella prima lanugine come di pesca d’agosto che gl’indorava l’indorabile, il Narcisso era amato e affocatamente era desiderato da mille: fanciulle, fanciull… e: sì, fanciulle. Pure non volle saper d’alcuna né di nulla: respinse tutte, tutto. La ninfa Eco […] arse ella pure di lui. E lui picche. Per disperata la riparò nei monti, ove non è che dirupi: fintantoché vi lasciò l’ossa, e una voce che rispondeva da una rupe. Ecc. (SGF I 643-44)
Converrà davvero annotare il nome della ninfa, Lirìope, Λειριόπη, di cui i commenti alle Metamorfosi – ad esempio quello classico di Ehwald e Albrecht – segnalano la ovvia derivazione da Λείριον giglio, vedendovi nel contempo la tendenza alessandrina a rafforzare di legami etimologici i legami di parentela (secondo più testimonianze νάρϰισσος e Λειριόπη designavano in effetti uno stesso fiore). In Liriope Gadda, teorico dei doppioni e dei triploni lessicali (giglio e lilio e ligio e lirio – il secondo e il terzo compresenti nelle brevi linee di una favola leonardesca ripresa in PLF), non aveva difficoltà ad individuare la base botanica, che del resto il familiare Tramater (19) gli confermava ad abundantiam, in prosa irtamente tecnica, anche per tutto il termine (i lessici attuali, semplicemente, individuano nella liriope un genere della famiglia delle Liliacee), con la giunta di una seconda etimologia fantastica e, per di più, esattamente della scansione in sillabe utilizzata. Le voci pertinenti del Tramater sono le seguenti:
LIRIOPE. (Bot.) Li-rì-o-pe. Sm. V[oce] G[reca] Lat. liriope (Da lirion, giglio e ops vista.) Genere di piante esotiche, da Jacquin stabilito nell’esandria monoginia e nella famiglia delle sarmentacee; così da Loureiro denominate a cagione della loro somiglianza col giglio. Riportato sotto il genere ophiopogon, dove costituisce la specie detta ophiopogon spicatus. (Aq [= Aquilino, Dizionario etimologico di tutti i vocaboli usati nelle scienze, arti e mestieri che traggono origine dal Greco compilato da Bonavilla Aquilino, Milano, Pirola, 1819-21; ecc.]) (N [= Voce o accezione nuova rispetto alla Crusca]).
2 – (Bot.) Da Herbert si propone un altro genere sotto lo stesso nome e che è una specie di Pancrazio detto Ringente per la forma delle lacinie della corolla. (N)
LIRIOPE. N. pr. f Lat. Liriope. (Dal celt. llyr Oceano, ed ap figlio: Figlia dell’Oceano.) – Una delle figliuole dell’Oceano, madre di Narciso. (B [= Bologna, Gran Dizionario della lingua italiana, Bologna, 1819-26]) (Mit [ = termine mitologico]).
Il punto di partenza della invenzione lessicale gaddiana è dunque una Liriope liliale: madre ad un Narciso di purezza degna del Santo dei gigli (si ricordi la invocata protezione di San Luigi in AG RR II 654-55). Ora, l’insorgenza del liriopesco, che altera radicalmente l’originario segno di candore, è gradualmente preparata nelle linee successive. Seguiamo da vicino il procedimento. Viene, da prima, una compattazione in sostantivo composto – «ligustri-rose» – di uno stereotipo descrittivo vulgato (ma che per Gadda è soprattutto ariostesco): (20) un accordo di fiori e colori – «bianchi e vermigli» direbbe il Carducci – a rendere le rosee trasparenze di una pelle candida (paradigma, si sa, di bellezza):
Nel primo essor dei quattordici, nel pieno éclat de’ suoi ligustri-rose (a noler citare garofani) con quella prima lanugine come di pesca d’agosto che gl’indorava l’indorabile, il Narcisso era amato e affocatamente era desiderato ecc.
Ad espandere l’immagine interviene quindi la lanugine delle gote (condotta ad evocarne altre: si badi all’indorabile) ed il conseguente paragone con l’incarnato di una pesca. Frutto desiderabilissimo, Narciso il liliale, il «non tocco», è convoité, secondo l’avverbio anteposto, con rosso, infuocato desiderio: «affocatamente». Il colore della passione s’accende poi ancora poche righe sotto nella resa di Orazio, Carm. IV, 10: «quel colorito che emula ora la rosa e la porpora, […] le rosee gote» (e più oltre: «i capelli d’oro e’ son degni di Bacco o di Apolline, e le guance d’impubere ove non anco è piuma né calugo. (21) Ligustri-rose a strafottere, l’Ovidio: per il collo, manco a dirlo, è mobilitato l’avorio»).
Per Narciso, il candido e il roseo, fiore puro e desiderabile frutto, è ormai maturo il qualificativo liriopesco:
Del crudel quattordicenne liriopesco ce ne fa storia e direi testimonianza l’Ovidio, in un suo poema buonissimo ecc., (SGF I 645)
un matronimico (figlio di Liriope – ma si noterà che in questa funzione il suffisso -esc- in italiano moderno non è più produttivo) (22) che assomma i due valori e i due campi associativi dei termini in cui come nome composto – lirio-pesco – è rianalizzato. Si prepara, tuttavia, una ultima e più sorprendente immissione di significato nel composto, che scompagina l’equilibrio oppositivo tra purezza e passione, tra ripulsa e desiderio. Il fiore giovinetto (23) del narciso – così l’ipotesi finale – è l’impubere dotato del «sottil veneno di bellezza», dotato anzi in una potenza prossima a mutarsi in atto – di «facultà operativa»: «giglio e bocciuol di rosa del diavolo» «non ancor levatosi a brùzzico» (SGF I 650). Così, dunque, la parola si carica di nuovi significati attraverso risonanze multiple con il suo contesto. Liriopesco è parola fattasi, come si asseriva sopra, pesante, che significa tutto assieme il figlio di Liriope, e il desiderabile guancia-di-pesca e incarnato di rosa della tradizione poetica, e il candido lirio-giglio di purezza, ma su uno stelo che troppo richiama certo ergersi di gigli dannunziani (24) o mallarmeiani, (25) o il dar di lancia d’un personaggio (un Lanciano) di QP, (26) e che desinit, ad ogni modo, in un «bocciuol di rosa». – «Eh bien, mon cher docteur», come diceva Jarry, «j’ai des doutes sur la pureté des lis…». (27)
Una parte importante della innovazione gaddiana, quella di carattere non lessicale o sintattico, si affida a procedimenti analogici di progressione fondati sulla consonanza dei significanti, i quali interagiscono con nuclei semantici privilegiati. L’itinerario del commendator Angeloni di QP nel corso della quotidiana passeggiata solitaria è tracciato nella toponomastica stradale romana – che pure rimane a vincolare con la sua referenzialità le escursioni fantastiche – in maniera tale da creare un gioco linguistico di suoni e di significati (se poi quelle associazioni fonico-semantiche non sono esse stesse alla origine dell’itinerario prescelto). Il «topazio» di un sogno sempre di QP – un sogno in zeta (28) – acquista l’imprevedibile mobilità e l’impudica tendenza insinuativa del topazzio-topazzo-topaccio che pronuncia romana e metaplasmi retorici così agevolmente associano (29) alle qualità del suo referente: un topazio = fanale-ruota-girasole-disco ecc. dunque, ma anche un topazio = topo-pazzo en quête della trappola per antonomasia:
uno strano essere: un pazzo, un topazzo […] che cos’è, infine, un topazio? un vetro sfaccettato, una specie di fanale giallo giallo, che ingrossava, ingrandiva d’attimo in attimo fino ad essere poi subito un girasole, un disco maligno che gli sfuggiva rotolando innanzi e pressoché al disotto della ruota della macchina, per muta magia […] non erano buoni a raggiungerlo su nessuna strada o stradazia, il topazio maledetto, il giallazio. Tantoché al passaggio a livello di Casal Bruciato il vetrone girasole… per fil a dest! E’ s’era involato lungo le rotaie cangiando sua figura in topaccio e ridarellava topo-topo-topo-topo ecc. (RR II 192)
Sotto la trama razionale dei significati corrono così dentro la lingua le ramificazioni dei significanti, che conducono ad abbandonarcisi, e comunque nel sogno, là dove non si sarebbe dovuto.
2.4. «Ragnatelo di riferimenti infiniti». (30) Si è dunque osservata nella prosa di Gadda una tendenza – giustificata e quindi potenziata dalle concezioni di poetica dell’autore – alla esplosione associativa. Certo, Gadda non è scrittore di erudizione divagante e pedantesca al modo, poniamo, di uno Stoppani o di un Verne (per il secondo la scienza che sovraccarica certi romanzi consiste essenzialmente nell’elencare, quantificare ed esemplificare). La sua, di Gadda, è piuttosto una compatta, folgorante, evocazione per lievi tocchi (valga per tutti l’esempio di QP RR II 231: «Una croce di granati, momenti rosso cupi dell’ombra domestica»). Ma l’effetto di un iterato – anche se microscopico – processo associativo non può essere altro che una violenta spinta centrifuga, verso un éclatement del testo-monade, che si manifesta in molti àmbiti, e che si cautela per compenso di opportuni correttivi, a partire dai minimi della sintassi dell’elenco e del parallelismo. La gaddiana risulta così una scrittura in equilibrio dinamico tra forze contrastanti: forze accentratrici e organizzatrici da una parte, e dall’altra forze disgregatrici; ad esempio tra la tendenza alle digressioni e contemporaneamente il loro riassorbimento, la loro pertinentizzazione per la linea principale della rappresentazione.
In Gadda, insomma, il testo singolo si rifiuta alla usuale chiusura. Questo in vari modi:
i) il testo, in primo luogo, viene ad intrattenere legami con tutti gli altri testi dell’autore (ritornano temi, formulazioni, situazioni, allusioni, e sono frequenti le citazioni interne);
ii) esso, inoltre, è suscettibile di riscrittura all’infinito, ogni riscrittura essendo espansiva, scoprendo cioè ulteriori dettagli e legami dell’oggetto;
iii) non è concluso, o rifugge da una conclusione troppo esplicita. È il non finito gaddiano che proviene dal rifiuto della banalità o dell’artificialità degli usuali scioglimenti romanzeschi e, soprattutto, dall’impossibilità di principio di considerare una situazione complessa come narrativamente conosciuta, dominata e congedata. L’esser di secondo grado – racconto nel racconto – è un mezzo per diminuire la resistenza alla completezza (si pensi al racconto del medico nella Cognizione);
iv) il testo conosce un prolungamento nelle note, che possono raggiungere estensione notevolissima. Le note provvedono cioè il testo di quel contrappunto necessario che tuttavia esso non potrebbe direttamente accogliere in sé senza sollecitare troppo le strutture portanti su cui si regge. La riduzione delle note che si constata in alcuni casi (ad es. nel passaggio dalla edizione in rivista del Pasticciaccio alla edizione in volume) è una inversione di tendenza solo momentanea, dettata da considerazioni extraletterarie (ad esempio, editoriali);
v) ancora, nel testo, l’entità singola (episodio, personaggio, azione, oggetto) viene tendenzialmente vista sullo sfondo della classe a cui appartiene, il che permette di arricchire la presentazione del singolo di tutti i tratti differenziali rispetto agli altri elementi della sua classe. Ciò si applica narrativamente in particolare alla presentazione di episodi come singolari o plurimi, puntuali o abitudinari. Un esempio caratteristico è dato dalle pagine iniziali del quinto tratto della Cognizione, in cui il vagare della madre del protagonista è ad un tempo puntuale e abitudinario, con raffinati effetti di sovrapposizione dei due valori;
vi) nel singolo testo, infine, si tende a far risuonare le armoniche storiche, o culturali, della narrazione, a collocarla entro un complesso quadro di riferimento. Persino nella Cognizione, dove la componente autobiografica sembrerebbe dover favorire il particulare, la vicenda privata del rapporto con la madre è vista come exemplum del male che pensato si fa realtà, sullo sfondo politico di un paese e di una situazione generale di vita in cui la libertà individuale non esiste, e il tentativo di sfuggire alle imposizioni viene ferocemente seppure occultamente represso. Questa componente storica e sociale ed etica fa di Gadda uno scrittore malgrado tutto manzoniano, di un manzonismo senza dubbio selettivo ma reale. Nella Apologia (SGF I 679-87), Gadda enfatizza dei Promessi Sposi i tratti che sono congeniali alla sua poetica: ad esempio, la «contaminazione grottesca» che consegue alla «mescolanza degli apporti storici e teoretici più disparati» (SGF I 679), e la ruvida inserzione dell’idillio nel tempestoso contesto sociale:
Ma ci sono cavalli e fanti nel mondo, istinti profondi di dominazione e di lotta, estreme difese delle sorgenti individualità etniche, deliberate offese, ed altro volere ed altre forze ed altri sogni ed altre follie, che non la chiusa saggezza e la mite onestà della casetta e del campicello. (SGF I 684)
Una interessante conseguenza di questa concezione aperta del testo è da vedere nella autonomia che possono assumere singoli episodi e parti. Accade così che venga a cadere il connettivo tra i capitoli (come ad esempio in CdD e in QP), o che singole sezioni vengano spostate e riutilizzate, quasi tessere di un puzzle, da opera a opera: si pensi alla sinfonia di RI anteposta ad L’A, ed ai frammenti – a volte nemmeno capitoli – di CdD integrati ad L’A ed a AG. Ma anche la genesi della singola opera può farsi per parti autonome, per studi successivi su singoli particolari, sottoponendo ad esempio un paragrafo ad elaborazioni che lo rendono disomogeneo al suo contesto: tanto da non poter più figurare come tale nella redazione definitiva (un caso di questa singolare tecnica compositiva sarà studiato in § 3.1).
3. Lirismo e comicità
3.1. Il pathos gaddiano. La vis combinatoria (31) che nel mondo del nostro autore agita senza posa gli esseri, le cose e le parole non è incompatibile a priori con un atteggiamento di osservazione distaccata. Ma lo sguardo di Gadda sul mar dei Sargassi della vita è tutt’altro che obbiettivamente descrittivo. Se nella pagina possono occorrere l’irrisione, l’acredine, la condanna inappellabile, sottostante si indovina, malgrado l’intensificarsi negli anni della misantropia, un forte senso sacrale della vita, del dolorare e gioire degli individui, del male sempre in agguato, dell’incalzare delle singole vite e delle generazioni verso la notte onniavvolgente. (32) Princìpi inesorabili reggono il comportamento degli esseri, e la cognizione dello scrittore li riconosce anche negli eventi più insignificanti. Accade così che una apparente digressione su argomenti collaterali sia fulmineamente riassorbita dalla formulazione di una legge generale, che risolve il caso particolare nell’universalmente valido, e contemporaneamente lo spiega. In CdD, un gatto viene ripetutamente precipitato da un secondo piano di villa per verificare, ridotto a indifferente strumento di sperimentazione, una legge di meccanica razionale. Il gatto ne viene a morire, «con occhi velati d’una irrevocabile tristezza, immalinconito da quell’oltraggio». E immediatamente, col legame esplicativo di un poiché, la sua morte è ricondotta ad una legge:
… immalinconito da quell’oltraggio. Poiché ogni oltraggio è morte. (Gadda 1987a: 79; mio il corsivo)
Questa equazione dell’oltraggio-morte, che presiede dunque alla psiche e alla biologia degli esseri, vale, nella Cognizione, non solo certo del gatto anonimo per cui è obliquamente formulata (l’obliquità è notevole e ricorrente soluzione tecnica, che permette di ovviare alla sentenziosità enfatica), ma del patire e morire di un personaggio centrale, la madre, così come della vita umiliata del figlio Gonzalo.
Le volte che il sentimento sacrale del destino umano giunge a manifestarsi direttamente sulla pagina, esso si veste dei toni della partecipazione commossa e del lirismo alto. Due esempi, di questo. Nel primo si contrappongono, a proposito di un personaggio minore, un lucidatore di parquets a cui sono riservate poche pagine, presente e passato, decadenza fisica e pienezza vitale, intensità di passioni e rassegnazione. Il secondo traccia nella sintassi franta del patetico, di volute oscurità e concisione, la vicenda delle generazioni: il loro seguirsi e procedere sorrette da magnanime illusioni sino ad un approdo «incredibile»:
Lo sguardo de’ grigi e dolci occhi, velati d’una sorta di lacrima, e i gran baffi ambrati pioventi sulla rassegnata pace dei settantadue, dicevano la pietà del rammemorare, e dell’accettare il destino. […] il torace, amplissimo e generoso, ed ecco già in via di smagrire e di rattrappirsi a una povera gabbia: dove per poco ancora la diàstole avrebbe dato segno di sé, come un soffio.
Quando viceversa in un battito violento, pieno, aveva sussultato di certi occhi, lontani anni! (L’A RR I 316-17)Oh!, lungo il cammino delle generazioni, la luce!…. che recede, recede…. opaca…. dell’immutato divenire. Ma nei giorni, nelle anime, quale elaborante speranza!…. e l’astratta fede, la pertinace carità. Ogni prassi è un’immagine, zendado, impresa, nel vento bandiera…. La luce, la luce recedeva e l’impresa chiamava avanti, avanti, i suoi quartati: a voler raggiungere il fuggitivo occidente…. E dolorava il respiro delle generazioni, de semine in semen, di arme in arme. Fino allo incredibile approdo. (Gadda 1987a: 97-98) (33)
Tra le illusioni che «incuorano al tragitto» (l’espressione è del Gadda degli ultimi anni) vi sono di certo la bellezza e l’amore. E i personaggi minori di Gadda, provvisti tutti di una risentita fisicità, raccolgono il «senso vitale della favola» (Gadda 1987a: 283) per affidare ad altri, dopo di loro, «lo spirito, o il sangue» (ancora a p. 283). «Crescessero, amassero», augura nella Cognizione la madre di Gonzalo alla «prole rustica». Ma i personaggi maggiori, che godono del privilegio di percepire e sentire in una coll’autore – questi personaggi non amano, non posseggono: desiderano, semmai, e soprattutto guardano, osservano. Guarda turbato il commissario Ingravallo nel Pasticciaccio. Guarda incapace anche di desiderio Elsa nell’Adalgisa. Guarda, l’autore-spettatore di Eros e Priapo, la scena agreste delle finte trebbiatrici della battaglia del grano:
E i tepidi, i divini seni ripresi e, ahimé, ristretti da lo scialle che ne vietava il trabocco: e gli occhî dolcemente ridenti […] E lievi gonne che uno spiro solleva, come un desiderio maritimo, venuto dalle astinenze, dalle diuturne penitenze navali, approdato quasi un contrabbandiere a le febbri, al convegno sotto la Cisterna, per la Pratica di Mare. Lievi gonne, tra il polverone delle trebbie, di mussola stampata. Sopra, gambe da non si poter dire, da non si poterle guatare: lasciamo, lasciamo. Compermesso. Compermèss che me ven fastidi. (EP SGF II 267)
La distanza, la separazione inerente al guardare e l’impossibilità psicologica del fruire generano, secondo la equiparazione gaddiana del «disperato lirismo» a un «Vorrei e non posso» (SGF I 647), una intensificazione emotiva e anzi schiettamente erotica che è rara nella letteratura italiana del Novecento. Nel passo appena citato la satira declina in un turbamento che per esprimersi in registro basso non è molto dissimile dall’offuscarsi amoroso dei sensi negli autori della classicità. E nel passo che segue (dove a guardare sono per una volta individualità non caratterizzate: carabinieri ai cui desideri obsta la Legge che impersonano) sguardo e desiderio si muovono in itinerario avventuroso (che sembra ricalcare quello genetico) verso l’ineffabile e l’irraggiungibile:
[ragazze di campagna in cerchio a cucire] A capo chino, però lo levavan ratte, a quando a quando, una dopo l’altra, dopo la prossima: a ricacciare indietro con la mano, come noiate, il viluppo de’ ricadenti capelli. Ma in quell’attimo! davano un lampo, gli occhi: neri, lucidi, emersi dal tedio […]. Un odorino de donne de campagna in sottane corte […]. Lo sguardo affondava nella penombra, poi nell’ombre: s’insinuava, s’inerpicava tra le gole della speranza ecc. (QP RR II 152)
Ad una simile concezione, sacrale come si è detto, della vita è in certo modo legata la scelta dei temi e dei personaggi. I personaggi principali, dai forti tratti autobiografici, sono spesso figure di esseri doloranti, in maggiore o minore misura, dentro un contesto di quotidianità, di costrizioni o di convenzioni a cui si sentono estranei; figure, a volte, di un vano desiderare, di quel «disperato lirismo» che si è menzionato sopra. Di quest’ultimo genere sono la Liliana del Pasticciaccio e la lunare Elsa dell’Adalgisa. Nasce così spesso una contrapposizione strutturante tra un mondo di idealità, di nobili sentimenti, di atti misurati e dignitosi, e dall’altra parte il mondo reale, pieno di vita e disordine, di forze istintuali, incontrollate: tra i mondi – per usare categorie shakespeariane – di Prospero e di Calibano. Il contrasto a volte viene messo in scena oltre che psicologicamente anche spazialmente: si pensi in CdD alla discesa del protagonista dalle letture elette della sua camera alla realtà bassa del pianterreno, dove si affollano elencatoriamente le manifestazioni repellenti (per Gonzalo) del mondo com’è:
Il sole e le luci declinavano verso la loro dolcezza, allorché il figlio discese dal Simposio, o forse dalle Leggi, e senza prevedere, aprì la porta di sala. Vi vide la mamma, con gli occhî arrossati dalle lacrime, tener crocchio: all’impiedi: e intorno, come una congiura che tenga finalmente la sua vittima, Peppa, Beppina, Poronga, polli, peone, la vecchia emiplegica del venerdì, la moglie nana e ingobbita dell’affossamorti, nera come una blatta, e il gatto, e la gatta tirati dal fiuto del pesce: ma fissavano il cagnolino del Poronga, lercio, che ora tremava e dava segni, il vile, d’aver paura dei due gatti, dopo aver annusato a lungo e libidinoso le scarpe di tutti e anche pisciato sotto la tavola. Ma il filo della piscia aveva poi progredito per suo conto verso il camino. E sul piatto il pesce morto, fetente (Gadda 1987a: 411; cfr. anche p. 386: «Gli sfrullò di capo anche un’altra molestia, che gli s’era fermata nel magazzino, nel retrobottega del cervello. Ma quale? ah! quale?…. mah! se stava leggendo il Parmenide? ah! già, che la Peppa seminava pulci per casa, raccoltele in cima di classifica al lavatoio “municipale”»).
E vi sono poi innumerevoli figure di pedoni, di umili comparse della vita, coinvolte o sfiorate loro malgrado dalle repentine manifestazioni del male; oppure fedeli ad un loro còmpito limitato ed all’illimitato sacrificio di sé che esso comporta. Certo tutto questo si nutre, è necessario osservare, di una visione fortemente gerarchica dei rapporti sociali. Vi è nel mondo il contemplatore, il lettore di Platone e dei Vangeli, e vi è chi presta mano alle basse opere, come vi è l’ex-lege. Ma, con le parole di un madrigale monteverdiano: «tutti al suo posto». La comprensione dei meccanismi sociali è in Gadda, per quanto lettore ed estimatore di Pareto, praticamente nulla. Agisce in suo luogo il risentimento dell’escluso, il timore del privilegiato; o, peggio, la comprensione-compassione della borghesia illuminata: le mondine, in uno sconcertante scritto di Verso la Certosa, sono, dopo la giornata di lavoro, «stanche […] ma non esauste» (SGF I 341), i «loro piedi larghi, dai diti aperti» paiono «ignorare la calzatura» (SGF I 342), nei capelli, «talora biondastri», un «bruscolo» o «fili d’erba» sono «segno della terra da cui venivano, su cui campavano» (SGF I 341). Gerarchia e anarchia, in Gadda, in un miscuglio inestricabile.
3.2. Gioco, irrisione, negazione. Il comico occupava nella scrittura gaddiana degli inizi una parte importante, tanto da giustificare, almeno in parte, l’etichetta critica di umorista con cui si era voluto catalogare – riduttivamente (come a dire: un Panzini solo più risentito linguisticamente) – le prime prove dell’autore. Si trattava a volte di un comico ingenuo, involontariamente di maniera, a volte decisamente goffo. Teatro, un racconto di MdF, si basa in toto sulla finzione non proprio peregrina dell’ingénu spettatore di una rappresentazione lirica, con le incomprensioni e le descrizioni estranianti che ciò comporta. Più in piccolo, un esempio caratteristico è l’inizio di Cinema, in MdF (RR I 51):
Bisognava concludere. Manifestai alla contessina Delrio ciò che sentivo di non poterle dissimulare più a lungo. Si rassegnasse all’idea: le diagonali del parallelogrammo si secano nel loro punto mediano. E non è tutto: esse ne dividono l’area in quattro triangoli equivalenti.
Ma il comico nel séguito muta progressivamente di carattere. Dalla più vulgata accezione di un comico-gioco applicato alla lingua ed alla realtà rappresentata, prende consistenza un comico che pare prossimo al grottesco della accezione bachtiniana (il riferimento è allo studio su Rabelais): un atteggiamento che «affranca da tutte le forme di necessità inumana che aderiscono alle idee dominanti sul mondo» (cito da Bachtin), che intacca l’«aspetto serio, incondizionale, perentorio» del dover essere sociale. Che carnevalizza il reale, aprendogli possibilità alternative di licenza liberatoria. Questo comico-grottesco sembra nascere in Gadda dalla voce profonda dell’umanità, da una verità anteriore alle convenzioni sociali, combinandosi così con l’evocazione di un illusorio stato incorrotto: un mondo di grandi alberi, di campagna sapientemente mensurata, di lavoro strenuo, di silenzio, di sentimenti profondi e ordinati. Il comico gaddiano ritrova insomma la stessa matrice dell’antica, spontanea, irreprimibile voce popolare che irride, che «sfronda menzogna» (QP RR II 120), che denega le «figurazioni non valide» della natura, degli individui e della società. Si legga:
Non si può reprimere l’antico fescennio, sbandire dalla vecchia terra la favola, la sua perenne atellana: quando vapora su su, lieto e turpe, il riso, dalle genti e dall’anima. (QP RR II 120) (34)
Ma il comico, in Gadda, tende sempre più a divenire una reazione difensiva o vendicativa, anche se gabellata per terapeutica, quasi la «diritta scesa del pennato (35) [che] consacra al frutto l’ulivo, e ne sfronda menzogna» (RR II 120). (36) Il caricaturare le parvenze difformi, barocche della vita, «attuffarla nella rancura e nello spregio come in una pozza di scrementi» (Gadda 1987a: 354), è l’estrema risorsa di chi si senta respinto dalla vita, o incapace di vivere. Molta della scrittura gaddiana degli ultimi anni può essere letta come guerra d’un solo contro tutti, di un ferito dalla vita contro ogni manifestazione della vita.
Si comprende allora che di frequente il comico sia fondato sulla miseria della persona umana: comportamenti, abbigliamenti, malattie, deformità, odori, deiezioni. Per quanto racchiusa e sublimata dal cristallo dello stile (si pensi all’«onta estrusa dall’Adamo, (37) l’arrotolata turpitudine» di Gadda 1987a: 381), la realtà più ripugnante occupa a volte con violenza il centro della scena, tradendo nella rappresentazione della «turpitudine dei segni» (Gadda 1987a: 406) attrazione e quasi compiacimento scatologico (38) che i cultori di interpretazioni freudiane hanno abbondantemente commentato: dal grado minimo di Gadda 1987a: 566: «non si capiva, quell’afrore, se fosse lui o il formaggio», a quello più elevato di QP RR II 219:
nel frattempo, senza darlo a divedere tuttavia, si sforzava jugular l’evento […]: con raccomandarsi […] ai buoni uffici (nel trascorso di lei tempo automatici) del plesso emorroidale medio, plexus haemorroidalis medii. Pervenne (39) infatti alla deliberata strizione dei più quotati anelli rettali ecc.
o dell’Incendio (RR II 712): «allentati, nel contempo, i più valorosi anelli inibitivi dello sfinctere anale […], nello spavento e nella congestione improvvisa», dove l’esito, che risparmiamo ai lettori, è lo stesso di un passo del Quart livre rabelaisiano (a cui i luoghi gaddiani fanno collettivamente allusione, redimendosi cioè per via di intertestualità): «La vertus retentrice du nerf qui restrainct le muscle nommé sphincter […] estoit dissolue par la vehemence de paour qu’il avoit eu en ses phantasticques visions».
4. L’atelier dello scrittore
4.1. «Nuvole rotonde e bianche»: l’elaborazione di una immagine
Como às vezes num dia azul e manso
No vivo verde da planície calma
Duma súbita nuvem o avanço
Pàlidamente as ervas escurece
(F. Pessoa)
Cercheremo ora di esaminare, se pure per sommi capi, il prender forma in immagine di un tipico spunto tematico (40) gaddiano: quello del cumularsi delle nubi, presente, con determinazioni diverse e valori divergenti (ora equiparato simbolicamente all’insorgere delle forze del male, ora corrispettivo del fluire eracliteo delle cose) in tutta l’opera del nostro autore. Esso serve ad esempio da preludio ad una delle prime opere d’ampio respiro, la Meditazione milanese (più esattamente, alla sua «seconda stesura»): «Quando le nuvole sorgono, come sogni, dai monti e dalle foreste», recuperando quasi alla lettera l’incipit di una poesia giovanile di assonanza dannunziana: (41) «Poi che le nuvole sorgono, | come sogni, dai monti | e dalle foreste, | ecc.». (42)
L’occorrenza di cui vogliamo occuparci è interna ad una redazione anteriore della seconda parte della Cognizione. Si tratta, per situare l’apparizione del nostro tema, della descrizione di un pomeriggio estivo, o tardo-estivo, sul terrazzo e nel giardino di una villa nel fondo della campagna. Ecco la premessa:
L’ora panica soleva arroventare il terrazzo, su cui molt’anni prima s’era messo, un giorno‹,› un mucchietto color fondo di caffé, sgrovigliatosi poi nella molle terribilità d’una vipera. E lo traversava la carovaniera interminabile delle formiche, quasi un prurito: dell’Ogaden e talvolta vi si riscontrava la macchia picea, berniniana, dello scorpione: uscito dalla tenebra a configurarsi come una pianta di cattedrale in ambasciatore di tenebra. Piatta, nera esedra con serbatoio di venefici. E dopo i viticci e l’edera in gran fruscio vi folgorava il ramarro, come un démone-attimo che da quella focaia fosse stato disprigionato nel meriggio.
La descrizione dell’«ora panica», limitata nel paragrafo appena letto al microspazio del terrazzo, viene allargata col capoverso che segue alla campagna senza confini: da essa, immanente ad essa, suona un singhiozzo: il canto del cuculo. Tale immagine sonora composita (impressione + identificazione (il cuculo)), a cui daremo il nome di tema I, è per Gadda, memorabile, tanto da ricomparire isolata come favola-aforisma in PLF. (43) Di essa è costitutiva, qui come in molte sue altre occorrenze, la regolarità, l’essere cioè il tempo scandito in alternarsi di suono (pateticamente: singhiozzo) e di silenzi. È proprio questa regolarità ritmica che permetterà poi l’associazione ad un altra serie di eventi regolari (il passaggio intermittente delle nuvole sulla campagna), e la sincronizzazione delle due serie. Il tema I nasce così:
(a: tema I) (44)
Nella solitudine ‹della campagna›, a lunghi intervalli, il un singhiozzo disperato ritenuto: il cuculo.
Il capoverso viene riscritto immediatamente sotto due altre volte, integrando ogni volta parte delle varianti della fase precedente. Nella seconda e terza riscrittura è degno di nota che il canto del cuculo diventi voce, pianto anzi, della campagna, fattasi soggetto simbolicamente animato da passiva localizzazione che era (cfr. (a): «Nella solitudine della campagna»); che, in (b), scompaia l’identificazione singhiozzo = cuculo, e che, inoltre, l’avverbio allora tenti un aggancio esplicito, poi abbandonato, all’inizio del paragrafo precedente («L’ora panica soleva arroventare il terrazzo»):
(b: tema I)
‹Allora› la [da La] solitudine della campagna, con intervalli disperati, dava e riteneva il suo remoto singhiozzo. Il cucù →, come [due parole illeggibili] della
(c: tema I)
Allora L’‹assolata od oscurata› [L’ è ricalcato su La] solitudine della campagna e del monte, con ◊lunghi → disperati intervalli → intervalli disperati con disperati intervalli, dav → esala dava ‹e riteneva› un il suo singhiozzo ◊ritenuto → lontano → remoto remoto singhiozzo. Il cucù [ricavato da cucùlo].
L’insorgere del tema, che diremo II, delle nuvole trascorrenti – una immagine paesaggistica padana (45) – ha luogo dopo la terza riscrittura (nel manoscritto esso è in realtà confinato per ragioni di spazio tra la seconda e la terza). In accordo col carattere rapsodico della prosa lirica gaddiana, il tema nasce sotto l’influsso di diversi attivatori. Valgono da attivatori, direi, in primo luogo la regolarità ritmica, cioè l’alternanza che si è vista caratteristica del tema I. In secondo luogo la componente di progressività che è presente, entro il frammento di contesto anteriore, nella immagine della riga in progress delle formiche: «E lo [= il terrazzo] traversava la carovaniera interminabile delle formiche, quasi un prurito: dell’Ogaden», e che è ricorrente in Gadda: si pensi alla favola 172 di PLF, per cui il curatore parla di topos della carovana: «Andava, la paziente carovana, lungo l’infinito sentiere. | Questa favola è detta de’ cammelli, de li arabi, de’ muli, delli alpini, delle inestinte formicole». Del resto nella redazione finale della Cognizione (cfr. più avanti) la metafora della carovana viene espressamente applicata – oltre che alle formiche (Gadda 1987a: 207: «I bianchi muri avrebbero seguitato a cuocere nella loro inanità calda, carovane di formiche li percorrevano: nere, minime briciole del moto e dell’essere»; p. 420: «Il terrazzo […] era asciutto e caldo, carovanato da quel prurito interminabile delle formiche»; e p. 433: «le formiche traversavano pazienti l’Ogaden, carovane eroiche….») – proprio al procedere delle nuvole: p. 420 (a contatto del periodo citato appena sopra): «Nubi […] avanzavano, carovane pazienti: come le generazioni degli umani verso il futuro». Gioverà ricordare, oltretutto, che nella memoria poetica dell’autore nuvole e carovane erano associate grazie ad un sonetto di Giacomo Zanella, Nubi, vv. 9-10: «Come il deserto fan le carovane, | Voi l’aria attraversate a tòrma a tòrma», che si chiude, esso pure, sulla comparazione con le generazioni: vv. 12-14 «In simil forma | Passan quaggiuso le prosàpie umane | Ed alla vostra egual lasciano un’orma». Il tema I ricompare ora in subordine a II, nel quale è innestato tramite un primo accenno di sincronizzazione (a luce corrispondendo suono e ad ombra silenzio) (46) espresso da «ad ogni ombra». Il risultato è il seguente:
(d: temi II + I)
Nuvole rotonde e bianche vaporavano dalle montagne, adombrando i campi ‹al passare› come vele fuggitive. Il cuculo dava ad ogni ombra le sue note scandite.
Prende inizio ora, in conseguenza o in parallelo al rifacimento della pagina in cui erano nate, un nuovo processo elaborativo dei due temi I e II ormai congiunti. Indicheremo con A-F le fasi relative. Il tema II si riaggrega, nella riscrittura (A) e in tutte le seguenti (solo in (D) compare il poco felice tentativo di variante alternativa «globearsi»), attorno a quel germe di cristallizzazione che è il lessema «morularsi», già presente (ma a proposito di «nuvoli d’incenso») in CdU RR I 168 con una ampia glossa (p. 177) a testimoniare la memorabilità, per l’autore, dell’acquisizione concettuale e lessicale relativa. (47) Il tema II compare da prima isolato, crescendo di una proposizione finale rispetto alla sua esecuzione in (d):
(A: tema II)
Nuvole rotonde e bianche si morulavano dalle montagne ‹per traversare traghettare l’estate›, adombravano i campi al passare, come vele in lente vele il marezzo.
E quindi, nelle prove successive, combinato col tema I del canto del cuculo. Questo, però, non per semplice aggiunzione di I a II, come già era stato fatto in (d), e come si stava iniziando a fare (si veda la variante cancellata di (B) qui sotto: «Il cuculo dava ad ogni ombra», che riprende letteralmente (d)). Quanto, piuttosto, espandendo ed isolando da I, trattato come complesso tematico, o, se si vuole, spunto tematico, dei temi parziali I′ e I″ che in potenza esso già conteneva, e introducendo un tema (che noteremo K) di collegamento, di transizione logica tra II e le determinazioni di I. Il tema di collegamento è quello del ristare del tempo ad ogni ombra. K si lega a II, in (B), mediante la derivatio «adombravano»/«ombra». I′, il tema del cuculo che dà «le sue note scandite», segue immediatamente K, legato ad esso dalla ripresa sinonimica «interruzione, sospensione»/«pausa». Compare quindi, in capoverso indipendente, il tema I″ della campagna che singhiozza, già sostanzialmente dominante nelle fasi (a), (c) e soprattutto (b) viste sopra, in cui il cuculo era menzionato solo alla fine, come interpretazione oggettiva dell’immagine impressionista del «remoto singhiozzo» della campagna. Ma leggiamo (B), che riporteremo una prima volta con le sue varianti instaurative, ed una seconda volta nella veste finale (tranne per una variante, che accenna un tema), con interventi a isolare i successivi temi e gli elementi di legame:
(B: temi II, K, I′ e I″)
Nuvole rotonde e bianche si morulavano dalle montagne per tra attraversare l’estate, adombravano i campi, al passare, come lente vele il marezzo. Il cuculo dava ad ogni ombra Il flusso del tempo, ad → ‹nel migrar sotto il migrare d’› ogni ombra, ristava: era una interruzione, una sospensione era → nel mondo → nelle cose → sopra le cose → ‹nel persistere ‹o nel divenire› delle cose›: e in → a quella pausa il cuculo ◊ suggeriva → ‹suggeriva›→ suggeriva ◊ un → il → rimpianto → l’amorosa ◊ dolcezza → tristezza. Come note di silofono scandiv e in quella pausa il cuculo metteva suggeriva al meriggio, come allo spazio puro ‹senza più (parola illeggibile) → motivo cagione›, come venutegli da una dimensione → un mondo metafisica, le poche brevi note del pensiero dolore. Per tal modo la assolata ed oscurata ‹la› solitudine della campagna, con disperati → straziati disperati intervalli, riteneva e dava il suo remoto singhiozzo.
*
[Tema II Nuvole rotonde e bianche si morulavano dalle montagne per attraversare l’estate, adombravano i campi, al passare, come lente vele il marezzo.] [Tema I′, pospostoIl cuculo dava ad ogni ombra] [Tema K Il flusso del tempo, sotto il migrare d’ogni ombra, ristava: una interruzione, una sospensione nel persistere o nel divenire delle cose:] [Tema I′ e in quella pausa il cuculo suggeriva allo spazio senza cagione, venutegli da una metafisica, le brevi note del dolore.]
[Tema I″ Per tal modo assolata ed oscurata la solitudine della campagna, con disperati intervalli, riteneva e dava il remoto singhiozzo.]
Il tema I″ è in questa fase presentato dall’avverbiale «Per tal modo» come una conseguenza, una deduzione razionale da quanto precede, in maniera forse non molto congrua col suo contenuto, e col carattere globalmente simbolista del passo. Questo legame pesantemente logico viene abbandonato (dopo averlo in un primo momento relegato ad una posizione non iniziale) nella fase (C) immediatamente successiva, che consiste nella riscrittura del solo tema I″. Di seguito a (C) diamo anche le fasi ulteriori, di cui le ultime due concernono il solo tema I″:
(C: tema I″)
Oscurata e assolata in tal modo Assolata e oscurata per tal modo nel frantumarsi → vanire frantumarsi del tempo, la solitudine della campagna, con disperati intervalli, riteneva e dava il remoto singhiozzo
(D: temi II, K, I′ e I″)
Nuvole rotonde e bianche si morulavano [var. alternativa: globeavano] ‹e poi spiccavano› dalle montagne per ‹, mollavano gli ormeggi ai crinali, agli spalti, disciolte ad› attraversare l’estate, adombravano i campi frumenti, al passare, come lente vele il marezzo. Sotto il migrare d’ogni ombra il flusso del tempo ristava: una interruzione, una sospensione, nel → [parola illeggibile cancellata]persistere o nel ‹il› divenire delle cose → degli alberi delle foglie: e in quella pausa ignara d’ogni ‹svolgimento e d’ogni› cagione di storico, il cuculo ‹nascosto› suggeriva alla terra ‹alle piante e alla terra›, come venutegli da una imminenza metafisica, le brevi note del dolore.
Assolata e oscurata → ombrata nel frantumarsi ristare del tempo, la ‹lontana› solitudine ‹eterna› della campagna, ‹All[ora]› con disperati intervalli [indicata la anteposizione a «La solitudine… campagna», e con questa la posizione iniziale di frase], riteneva e dava il → quel suo il remoto singhiozzo.
(E: tema I″)
Allora, con disperati intervalli, la La solitudine ‹oscurata ‹‹o a[rdente]›› ‹ardente o scurata› della campagna, assolata ◊e →, → ‹od› ombrata nel frantumarsi ristare ‹delle cose e› del tempo [dell’inciso «nel … tempo» è quindi indicata l’anteposizione al soggetto], con lunghi, lunghi, disperati intervalli, riteneva e dava il ‹suo› remoto singhiozzo.
(F: tema I″)
Nel ristare del tempo e delle immobili cose, ardente o subitamente oscurata, la solitudine della campagna con per disperati intervalli riteneva e dava il remoto singhiozzo.
Non sfuggirà ad una lettura attenta di queste prove il rigoglio di alternative sostanzialmente sinonimiche, e in generale la ridondanza tra i diversi temi. Ma la ripetitività e la insistenza sui dettagli che sconfina nel prezioso e nel manierato (si noti in particolare in (E) la tormentata ricerca dell’ordine delle parole, e in (D) la proliferazione parafrastica: «si morulavano/globeavano e poi spiccavano dalle montagne, mollavano gli ormeggi ai crinali, agli spalti, disciolte ad attraversare l’estate») è tipica degli studi gaddiani, e non passa mai all’opera. Essa è il faticoso aggiustamento che assicura alla pagina a stampa la sicurezza infallibile dello stile. All’opera non giunge che una scelta ristretta di una ampia sperimentazione.
Cosa significa questo, specificamente, per il tema II delle nuvole? Nato sotto l’influsso di più fattori, il tema II era stato tentativamente anteposto al tema I e poi ai temi I′, I″ nella ricerca di una connessione semantica naturale. Nel contempo tutti i temi in gioco venivano sottoposti ad una intensiva expolitio. Il risultato non poteva in nessun modo essere accolto come tale nella redazione definitiva: da una parte per il manierismo sperimentale delle immagini, dall’altra per la scarsa perspicuità dei legami semantici tra i temi componenti, dall’altra ancora per il tasso elevato di ridondanza dell’insieme. Così, nella redazione finale di CdD che qui riportiamo ponendo in evidenza i temi, si assiste ad una ristrutturazione radicale:
La vampa si attenuava. [tema II Nubi transitavano, dalla montagna, in quel cielo, così sereno ed ampio da parere infinito. Valicavano i lontani crinali. Avanzavano, carovane pazienti: come le generazioni degli umani verso il futuro] Il terrazzo, di piastrelle di cemento, consunte e perciò porose, era asciutto e caldo, carovanato da quel prurito interminabile delle formiche. E dal folto, forse, dell’edera, là, là, dove oscillava un corimbo, Puck, forse: o il ramarro-folgore a meditare il suo guizzo. Il figlio si appoggiò, chinandosi, (data l’altezza della persona), al parapetto di legno. E guardava; forse, ascoltava. C’erano, davanti a lui, dal prato, i mandorli, coi diritti rami nel cielo, che il peone aveva ferocemente bacchiato, (nottetempo però), senza più foglie quasi; una drupa bleu, invece, con pruina, porgevano gli arditi polloni de’ susini: le pere butirro, a spalliera, erano più dure di certo del più duro sasso del Serruchón. Ma San Carlo avrebbe rimediato a ogni cosa. Il figlio guardava, guardava, come per sempre. Di certo anche, ascoltava.
[Tema I* Per intervalli sospesi al di là di ogni clàusola, due note venivano dai silenzi, quasi dallo spazio e dal tempo astratti, ritenute e profonde, come la cognizione del dolore: immanenti alla terra, quandoché vi migravano luci ed ombre]. [E, sommesso, venuto gli dalla remota scaturigine della campagna, si cancellava il disperato singhiozzo.] (Gadda 1987a: 420-22)
Il tema II delle nuvole riacquista ora una sua quasi totale indipendenza, distaccato dai rimanenti ed anteposto alla descrizione del terrazzo (l’ora, intanto, non è più la «panica»: la «vampa si attenuava»). Inoltre, scompare da II il momento dinamico del sorgere e morularsi delle nuvole accentuandosi di contro l’elemento di progressività e di continuità: «Nubi transitavano […]. Valicavano i lontani crinali. Avanzavano, carovane pazienti […]». Non più eventi, dunque, ma fluire sempre identico del tempo (e delle nuvole) sulla campagna. La parte dinamica del tema II riaffiora a molte pagine di distanza, entro il diverso tema della incipiente tempesta, e sorprendentemente nella veste povera della sua prima realizzazione linguistica (d):
Il cielo, così vasto sopra il tempo dissolto, si adombrava talora delle sue cupe nuvole; che vaporavano rotonde e bianche dai monti e cumulate e poi annerate ad un tratto parevano minacciare chi è sola nella casa, lontani i figli, terribilmente. (Gadda 1987a: 260)
Il secondo dei due paragrafi accoglie ciò che rimane del complesso K, I′ e I″ di temi, di cui vedremo rapidamente, per concludere, la sorte. Il tema di collegamento K, anzitutto, viene eliminato: e per la distanza nei confronti di I, e per la rinuncia a sincronizzare passaggio delle nuvole e singhiozzo del cuculo (malgrado gli «intervalli sospesi» dell’inizio, la circostanziale «quandoché vi migravano luci ed ombre» è infatti troppo vaga per legare le due serie, e comunque subordinata al qualificativo «imminenti [le note] alla terra»). I temi I′ e I″, o meglio, cadendo ogni distinzione tra di essi, il loro Ur-tema I viene totalmente rielaborato [= tema I*] nel senso ancora di una attenuazione della dinamicità: non più la campagna che ritiene o dà il suo «remoto singhiozzo», non più il cuculo che suggerisce alla terra le «brevi note del dolore». Ma le note («due note») che, divenute soggetto, da sé vengono – il loro rendersi percepibile è cioè designato con un verbo che qui è di processo, e non d’azione – e vengono da una origine prima astratta (i «silenzi») e poi indeterminata (la «remota scaturigine della campagna»). (48) Alla riduzione della dinamicità della rappresentazione si accompagna la riduzione della sua fisicità, dominando incontrastati gli astratti («intervalli», «clàusola», «note», «silenzi», «spazio», «tempo», ecc.). Tutto concorre – l’astrattezza, la sospensione d’ogni azione, il patetico, la citazione del titolo entro la comparazione (49) – a stabilire qui il centro immobile del dramma della Cognizione.
4.2. La rappresentazione della simultaneità e l’opposizione tra puntuale e abitudinario. Ci fermeremo ora, lasciata la genesi della pagina, su un altro aspetto dell’atelier gaddiano: su come venga affrontato in un caso particolare il problema rappresentativo della simultaneità tra eventi; e, con esso, quello della interazione tra abitudinarietà e puntualità (una delle tecniche di non-chiusura testuale di cui si è parlato sopra in § 2.4). Il passo che analizzeremo è tratto dalle prime pagine dell’Incendio di via Keplero (RR II 702-04) e verrà qui (parzialmente) riprodotto, per comodità di analisi, con un certo ammontare di editing:
Una bimba di tre anni, Flora Procopio di Giovan Battista, lasciata sola in casa con un pappagallo, dal seggiolone dove l’avevano issata e imprigionata chiamava disperatamente la mamma senza poterne scendere, e grosse lacrime come disperate perle le gocciavano e rotolavano giù, dopo le gote, per il bavaglino fradicio con su scritto «Buon Appetito», fin dentro la polta papposa d’un suo caffelatte dove a poco a poco ci aveva messo a bagno tutto un bastone di pan francese evidentemente mal cotto più alcuni biscotti di Novara o Saronno che fossero, ma di tre anni loro pure, questo è certo. «Mamma, mamma!» urlava terrorizzata; nel mentre di là dall’altro capo della tavola il variopinto uccello, col suo rostro a naso di duchessa,
i) ch’era solito stimarsi e andare tutto in visibilio e in sollucchero non appena i ragazzi lo apostrofavano di strada «Loreto, Loreto», e anche in superbia,
ii) oppure lo prendeva una specie di malinconia e di letargo senza rimedio,
iii) o invece se lo incitavano «Vuôei, Loreto, canta!… desèdes… canta Viva l’Italia!… Vuôei, baüsciòn d’on Loreto!», (50) allora appena sentire quel «canta» lui rimbeccava con un dolce gorgoglio «Kanta-tì»,
questa volta invece, povera creatura, altro che Kanta-tì! Oh Dio, sì, difatti, per vero dire un certo sentore di bruciaticcio lui lo aveva già percepito, se pur senza troppo inquietarsene: ma quando però vide […], allora prese tutt’a un tratto a squittire anche lui dal fondo del gozzo tutto quello che gli venne in mente, tutto in una volta […].
[segue una digressione di cinque righe sulla carriera domestica del pappagallo] Stavolta però […] aveva perso al tutto la trebisonda: pareva impazzire: «Hiva-i-Ità-ia!, Hiva-i-Ità-ia!», s’era messo a squittire a sguarcigozzo […], mentre la bimba strillava «mamma, mamma!» ed urlava terrorizzata dentro il suo pianto, battendo sulla tavola con l’impugnatura del cucchiarone. Finché un certo Besozzi Achille di anni 33 ecc.
Il paragrafo che esaminiamo è il primo dei tre su cui si estende l’episodio iniziale, uno dei casi (cinque) in cui è decomposto l’evento collettivo (51) dell’incendio di un palazzo della periferia milanese: una bambina, sola in casa con un pappagallo, viene salvata da «certo Besozzi Achille» (le due traiettorie si sono fortuitamente ma provvidenzialmente incrociate). Il nostro paragrafo è costruito da un punto di vista razionale attorno ad una duplice manifestazione di paura che si protrae sino all’intervento risolutore del Besozzi [= «Finché un certo Besozzi Achille ecc.»]: da una parte le grida della «bimba di tre anni, Flora Procopio», dall’altra lo squittire del pappagallo. La bambina
chiamava disperatamente la mamma […]. «Mamma, mamma!» urlava terrorizzata;
il pappagallo
prese tutt’a un tratto a squittire anche lui dal fondo del gozzo […]: «Hiva-i-Ità-ia, Hiva-i-Ità-ia!», s’era messo a squittire a squarciagozz0. (52)
Le due manifestazioni, che nella realtà sono simultanee, o comunque almeno in parte sovrapposte, vengono correlate linguisticamente dal costrutto |p nel mentre q|. Ma quel che accade nel paragrafo è molto più complicato. Anzitutto la descrizione della bambina si espande, dopo l’inizio compatto e dinamico («chiamava disperatamente la mamma»), ad un minuto itinerario delle lagrime: «e grosse lacrime come disperate perle ecc.». Nell’itinerario, una delle manifestazioni della tendenza topografica che pervade il paragrafo, (53) ancorando la scrittura al reale e favorendone la leggibilità stereometrica, le lacrime, divenute in certo modo, in quanto soggetto della predicazione, autonome dalla bambina, transitano per tappe successivamente menzionate (una anticipazione ragionevole del folle itinerario finale dell’autolettiga), con per alcune protratti indugi descrittivi, sino al porto della scodella del caffelatte. Lì esse si congiungono agli ingredienti d’altro genere che le avevano precedute, con un esempio in piccolo della combinatoria universale che conduce a collidere traiettorie di entità eterogenee per generare insospettate manifestazioni di vita. Va da sé che la molta luce sui dettagli non contribuisce a mantenere la tensione drammatica dell’inizio. La tonalità che si stabilisce è piuttosto quella di un divertissement composito. Ad ogni modo, malgrado le lagrime siano anch’esse una manifestazione di angoscia parallela alle grida, il riagganciarsi alla linea principale del discorso risulta ora malagevole. Prima cioè di introdurre lo squittire del pappagallo [= q] come concomitante al disperato chiamare della bambina [= p], le dimensioni dell’itinerario [= p1] frapposto rendono opportuna una ripresa parafrastica di p [= p′]. La ripresa, costituita da «“Mamma, mamma!” urlava terrorizzata», ha la funzione di riattualizzare p, cioè la prima menzione del chiamare disperatamente. Coi simboli proposizionali introdotti, lo schema semplice |p nel mentre q| viene complicato da p1 a |p e p1, nel mentre q| e riequilibrato dalla parafrasi p′ di p nello schema che effettivamente compare sulla pagina: |p e p1; p′ nel mentre q|.
Ma l’interessante viene ora nel trattamento a dir poco peculiare cui è sottoposto q. Il verbo d’azione squittire, attorno al quale q è costruito, occorre in effetti solo al termine di una lunga digressione ritardante (così come ritardante era l’itinerario p1). Essa si sofferma su dei comportamenti abituali (nel passato) del pappagallo: i quali complessivamente si oppongono al suo comportamento attuale. Questo è dunque presentato sullo sfondo di abitudini di genere simile ma di segno opposto:
ch’era solito […], questa volta invece […] altro che Kanta-tì!
Appena sotto, dopo una nuova digressione storica (la giovinezza, «riposata e piena d’idee», del pappagallo), la ripresa è ancora oppositiva:
Stavolta però ecc.
Ora, i comportamenti abituali del pappagallo sono accuratamente disgiunti in una terna (secondo lo schema |r1, oppure r2, o invece r3|): vi è prima la reazione dionisiaca (r1 = «era solito stimarsi e andare tutto in visibilio e in sollucchero»), poi la saturnina (54) (r2 = «lo prendeva una specie di malinconia e di letargo senza rimedio»). Ma il terzo membro r3 consiste sorprendentemente in una variante ed in una specificazione del primo, vanificando così quell’ordine logico che la sintassi sembra postulare (sotto le specie dell’ordine si cela dunque il disordine). Non solo, tuttavia. Se complessivamente q si oppone alla terna dei comportamenti r1, q intrattiene un rapporto particolarmente stretto proprio con l’extravagante r3. Se la richiesta dei ragazzi in strada (di cantare Viva l’Italia) veniva, dal pappagallo, abitualmente respinta col suo Kanta-tì!, «questa volta invece, povera creatura, altro che Kanta-tì!». Il comportamento attuale del pappagallo è cioè proprio quello a cui nel passato egli si rifiutava: nel presente della bestiola, allentatosi il controllo razionale, emerge automaticamente il passato. La digressione, a prima vista gratuita, serve insomma a dar ragione di un altrimenti incomprensibile presente. Ma dopo la lunga digressione disgiuntiva dei comportamenti ri il predicato centrale di q non viene introdotto direttamente. Al suo posto, con una ulteriore applicazione dell’artificio del ritardare il manifestarsi delle azioni (inducendo dunque nei loro rapporti lo spasmo di cui si era parlato), non appare altro che una negazione di r3: «questa volta invece […] altro che Kanta-tì!». Per arrivare all’effettivo r3 bisognerà aspettare ancora per alcune righe che si esaurisca una nuova descrizione dei dettagli dell’incendio:
quando […] vide i petali di quella così sinistra magìa traversargli in diagonale diretta la finestra aperta e poi entrargli in camera ecc. [= s]
Lo stesso, si noterà, si ripete sotto, incrementando una ripetitività di cui il lettore si rende conto in minima misura: «Stavolta però, di fronte a quel volo di tàlleri affocati che parevano vaporar via dalla zecca maledetta di Belzebù, ecc.». In definitiva, se si vuole precisare lo schema di simultaneità introdotto sopra, si avrà lo schema seguente (p′, si ricorderà, vi riformula p) che visualizza (per il momento) l’elaborazione a cui il semplice schema di simultaneità |p nel mentre q| è stato sottoposto:
|p e p1; p′ nel mentre – in luogo di r1 oppure di r2 o invece di r3 – non r3: cioè, in ragione di s, q|.
Se il risultato finale del nostro passo fosse quello che abbiamo appena schematizzato, la rappresentazione della simultaneità ne uscirebbe compromessa in misura notevole. Il peso delle espansioni inserite tra le proposizioni simultanee p e q ridurrebbe la forza di legame di mentre. L’antidoto a cui Gadda ricorre è a dir poco singolare: dopo la digressione sulla carriera del pappagallo, e la riformulazione di q (preceduta da una nuova menzione – quella a cui si è accennato appena sopra – delle sue cause dirette), lo squittire e la paura dell’animale vengono a loro volta circolarmente ricollocate entro le manifestazioni di paura della bambina:
mentre la bimba strillava «mamma, mamma!» ed urlava terrorizzata dentro il suo piatto ecc.
Ridotto ai minimi termini, lo schema temporale adottato è dunque:
|p mentre q mentre p|,
vale a dire uno schema perfettamente circolare che passa tuttavia inosservato in virtù delle dimensioni dei materiali su cui opera. In esso va vista non tanto l’usuale asserzione tramite la lingua della simultaneità quanto piuttosto la sua attuazione linguistica: la sintassi e le stesse strutture semantiche si fanno iconiche dei contenuti che esse veicolano.
4. Edizioni e studi
Ci si limita qui ad alcune indicazioni di lettura, destinate non tanto allo specialista (che potrà consentire o dissentire col giudizio di valore che esse riflettono), quanto a chi voglia cominciare a muoversi – neofita o quasi – nel mondo di Gadda.
4.1. Un primo approccio antologico a Carlo Emilio Gadda è fornito dal volume di 246 pagine curato (e, in particolare, commentato) da Eduardo Melfi: Per leggere C.E. Gadda, Roma: Bonacci, 1986 (Melfi 1986); o, più compattamente dalle 26 pp. esemplarmente annotate entro il volume Lombardia, a cura di A. Stella, C. Repossi e F. Pusteria (Letteratura delle Regioni d’Italia. Storia e Testi), Brescia: La Scuola, 1990.
4.2. Le opere da considerare maggiori – nella misura in cui il qualificativo è applicabile ad una produzione dai confini estremamente fluidi – sono qui sotto indicate in ordine (parzialmente) cronologico, con qualche commento bibliografico o critico:
a) La cognizione del dolore [1a edizione parziale a puntate – tratti – in sette numeri della rivista Letteratura, dal luglio-settembre 1938 (n. 7) al gennaio-marzo 1941 (n. 17); la edizione parziale in volume nei «Supercoralli» Einaudi, 1963], in RR I 565-772. Una edizione in volume singolo, ampiamente commentata (55) e con una appendice di frammenti inediti, è disponibile dal 1987 presso Einaudi nella collezione «Gli Struzzi» (Gadda 1987a).
b) L’Adalgisa. Disegni milanesi, in RR I 283-564. Edizioni in volume singolo da Einaudi (in particolare nella «Nuova Universale», con una breve nota introduttiva di Gianfranco Contini) e da ultimo presso Garzanti, nella collana «Gli Elefanti». L’Adalgisa – uscita in volume originariamente nel 1944 presso Le Monnier di Firenze (e un anno dopo in una seconda edizione diminuita di tre disegni) – raccoglie nove racconti o frammenti di più vasto racconto (e due frammenti della Cognizione) già precedentemente pubblicati in rivista tra il ’38 e il ’43, preceduti da una compatta sinfonia di tono fortemente simbolista recuperata (con varianti) da un giovanile abbozzo di romanzo del ’24 (56) (anche se uscita a stampa nel ’42 in Primato. Lettere e Arti d’Italia 3, no. 12). Converrà fare astrazione nella lettura dai due frammenti della Cognizione (nell’affidare a Le Monnier L’Adalgisa, nel ’43, Gadda non vedeva per la Cognizione possibilità di conclusione e stampa autonoma), così come dal breve e deludente Claudio disimpara a vivere, e dalla troppo lontana sinfonia introduttiva. Rimangono sei disegni (nell’ordine: I: Quando il Girolamo ha smesso….; II: Quattro figlie ebbe e ciascuna regina; III: I ritagli di tempo (il più debole dei sei); IV: Un «concerto» di centoventi professori; V: Al Parco, in una sera di maggio; e VI: L’Adalgisa) che tendono a fondersi in una unica storia, e dànno vita ad alcuni dei più straordinari personaggi di tutta la narrativa gaddiana: il «vecchio Zavattari» lucidatore di parquets, la ragazza Maria dalle «lunghe ore, senza canti […] presso l’acquaio» e dal ferito pudore di montanara, Donna Giulia de’ Marpioni nata Pertegati, trionfante ghigliottinatrice di polli, l’umbratile Elsa, e l’Adalgisa stessa, e il suo «povero Carlo», ragioniere e naturalista.
c) I viaggi la morte, Milano: Garzanti («Saggi»), 1958 e ristampe successive in altra collana; e ora in SGF I 419-667. Nella prima edizione risvolto di copertina di mano dello stesso Gadda (ripreso poi in quarta di copertina nella ristampa dei «Saggi blu» del ’77) in cui è definita la natura delle «24 battute» che costituiscono la raccolta: «Saggi, brevi saggi, è il nome che nelle letterature occidentali si suol conferire a un siffatto genere di lavorucci. Meglio forse varrebbe, per il libro che ci occupa, il francese Entretiens. Il lettore vi potrà scorgere, a dispetto di qualche impressione momentanea, una coerenza tonale nell’istruttoria e nel giudizio delle cause, lievi cause: quella coerenza che al secol nostro si usò chiamare una linea. Il guaio è che la linea del Gadda, le più volte, s’impenna e diverge dalle linee più accreditate». I saggi raccolti abbracciano un periodo di 30 anni: dal solariano I viaggi, la morte (1927) a Il pasticciaccio del ’57. I primi sei, Come lavoro (1949), Meditazione breve circa il dire e il fare (1936), Psicanalisi e letteratura (1946), Tecnica e poesia (1940), Le belle lettere e i contributi espressivi delle tecniche (1929), Lingua letteraria e lingua dell’uso (1942), assieme al penultimo, il bellissimo Emilio e Narcisso del ’49, sono uno dei più straordinari esempi novecenteschi di prosa d’invenzione e di pensiero ad un tempo.
d) Quer pasticciaccio brutto de via Merulana [1a ed. parziale a puntate in cinque numeri della rivista Letteratura da gennaio-febbraio a novembre-dicembre 1946; 1a edizione in volume – ma di una nuova redazione – Milano: Garzanti («Romanzi moderni»), 1953], ora in RR II 11-276. Il giallo come strumento di apprensione totale del mondo e delle anime, e nella sua incompiutezza il fallimento della quête davanti alla sfuggente complessità e insondabilità dell’oggetto d’indagine. Vi si trovano gli esempi più rivoluzionari di sintassi narrativa (e sintassi tout court) che rompe gli schemi tradizionali frantumandosi in spezzoni emotivi.
e) tre racconti confluiti poi negli Accoppiamenti giudiziosi [1a edizione Milano: Garzanti («Racconti Moderni»), 1963], ed ora leggibili in RR II 643-97, 699-713 e 891-920; vale a dire:
e1) San Giorgio in casa Brocchi, originariamente pubblicato in Solaria 6, no. 6 (1931): 1-49, e poi ripreso con varianti nella prima incarnazione degli Accoppiamenti, le Novelle dal Ducato in fiamme, Firenze: Vallecchi, 1953. In una lettera a Tecchi del 7 maggio 1931 Gadda (cito dalla Nota al testo di R. Rodondi, RR II 1279)
ne schizza sinteticamente profilo e intenzioni: «è una satira dell’ossessione conservatrice e moralistica di una famiglia signorile milanese. Contro questa ossessione congiurano tutti gli accidenti possibili dei “tempi perversi” – e cioè le serve, i medici di casa, un pittore, l’esposizione dei Novecentisti, gli studenti del politecnico, ecc. – e soprattutto la crisi puberale di Gigi (il rampollo di famiglia) che finisce per entrare nella virilità proprio il giorno di S. Giorgio, suo compleanno.
Vi è una lotta simbolica fra S. Giorgio, il Santo cavalleresco e… femminista, contro S. Luigi Gonzaga, il Santo ascetico e rinunciatario. Ecc.»
e2) L’incendio di via Keplero, comparso come Studio 128 per l’apertura del racconto inedito: L’incendio ecc. ne Il Tesoretto. Almanacco delle lettere e delle arti (Milano: Primi Piani, 1940), 58-72; uno studio, vale a dire nell’accezione gaddiana, un tentativo, un frammento di un tutto costruito per blocchi – qui, iperbolicamente, il blocco 128. L’incendio, di una casa popolare nella milanese via Keplero, permette l’assonometria rappresentativa, caso dopo caso (cinque in tutto) del Pandaemonion che nella casa si concentra.
e3) Accoppiamenti giudiziosi, uscito in cinque puntate di Palatina tra il ’57 e il ’58. «Si tratta – spiega Gadda in una lettera del ’56 a Garzanti [cfr. la Nota al testo di R. Rodondi in RR II 1289] – di un lungo racconto o meglio dell’antefatto di un Soggetto Cinematografico […] riguardante una serie di matrimonî “combinati”, durante 2-3 generazioni, in vista della salvazione della “Sostanza” di famiglia». Il racconto si conclude con una felicissima antianalisi prima grammaticale e poi distruttivamente alogica, un puro gioco coi suoni, dei versi iniziali dei Sepolcri foscoliani.
La bibliografia gaddiana – il singolare constata unicità e qualità – è quella (cresciuta da una edizione alla successiva delle Bizze adelphiane) curata da Dante Isella: ora, nella versione più estesa nel secondo tomo del quinto volume delle Opere: BI 9-67. La letteratura critica su Gadda, ampia, è di valore diseguale. Il volume capitale rimane, anni dopo la prima pubblicazione nel ’69, Roscioni 1995a, citato a n. 4. Ad esso si aggiungeranno gli interventi continiani, preziosi tutti, anche se a volte per forza di cose essi parzialmente si sovrappongono, raccolti in Contini 1989, e le Introduzioni e Note al testo di Dante Isella alle sue numerose edizioni di inediti o raccolte gaddiane (in particolare la Prefazione al Racconto italiano di ignoto del novecento: Gadda 1983a: v-xxvii).
Université de GenèveNote
1. Cfr. Montaigne, EssaisIII, 5 (in un passo che sembra prefigurare la poetica gaddiana dell’impiego spastico della lingua): «Le maniement et emploite des beaux espris donne pris à la langue, non pas l’innovant tant comme la remplissant de plus vigoreux et divers services, l’estirant et ployant. Il n’y aportent point des mots, mais ils enrichissent les leurs, appesantissent et enfoncent leur signification et leur usage, luy aprenent des mouvements inaccoustumés, mais prudemment et ingenieusement».
2. I cui «lenes […] sub noctem susurri», ad esempio, sono in Gadda accordo ricorrente nella rappresentazione dell’intimità amorosa (cfr. MdF RR I 81 – «per entro l’ombre i convegni furtivi ed i rapidi baci ne’ vicoletti e le strette, ed i lievi sussurri, se cada la notte: “lenesque ecc.”», e L’A RR I 292 – «interrompendo ogni parola o gioco o passo o tardo pensiero: o un susurro, che forse la notte avrebbe conceduto di prorogare» (RR I 292 n.1, ancora «sub noctem»).
3. Sono espressioni della Meditazione milanese: Gadda 1974a: 289 e 79 (intensificata, la prima, dal qualificativo monstruoso).
4. Gadda 1974a: 99, cit. in Roscioni 1995a: 17. Nel suo contesto la citazione suona così: «io dico: il dato o realtà è una pausa della deformazione in atto, operantesi come correzione (sic) o introduzione di relazioni sempre diverse. Il dato è per gli altri uno stacco sicuro dalla terra ferma, una predella ferma per spiccare un bel salto. Per me è lo stacco da una tolda traballante (bateau ivre): o una predella già essa moventesi. | Conoscere significa deformare».
5. Si veda ad esempio Roscioni 1995a: 4.
6. Un oggetto basso che sigla – come i dettagli ricorrenti di certi pittori – molta della invenzione gaddiana: si pensi all’Incendio di via Keplero (RR II 706): «pitali di ferro smaltato ripieni di carote buttati giù di finestra», alla Madonna dei Filosofi (RR I 81): «mezzo intontito dentro la mota, si discerneva bene un recipiente pariniano [cfr. La salubrità dell’aria, v. 98], ma di consistenza novecentesca, e cioè di ferro smaltato, rugginoso e sfondato», o alla Casa (RR II 1115 e 1118): «una capace e pariniana creta ecc.».
7. La pagina è ampiamente discussa in apertura di Roscioni 1995a: 4-5, e quindi, da un punto di vista complementare, nel capitolo conclusivo (La visée réaliste et la dynamique autonome de l’écriture: l’exemplaire description des bijoux) di Fratnik 1990.
8. Diversa la lezione (anteriore) della Meccanica in RR II 472: «con tra mano un rugginoso coltello dal defunto manico a rimestar dentro vasi o cassette di probabili rosmarini e garofani». Se non che l’apparato critico di RR II (1211) mostra i rosmarini essere correzione – dell’originario lattughe – successivamente annullata forse perché incompatibile appunto con l’aggettivo probabili.
9. Da QP RR II 230-31.
10. Le parole «durano quel che durano: un decennio, un cinquantennio, due secoli, otto secoli. Mutano di significato col costume, col variare delle lune, con il lento o con il rapido consumarsi del tempo: e mutano talora di valore, di peso. La loro storia, che è la pazza istoria degli uomini, ci illustra i significati di ognuna: quattro, o dodici, o ventitré: le sfumature, le minime variazioni di valore: in altri termini il loro differenziale semàntico» (VM SGF I 437).
11. Si cita, qui e nel séguito, da Gadda 1987a (qui p. 301).
12. La forma in -ere della terza persona plurale è una caratteristica arcaica e periferica del latino, che appunto lo apparenta, dicono i glottologi, all’ittita, al tocarico e all’indoiranico.
13. Cfr. in Gadda 1987a il commento al passo citato, con la battuta dell’Autore: «Già, forse sarebbe più logico dire dans le panier».
14. Nella misura in cui questo non discenda dalla contaminazione nella memoria col precedente «a contanti» del paragrafo manzoniano.
15. Vanno ricordate in particolare le dissacranti citazioni o allusioni al modello manzoniano: si pensi – in corrispondenza all’apertura dei Promessi Sposi «il Resegone […]: talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano che guardano a settentrione, ecc.»– a L’A RR I 551-52: «certi licheni verdastri, o nerastri, insistevano invece a incrostargli quell’altra falce, tra le due natiche, d’una scandalosa flora criptogamica. Le natiche in parola erano “rivolte a settentrione”, come le mura di Porta Nuova nei Promessi Sposi. Donde quelle muffe»; o a Gadda 1987a: 399-400: «dall’animo tenuemente rattristato sarebbero potuti venire alle labbra quei detti, dell’immortale preludio de’ Promessi Sposi: “Talché non è chi, al primo vederlo (il Serruchón) purché sia di fronte, come per esempio, di su le mura di Pastrufazio che guardano a settentrione ecc.”» e agli altri luoghi indicati ivi in nota. Un caso meno noto è quello della «invereconda porpora» di una delle Favole, che, detta del boleto «tutto ritto e scarlatto», è brutale contrappasso alla «casta porpora» fiorita nella Pentecoste (v. 131) sul viso delle donzelle.
16. Nel passo espunto, Gadda allude caricaturalmente ai risultati della propria scrittura – di cui tuttavia rivendica subito dopo il carattere meditato: «Sfocia talora, presso alcuno, codesto arbitrio, ad orribili torsioni: a contaminazioni intollerabili. (Procedo però guardingo: sulle parole mi si consuma l’ora e tutta la vigilia, più che labile moccolo)».
17. Qui parodistico è da intendere nella accezione bachtiniana di automaticamente allusivo alla parola d’altri: di gruppi, classi sociali, ecc.
18. Laus vitae, v. 7932: «l’odor del cefisio narcisso».
19. Vocabolario universale italiano (Napoli: compilato a cura della Società Tipografica Tramater e C.i, 1829-40), e con giunte e correzioni (Mantova: F.lli Negretti, 1845-56).
20. Si veda (ricordato che la coppia rose e gigli – Maria e gli Apostoli – è in primo luogo dantesca: Purg. XXII, 73-75), Orlando Furioso VII, 11 (la descrizione di Alcina): «Spargeasi per la guancia delicata | misto color di rose e di ligustri», 28 (ancora Alcina): «[…] e restò il vel suttile e rado, | che non copria dinanzi né di dietro, | più che le rose o i gigli un chiaro vetro» e X, 95 e 96 («Angelica legata al nudo sasso»): «Un velo non ha pure, in che richiuda | i bianchi gigli e le vermiglie rose», «[…] la lacrima distinta | tra fresche rose e candidi ligustri, | far rugiadose le crudette pome».
21. è lo scurirsi della prima barba: Orazio, nel carme cit., ha «insperata […] pluma», reso da Gadda (SGF I 644), non immemore credo di un caliga dantesco, con «non attesa calugine».
22. Ma in fasi precedenti dell’italiano nomi propri e cognomi potevano effettivamente essere formati con -esc-: si pensi a Francesco, Grimaldesco, e a Palazzeschi o Guareschi.
23. Il sintagma – SGF I 650 – sembra calcato sul modello del «figlio giovinetto» di una notissima scolasticamente, e più volte citata da Gadda, lirica del Giusti.
24. Si vedano appunto I gigli, nella Chimera, vv.8-14: «Ma i gigli […] | […] | […], i gigli, i gigli, a quando a quando, || alti e soli risplendere ne l’ombra | vede la moribonda anima mia, | sé ne la voluttà riprofondando», e i rimandi alla diffusione dell’ambiguo motivo del giglio nel commento di A. Andreoli & N. Lorenzini all’edizione dei «Meridiani» Mondadori. Ma cfr. anche in QP RR II 197 la reinterpretazione erotica della verga fiorita dello Sposalizio della Vergine (usualmente presente, sulla scorta del Protovangelo di Giacomo, IX, 2, nella iconografia di San Giuseppe): «E risponde [il «dito mastro», l’alluce], fatto augusto dalla divaricazione, risponde all’estasi alta ed eretta del sottile stelo o bàculo che nottetempo ebbe fioritura bianca di tre gigli, anziché del consueto garofano».
25. è difficile non sentire qui una traccia del Faune di Mallarmé (contigui ad Emilio e Narcisso – che è del ’49 – sono il saggio di Contini Sulle trasformazioni dell’«Après-midi» ecc. apparso nell’Immagine dell’agosto-dicembre ’48, e, dello stesso anno, la traduzione ungarettiana del Faune nel volume Da Gongora a Mallarmé), che si risveglierà «Droit et seul, sous un flot antique de lumière, | Lys!»), preda di un désir torride.
26. Ma anche di «tant’altri Lancellotti […] di eccellente lanza» (SGF I 949).
27. L’amour en visites, VII Chez le médecin (Jarry vi riprende, a volte letteralmente, i gigli del Faune). In una scena di ironico parossismo il giglio – «au pistil inquiétant» – è espressamente equiparato al narciso mitologico: «Le lis […] se tourna dans tous les sens […] et fini par s’arracher lui-même de sa tige; s’éparpilla, pétales à pétales, perles de rosée à perles de rosée, se mourut de langueur comme un simple narcisse au bord de la fontaine, et demeura flétri».
28. RR II 192-94 – sogno sognato da un brigadiere Pestalozzi in Motoguzzi e in cui è Z-sacerdotessa (zeta come Zoccolaccia: RR II 201) – assente il Zignore (RR II 169) – una Circe-Zamira («Pàcori Zamira. Zamira! Zeta come Zara, a come Ancona! Zamìra!… sì, sì, Zamìra», RR II 140), circondata nella sua realtà di carzonara eccetera, oltre che da un coro di ragazzee da galline zozzone, da topazzi-sorconi «lunghi mezzo braccio» (RR II 151).
29. La prima volta, in QP, a proposito di altro topazio, smarrito da una proprietaria svampita (una mezza pazza) dal nome predestinante per consonanza: «un anello con un topazzio o topazzo (quarcuna, sempre pe rispetto, pronunziava topaccio), che la Menegazzi o per più pulito dire Menecacci aveva dimenticato al cesso, unicamente perché era un’oca vanesia e le era svaporato il cervello ecc.» (QP RR II 51-52).
31. L’idea di «istinto della combinazione» è già ampiamente presente in RI – cfr. Lucchini 1988a.
32. Cfr. Roscioni 1995a: 34, dove è questione della «vibrazione affettiva», della «nota di meraviglia o di orrore» che spesso inerisce alla scrittura gaddiana.
33. Per una interpretazione si vedrà l’annotazione di cui è provvisto Gadda 1987a, e i luoghi di Roscioni 1995a a cui in essa si rimanda.
34. Fescennio, da intendere come fescennino (canto satirico di mordace licenziosità, d’origine agreste) e (fabula) atellana (cfr. appena sopra nel passo citato la favola), id est l’antica rappresentazione farsesca, di spinta e sboccata comicità, e dai frizzi pungenti, valgono qui per le spontanee manifestazioni giocose, grottesche, demistificanti, dell’animo popolare. In VM SGF I 495, Gadda attribuisce significativamente alla propria scrittura «la bozza macaronica, […] la tumescenza barocca. La gromma fescennina».
35. è termine di sapore pascoliano: l’«arnese di ferro, adunco e tagliente, fatto per uso de’ potatori» (così il Passerini nel suo vocabolarietto).
36. Cfr. anche Gadda 1987a: 353-54: «Le figurazioni non valide erano da negare e da respingere, come specie falsa di denaro. Così l’agricoltore, il giardiniere sagace mondano la bella pianta dalle sue foglie intristite, o ne spiccano acerbamente il frutto, quello che sia venuto mencio o vizzo al dispregio della circostante natura».
37. Così come in AG RR II 826 «la […] spada fiammeggiante, che scaccia di paradiso l’Adamo», l’articolo ravviva l’etimologia: ebr. adham = uomo. Qui, in particolare, anche per alludere alla umanità senza impacci dei peones della Cognizione.
38. Evidente ad esempio nel terzo capoverso – «Scacazzamento della mandra» – di una lettera agli amici milanesi in Gadda 1983c: 5-6.
39. Si ricorderanno le considerazioni di § 2.2 sul valore di pervenire.
40. Distinguo tra spunto tematico [= classe di temi, denominatore comune di più temi], individuato ad esempio da una designazione di entità – le nuvole – o da una nominalizzazione – il sorgere (cumularsi) delle nuvole – e tema, più concreto, più determinato rispetto allo spunto tematico, e usualmente rappresentato da una proposizione (cfr. sotto la prima frase di (d)). Va da sé che la distinzione è relativa, che cioè uno spunto tematico (contenente una proposizione) può essere tema rispetto ad una astrazione di grado più elevato.
41. Cfr. ad es., in Alcyone, L’oleandro, vv. 190-91 «[…] i grandi miti | come le nubi sorgere dall’Alpe».
42. Cfr. le annotazioni di Gian Carlo Roscioni in Gadda 1974a: 309, e gli altri luoghi ivi indicati.
43. «Il cucùlo: nella solitudine della campagna remoto singhiozzo» (cfr. l’Appendice a Gadda 1990a: 211, e l’annotazione relativa alle pp. 217-18). Per una storia del canto del cuculo si vedrà Gadda 1987a: 421-22, rr. 707-13 n. Ivi in particolare l’indicazione di una possibile ascendenza pascoliana (Mezzanotte e L’Assiuol0, in Myricae).
44. Qui e nei passi che seguono le parentesi uncinate isolano le aggiunte, interlineari o in rigo. In corsivo sono le varianti abbandonate, la freccia indicando il passaggio dall’una all’altra. Infine, la losanga – come in (c), ad es. – serve a segnalare quando vi siano dubbi il punto di attacco della variante in quanto precede, e le parentesi quadre accolgono ulteriori dettagli variantistici.
45. L’autore, come è stato osservato dalla critica, è sensibile ai geometrismi di volumi e piani; qui, in particolare alla regolarità del pattern luce-ombra (una poesia giovanile della primavera del ’19 – riprodotta nel giugno 1967 (Gadda 1967c; ora SGF II 884-85) – si apre con «Piani di sole e liste | d’ombra», anche se l’immagine è riferita, credo, ad effetti di luce sulla facciata di una casa). Da non trascurare comunque è l’oltranza simbolica del tema delle «trasvolanti nubi di tristezza» (QP RR II 26), che trova rispondenza in una comparazione schopenhaueriana: «il presente è come una piccola nuvola scura, che il vento spinge sulla pianura soleggiata: davanti e dietro tutto è chiaro, solo quella nuvola getta sempre un’ombra» (Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di A. Vigliani (Milano: Mondadori, 1989), Supp. al IV libro, cap. 46, Della vanità e dei dolori della vita, 1487).
46. La stessa sincronizzazione appare (probabilmente in conseguenza della attuale elaborazione) in apertura del secondo tratto della Cognizione (Gadda 1987a: 111-12): «Al passar della nuvola, il carpino tacque [vale a dire, l’ombra spegne il canto delle cicale solari; nella prima versione: «Nell’intermettere della cicala, trasvolando la nùvola, si tacitò il carpino»]. È compagno all’olmo […]. La robinia tacque, senza nobiltà di carme ecc.».
47. «Morulazione (t. tecn.) è nella biogènesi il processo de’ consecutivi sdoppiamenti d’una cellula fecondata. Da una due, da due quattro, ecc. ecc. È una fase dello sviluppo del feto. I nùvoli d’incenso o di fumo vengono a “morularsi” in quanto un globo ne dà due, i due ne dàn quattro, ecc. ecc. (Fumo delle ciminiere, neri incendi de’ pozzi petroliferi). Etimologicamente da mora, ch’è una sorta di frutto: (p.e. del gelso)». Un impiego ancora anteriore del termine è nell’inedita Villa in Brianza, f. 18v (cit. nel commento di Gadda 1987a: 260, r. 50) «Nuvole strane trasvolavano nel torrido cielo, da Bergamo sopra l’Albenza […]. I cumuli enormi si morulavano, come a simboleggiare future tempeste» [ora Gadda 2001a: 28-29, N.d.C.].
48. La ripetizione a breve distanza del verbo venire («venivano dai silenzi» – «venutegli [= al protagonista] dalla remota scaturigine della campagna») attesta di nuovo, in un autore come Gadda, la difficoltà della elaborazione.
49. Le «due note» sono «ritenute e profonde, come la cognizione del dolore».
50. Si conserva qui per il milanese di Vuôei e baüsciòn la lezione non normalizzata della princeps garzantiana (Milano, 1963) di AG.
51. L’Incendio (sulla cui storia esterna cfr. RR II 1280 e 1332 n.17) consta di tre paragrafi iniziali d’inquadramento e di una parte centrale articolata in una serie di casi a funzione illustrativa, il secondo caso essendo separato dal primo ancora da un paragrafo descrittivo. I casi, esauriti l’uno dopo l’altro senza sovrapposizioni, e bipartiti all’interno (grave pericolo + salvataggio), sono ordinati, secondo un criterio di gravità crescente, sino al tragico risolto maccheronicamente del penultimo e all’esito ferale dell’ultimo. Linguisticamente sono operanti i modelli di due tipi di discorso: la prosa giornalistica dei fatti di cronaca (con voluta goffaggine degli incipit: cfr. il secondo: «Una donna incinta, altro caso pietosissimo», il quarto: «E anche un altro poveraccio, il vecchio Zavattari, la scampò per un pelo» e il quinto: «Penosissimo, e purtroppo ferale, il caso del cavalier Carlo Garbagnati») e la narrazione popolare col divagare tematico delle sue libere associazioni. La situazione rappresentativa, tipicamente gaddiana, è quella delle prime pagine di QP, con il concentrato di realtà di un palazzo a svelarsi ad un commentante pubblico di spettatori. Di più, qui, vi è l’utilizzazione teatrale delle scale, che non è senza richiamare soluzioni classiche, quali l’ottocentesca del dickensiano Wilkie Collins in apertura di No name: «Who were the sleepers hidden in the upper regions? Let the house reveal its own secrets; and, one by one, as they descend the stairs from their beds, let the sleepers disclose themselves» (cito, con corsivo ovviamente mio, dalla edizione newyorkese di Harper & Brothers, 1873, p. 11).
52. Una situazione analoga è in Vittorio Imbriani, Il vero motivo delle dimissioni volontarie del Capitano Cuzzocrea (Trani: Fusco, 1877), ma cito dai «Classici» UTET, Narratori meridionali dell’800, 105: «Un bel pappagallo, appollajato sur una gruccia davanti alla finestra del burò, atterrito dall’urlo e da quei rantoli affannosi, avea tentato di fuggire volando: e, trattenuto dalla catena, penzolava giù, dimenando le ali, starnazzando e squittendo ridicolo e miserabilmente». Il confronto riconferma ad abundantiam il divario incommensurabile rispetto alla elaborazione sintattica e concettuale della immagine gaddiana.
53. Si vedano ad esempio le molte localizzazioni: «dal seggiolone», «dall’altro capo della tavola», «di strada», ecc.
54. La coppia oppositiva saturnino/dionisiaco è notoriamente della Cognizione.
55. Le altre edizioni commentate sin qui disponibili di opere gaddiane sono la già citata Meditazione milanese (Gadda 1974a), e il Primo libro delle Favole (Gadda 1990a). Annotazioni più o meno estese e utili sono nei volumi disponibili dell’epistolario gaddiano, in cui eccelle per qualità dei materiali e del tessuto connettivo la sezione continiana: Gadda 1988b. In francese pregevoli le note del traduttore (Giovanni Clerico) alla stampa presso l’editore Bourgois di Eros e Priapo.
56. Il Racconto italiano di ignoto del novecento, edito da D. Isella nel 1983 nella collana «Einaudi Letteratura» (Gadda 1983a).
Published by The Edinburgh Journal of Gadda Studies (EJGS)
ISSN 1476-9859
ISBN 1-904371-16-7
© 2007-2026 by Emilio Manzotti & EJGS Manzotti Archive. First archived in EJGS (EJGS 5/2007), Supplement no. 5. Previously published in E. Manzotti (ed.), Le ragioni del dolore. Carlo Emilio Gadda 1893-1993 (Lugano: Edizioni Cenobio, 1993), 17-50.
Artwork © 2007-2026 by G. & F. Pedriali. Framed image: A Cabinet of Curiosities (Wunderkammern) – detail from an illustration in V. Levinus, Wondertooneel der natuur, tome II (1715), Strasbourg University.
The digitisation and editing of EJGS Supplement no. 5 were made possible thanks to the generous financial support of the School of Languages, Literatures and Cultures, University of Edinburgh.
All EJGS hyperlinks are the responsibility of the Chair of the Board of Editors.
EJGS is a member of CELJ, The Council of Editors of Learned Journals. EJGS may not be printed, forwarded, or otherwise distributed for any reasons other than personal use.
Dynamically-generated word count for this file is 17566 words, the equivalent of 51 pages in print.


